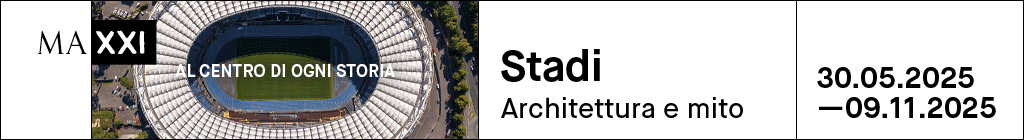Esposizioni universali vs internazionali vs nazionalismi
Le Esposizioni universali sono sempre state esempi unici di come un luogo si produce, con uno scambio tra quanto è effimero e l’eredità che in questo caso l’Esposizione lascia. Le Esposizioni parigine hanno mutato tra 1854 e 1900 l’assetto di quella zona di Parigi che oggi va dal Grand Palais alla collina di Chaillot. Zona umida e malsana a metà Ottocento, è diventata con gli anni il quartiere dei musei: destinazione sancita ancora in anni recenti con la costruzione del museo del quai de Branly. A Chicago, l’Esposizione colombiana ha mutato radicalmente il rapporto tra la città e il lago Michigan con la costruzione del Jackson Park, che umanizzza il rapporto tra la prima black city americana e l’acqua, la quale peraltro già delimita il quartiere dei grattacieli (il loop).
Ma le eredità immateriali, per fare il verso ai patrimoni immateriali dell’Umanità, sono per le Esposizioni ben più ricche ed estese, a iniziare dalla discussione sul sintagma che le connota: Esposizioni “Universali” o “Internazionali”? Sin da Londra 1851, la prima Esposizione, quella del Crystal Palace, per decenni l’incipit della modenità, lo slittamento sematico da Great a International, a Universal, segna, persino nei documenti ufficiali dell’esposizione londinese, la coscienza del programma che si vuole proporre. Nel cuore della disputa tra nazionalismi e internazionalismi, negli anni in cui si forma la radice conservatrice e identitaria della nazione e le si contrappone un internazionalismo di appartenza (sociale, professionale, artisitica), gli organizzatori alla fine scelgono l’universalismo. Non è solo – e si dice poco – una questione nominalistica: precisa con i valori che si vogliono promuovere l’obiettivo che l’Esposizione si propone. Non a caso quelle Esposizioni, almeno sino al 1900, saranno la messa in scena – certo conflittuale e tutt’altro che rassicurante – del progresso.
Un conflito e una contradidzione che hanno un prologo quasi troppo emblematico. La scelta pacifista dell’Esposizione del 1851 – non bisogna dimenticare che vien dopo i moti del 1848 – viene violata dalla Krupp. La grande industria tedesca vuole portare a Londra il più grande cannone mai prodotto. La sfida sulla misura sarà peraltro una costante delle Esposizioni: la contesa sulla più grande, visitata, innovativa, artistica… farà correre (e fa correre oggi a Milano) fiumi di retoriche. Ma gli dei delle Esposizioni, volendo prendere il tema con un po’ di leggerezza, non vollero che quel cannone arrivasse: e una tempesta lo fece sprofondare nelle acque della Manica, sostituito da uno più innocuo e meno enfatico, parente lontano della famosa Berta che poi sparerà sulla Comune parigina nel 1870. Ma la distinzione tra Internazionale e Universale rimarrà in tutta la storia delle Esposizioni. Universale riemergerà, dopo un’eclisse durata sino alla seconda guerra mondiale, con le Esposizioni di Bruxelles e Montréal, non a caso le più intriganti Esposizioni di quel dopoguerra che voleva fondarsi proprio su un nuovo patto sociale e su nuovi valori universali che la pace avrebbe garantito.
Milano 2015: un tema davvero universale
Il tema dell’Expo di Milano in questa chiave non poteva essere più universale. L’alimentazione è, come racconta con una spazialità vuota che un po’ intimorisce, il Padiglione zero dell’Expo milanese, un tema radicalmente universalista. L’universalità non è solo nei bisogni e nelle contraddizioni che oggi un bene comunque limitato e perciò indisponibile a una crescita indiscriminata comporta, ma nella sua storia. Una storia raccontata forse con un po’ troppa consolazione in questa Expo. La lotta per l’acqua o per il terreno fertile accompagna la storia stessa dell’umanità, delle sue tecniche, dei suoi successi e delle guerre che, ancora oggi, accompagnano l’alimentazione: e i fantasmi della scarsità sono inesorabilmente legati alla costituzionale limitatezza dei prodotti della terra, perché è la terra a essere limitata in primo luogo.
Il Decumano e i padiglioni
Non è certo un’Esposizione il luogo dove si possono rappresentare i pericoli di quella che un grande giurista conservatore, Carl Schmitt, chiama tirannia dei valori. Ma certo qualche attenzione in più, non solo nei dibattiti, o nell’esaltazione come autentico kharma della sostenibilità, che è scelta legata al limite della crescita – lo diceva già il Club di Roma nel 1974, non certo qualche fondamentalistia ambientale – avrebbe giovato al lungo boulevard che è l’espediente narrativo, purtroppo incompiuto ma più azzeccato, dell’intera Expo. È inutile qui ripercorrere il tormentato iter del progetto urbanisitico, le ragioni per le quali, con un’intuizione che univa storia, valori ed eredità, il boulevard doveva essere accompagnato dalla rigenerazione della rete di canali che una volta segnava il paesaggio (e l’economia) attorno e dentro Milano. Oggi si percorre quest’asse sul quale si affanciano i padiglioni o le strade che portano agli altri, rendendo possibile uno skyline dell’Expo che negli ultimi decenni non era mai stato possibile. Uno skyline che dice cosa? Certo gli occhi di chi vede sono assai differenziati, ancor più in fenomeni di massa come le Esposizioni. Rimanendo allla distinzione abbozzata, certo si coglie un internazionalismo venato da teneri o ingenui regionalismi, quello che le architetture disegnano: un internazionalismo delle tecniche più ancora che delle forme. In rari casi – il Brasile ad esempio – la tecnica diventa protagonista assoluta, in quasi tutti gli altri è il supporto evidente a bizzarrie formali che sono la cifra attuale più ricorrente dell’architettura contemporanea.
Un internazionalismo nascosto da dune, pagode, citazioni degli anni venti, analogie elementari (la tenda come il tunnel della conoscenza…), che rispecchia così un altro paradosso di oggi: la rigidità delle strutture costruttive e l’assenza di codici per le forme. È una passeggiata che non a caso affascina e registra code di persone in attesa praticamente per ogni padiglione. Il boulevard dell’Expo è un bagno, assai concentrato, nella città che scambia i suoi immaginari con i luoghi, come avviene ormai in piazza Gae Aulenti a Milano, dove chi la abita può pensare di essere a Pechino come a San Francisco. Solo che all’Expo la passeggiata coinvolge le rappresentazioni delle identità nazionali, ribadendo la fragilità e in molti casi la banalità di identità locali tradotte in simbologie evocative. Ma il successo indubbio di pubblico deve indurre una riflessione sulla cultura di massa oggi, non negli anni sessanta. All’Expo non ci si trova in pieno kitsch ma in piena consunzione dei simboli, in un vero cannibalismo di segni, evocazioni, citazioni.
Il Padiglione Italia: una meringata di cemento armato
L’esempio più sconfortante è in questo senso il Padiglione Italia. Collocato su cardo dell’Expo, in prossimità del simbolo della stessa, non a caso l’albero della vita, il padiglione italiano è una meringata di cemento armato, attraversata da percorsi improbabili e faticosi, con spazi vuoti solo retorici. Non esiste, nel padiglione, neanche la ricerca di un’identità. E’ un goffo modo di evocare l’elogio della tecnica – non senza un’ironia del tutto involontaria sul cemento – e un’artisticità ricondotta a un maquillage di forme improbabili. Padiglione che peraltro accompagna padiglioni regionali che fanno rimpiangere quelli di Italia 61 a Torino.
I contenuti e lo slittamento del tema: dall’alimentazione al cibo
Il rapporto tra un universo progettuale e costruttivo, specchio impietoso di una crisi poetica e ideologica assieme, e i contenuti, evidenzia uno slittamento del tema – dall’alimentazione al cibo – che spiega anche la presenza, un po’ fastidiosa, di marchi dell’alimentazione industrializzata lungo tutto il percorso del boulevard. Anche in questo caso è un realismo più realista di quello sovietico degli anni cinquanta: la presenza capillare di marchi è lo specchio fedele delle nostre città, finendo con il far piombare il visitatore in un iperrealismo dai toni quasi involontariamente ironici. L’avventura delle Expo è ricondotta allora al suo contrario, al non sentirsi spaesati, al concentrarsi di emozioni e sensazioni della vita quotidiana nelle metropoli, al “gustarsi” in un unico spazio iperurbano anche lui, gusti che sarebbe impossibile riunificare in qualsiasi metropoli del mondo.
Il gusto come si sa è un gran tema dell’estetica settecentesca, ripreso e ribaltato più volte in tre secoli. A Milano il gusto torna a essere il centro di un’estetica e non di un’etica. Ed è forse il limite più rilevante di un’Expo che peraltro incontra il piacere di tanti, mettendo in crisi facili giudizi, spesso, ahimé, espressi senza aver vissuto anche solo due ore dentro il fiume umano che percorre il boulevard. Il Novecento ci ha insegnato troppe volte a dubitare delle folle, ma anche a dubitare di chi costruisce il suo giudizio su voci, retoriche, boatos. L’immersione è sconcertante, anche perché manca anche nella folla la sorpresa, che è stata l’estetica di fondo delle Esposizioni universali.
L’eredità
Internazionale, urbana, iperrealista, rassicurante: questa è l’Expo di Milano. Forse ci vorrebbe Duan Henson per raccontare questa Expo, per spiegarci che anche lo slitttamento da alimentazione a cibo è interna a rappresentazioni in cui la rassicurazione e l’eliminazione del conflitto – che nella ricchissima California di oggi vede confliggere persone e interessi sull’uso dell’acqua – sono necessari per convivere con paure, competizioni, traumi. Traumi che proprio uno dei grandi temi che l’Expo contiene e sviluppa poco, il rapporto tra alimentazione e mutamenti climatici, esapera ed esaspererà. Se la terra è un bene limitato, la sua desertificazione forse spiega la bulimia nevrotica e ossessiva che fa entrare il visitatore in un continuo riporto fotografico di immagini del benessere alimentare. Per ritrovarsi poi a misurarsi con un altro realismo: quello della nuova economia agricola e montana che sta portando a ripercorrere all’indietro strade battute nella direzione opposta da milioni di montanari e contadini inurbati nel Novecento. In filigrana è il messaggio di speranza forse più importante che l’Expo di Milano ci lascia. Più importante, come tutti i processi che nascono dal basso, di carte e accordi che si firmeranno a Milano.
About Author
Tag
expo 2015
Last modified: 9 Ottobre 2015