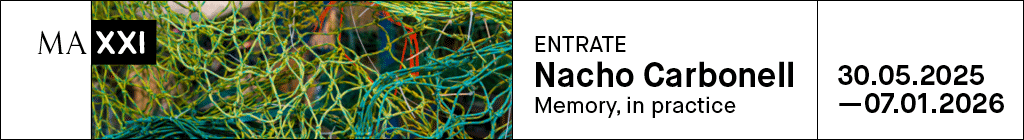Uno sguardo sulla crescente tendenza a coinvolgere le comunità nella riconfigurazione degli spazi pubblici (come da un decennio avviene a New York)
I rigidi processi di progettazione a scala urbana concedono poco spazio per le comunità locali nelle scelte relative alla realizzazione di spazi pubblici. Vediamo così, spesso, spazi magari esteticamente risolti ma vuoti o sottoutilizzati o, peggio, vandalizzati e abbandonati. E, frequentemente, frutto di realizzazioni costose in tempi lunghissimi, con il primo risultato di trasformare spazi urbani in cantieri indefiniti e irritanti per cittadini, imprenditori, turisti. Luoghi poco frequentati che non contribuiscono alla vivibilità dei contesti e ne penalizzano la capacità attrattiva anche in termini d’investimento, di scelte residenziali e di vivacità della rete microeconomica.
Recentemente, la necessità, progettuale e non solo decisionale, di affrontare in maniera diversa la progettazione di spazi pubblici, è emersa con forza, non fosse altro che per il ridimensionamento dei budget disponibili, e con l’obiettivo di renderla maggiormente “partecipata”, grazie al coinvolgimento delle comunità locali. Si tratta, però, di casi ancora sporadici, privi di qualsiasi codificazione a livello normativo. E, forse, si tratta anche di modalità progettuali poco sentite dagli architetti e dalle figure decisionali preposte, tutte concentrate sul momento della progettazione e per nulla preoccupate della fase della gestione.
Un approccio che può essere utile al dibattito in corso e alle singole iniziative in atto nel nostro Paese, riguarda il movimento del placemaking (e del placemanagement), teorizzato a partire dal 1975 dall’associazione newyorkese Project for Public Spaces (Pps) negli Stati Uniti e ora diffuso a livello internazionale e utilizzato da oltre 3.000 comunità locali in 43 nazioni.
Il placemaking è un approccio condiviso alla progettazione degli spazi pubblici per farne il cuore pulsante d’iniziative di rigenerazione di quartieri o città. Nel rafforzare il legame tra le persone e i luoghi che queste condividono, la metodologia del placemaking si concentra sul processo collaborativo fra gli attori pubblici e privati, sia nella fase progettuale che in quella gestionale. Un approccio che rivela la forza che la visione condivisa può avere nel realizzare spazi di qualità, in grado di contribuire al benessere delle persone, sfruttandone le potenzialità: siano essi parchi, centri città, waterfront, piazze, strade, quartieri, mercati, campus o edifici pubblici. Più della semplice promozione di una migliore progettazione urbana, il placemaking facilita modelli creativi di utilizzo, prestando particolare attenzione alle identità fisiche, culturali e sociali che definiscono un luogo e sostengono la sua continua evoluzione. Con interventi spesso più di gestione che semplicemente progettuali. E dai costi contenuti.
Il placemaking non è un’idea nuova. Quando Pps iniziò ad utilizzare il termine a metà anni ’90 per descrivere la propria metodologia di approccio al ridisegno degli spazi pubblici, il pensiero alla base del movimento derivava dall’attività condotta negli anni ’60, fra gli altri, da Jane Jacobs e William H. Whyte, i quali avevano teorizzato la necessità di progettare le città americane per le persone e non solo per le auto o come shopping center. Il loro lavoro si focalizzava sulla necessità sociale e culturale di realizzare quartieri vivibili e spazi pubblici attraenti. A partire dal 1975, questo approccio si è poi concretizzato in un movimento dove l’atto progettuale non è slegato dai bisogni dei fruitori; anzi, mira alla definizione di spazi flessibili che, con poca spesa, possano accogliere gli usi più disparati e soddisfare le necessità degli utenti, sia durante l’arco della giornata che a seconda delle stagioni, diventando il vero motore di alcune aree urbane, oltre che un formidabile punto d’integrazione.
Forse, l’esempio di maggior impatto è la trasformazione avvenuta a New York. Nella metropoli statunitense sono attivi una settantina di distretti del commercio (Business Improvement Districts) che si occupano di trasformare aree della città in luoghi attrattivi per residenti, visitatori e turisti, senza dimenticare gli interessi delle imprese che vi lavorano e dei proprietari immobiliari. Predisporre e, soprattutto, gestire nuovi “luoghi” in maniera condivisa, tramite operazioni culturali, “leggere”, è la chiave del metodo: basti pensare alle 5.000 sedioline verdi di cui è stato dotato Bryant Park, divenute poi il simbolo della riappropriazione degli spazi pubblici della città. Una sfida che negli ultimi dieci anni ha saputo trasformare – a Bryant Park, Hudson River Park, Times Square, Herald Square, Union Square, per citare sono solo alcuni casi – la città “minerale” per eccellenza in un luogo verde e accogliente. Tale esperienza spiega i meccanismi di governance e di compartecipazione finanziaria, anche dei soggetti privati, e le tipologie di servizi che possono ispirare, se opportunamente contestualizzati, i programmi di sviluppo dei distretti e delle città in Italia.
Immagine di copertina: Times Square a New York (foto di Elena Franco)
About Author
Tag
new york , rigenerazione urbana
Last modified: 22 Aprile 2016