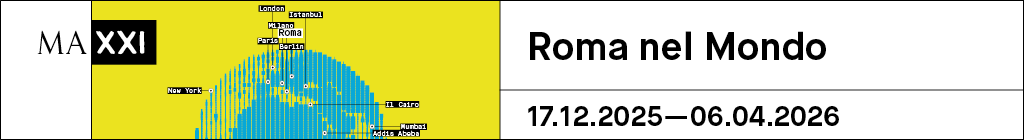Joseph Grima, curatore insieme a Sarah Herda, illustra la prima edizione della Chicago Architecture Biennial, intitolata «The State of the Art of Architecture»
CHICAGO. È la più importante Biennale di architettura del Nord America. Il primo esperimento di questo genere che, come tale, potrebbe diventare un punto di riferimento o finire per essere l’ennesimo evento di architettura. Dal 3 ottobre al 3 gennaio, oltre cento progetti dalle “visioni forti” sono stati selezionati dai curatori Sarah Herda e Joseph Grima e riuniti sotto un titolo ridondante e ambizioso: The State of the Art of Architecture. Degli studi in mostra, soprattutto degli italiani, dell’inevitabile confronto con Venezia e della differenza culturale tra Usa ed Europa ne abbiamo parlato con Grima durante i giorni di apertura.
Dopo aver lavorato diverso tempo a questa prima Biennale, ora che quasi tutti i progetti sono in mostra, è come te l’aspettavi?
Quando hai più di cento progetti è difficile visualizzare tutto insieme. Poi questo [il Chicago Cultural Institute; n.d.r.] è un edificio abbastanza inusuale con spazi inconsueti, di ogni tipo. Adesso per la prima volta lo sto vedendo nel suo complesso ed è un grande piacere vedere tutti i progetti in dialogo tra loro.

Una delle sedi: il Chicago Cultural Center
Quali sono gli obiettivi di questa nuova Biennale sull’architettura?
Bisogna tener conto che, a differenza dell’Europa dove c’è una moltitudine di istituzioni, Biennali e musei, in Nord America non c’era mai stata una mostra su questa scala. Qui esistono eccellenze incredibili nella teoria, nell’ambito accademico, oltre a studi di enorme scala con migliaia di architetti che costruiscono in tutto il mondo. Quello che mancava era un ponte fra queste due cose. Penso che esista una visione relativamente limitata rispetto a quello che l’architettura è, quello che rappresenta e che può essere. Il nostro obiettivo è presentare una visione allargata di quello che l’architettura è oggi, in tutte le sue possibili declinazioni: nel reale costruire come nella dimensione più speculativa ma nella libera immaginazione, più narrativa, più poetica. Mettere tutto questo insieme, in dialogo, senza scegliere un tema preciso.
Come avete selezionato i progettisti in mostra? Si nota una grande varietà, sia di età, sia di approcci di ricerca.
Per noi è stato molto importante non scegliere un ambito particolare o una tipologia di architettura quanto un’attitudine, una visione dell’architettura. Quindi forse l’unico criterio è stato: coraggio, bold vision (una visione forte), la capacità di mettere in dubbio se stessi e quello che si sapeva dell’architettura, curiosità e un’attitudine alla sperimentazione. Questa è una cosa che non ha ambiti geografici o di età ma che accomuna una serie di persone di ogni provenienza, per ogni aspetto dell’architettura.
Sulla base delle vostre indicazioni, come sono state tradotte queste “visioni forti”? In mostra c’è di tutto: progetti realizzati, progetti utopici, installazioni artistiche, film, fotografie. E la cosa più difficile è rendere le mostre di architettura chiare e stimolanti. Sei soddisfatto di come i partecipanti hanno tradotto le loro visioni?
A causa del grande numero di partecipanti non c’è stato un unico processo. Alcuni progetti erano preesistenti e li abbiamo semplicemente portati qui, altri ci sono stati proposti e, in molti casi, abbiamo scelto le persone prima di scegliere i progetti. Volevamo dare uno spazio di sperimentazione a persone che avevano una visione che ci interessava, quindi per tanti di loro la partecipazione è stata annunciata ancora prima di sapere cosa avrebbero fatto in questa Biennale. Questo è un rischio ma c’è anche un alto ritorno potenziale.
Nella conferenza stampa di apertura hai detto che “nessun progetto è troppo piccolo per avere la sua importanza in architettura“. In effetti la maggior parte degli allestimenti racconta questo aspetto. In che modo i progetti, nella loro dimensione ridotta, possono avere un impatto (sociale, ad esempio) rispetto a quelli che riguardano porzioni di città?
É una buona domanda. Qui il rischio è che si crei un playground, un parco giochi in cui le idee sono libere ma l’impatto è trascurabile. Trovare un messaggio rappresentando progetti su grande scala è una cosa molto difficile in un ambito in cui un dialogo precedente non esiste. Si tratta di stabilire prima un dialogo. Questa è la cosa a cui abbiamo dato precedenza, l’idea che è necessario prima di tutto parlare di cosa si intende per architettura. I piccoli progetti in mostra sono capaci di portare all’interno del dibattito pubblico una visione diversa di quello che l’architettura può rappresentare, del suo impatto sulla città. Ovviamente poi c’è il ricambio generazionale; molti dei progettisti sono giovani e una mostra simile può servire per ottenere maggiore visibilità. Ci interessava non essere eccessivamente disciplinari e scientifici ma rappresentare uno sguardo verso il futuro di quello che potrebbe essere un’architettura migliore.
Quale degli allestimenti in mostra meglio interpreta l’operazione che state portando avanti in questa Biennale?
Selezionarne uno o dieci non avrebbe senso. Secondo me ognuno ha impatto nel contesto con gli altri. C’è la categoria dei prototipi di case e abitazioni che è molto forte; poi ci sono i disegni e gli esperimenti di rappresentazioni che sono molto interessanti. É il dialogo tra tutti questi sforzi e tentativi che è interessante.
Con l’Italia hai un rapporto privilegiato: il tuo studio è a Genova. Gli italiani che hai selezionato sono piovenefabi, Yellow office, Stefano Graziani, Baukuh, Stefano Boeri Architetti e Studio Albori. In base a cosa li hai selezionati?
Prima di tutto non abbiamo fatto, a nessun punto, un ragionamento attorno alla nazionalità. Per mie questioni biografiche non riesco a pensare in questi termini, sono inglese ma nato in Francia, vissuto in Italia e negli Stati Uniti. Questa è una cosa che conta pressoché niente nella composizione delle partecipazioni. Per quanto riguarda gli italiani in realtà forse abbiamo agito scegliendo le persone. Il caso di piovenefabi riguarda un concorso in Albania in cui ho partecipato con un team rivale ma ero rimasto colpito dalla loro proposta. Di Baukuh conosco molto bene il lavoro. E comunque il criterio era di avere un’idea forte, una visione forte, un coraggio progettuale che potesse avere risonanza in un dibattito internazionale su certi temi. Stefano Boeri con il suo «Bosco verticale» milanese ha reinventato la tipologia urbana della residenza a torre, registrando un enorme impatto mediatico a livello mondiale.
Hai detto spesso che questa Biennale può competere con i grandi eventi internazionali incentranti sull’architettura. Penso ovviamente alla Biennale di Venezia. Credi di esserci riuscito?
Ho sempre evitato il paragone con Venezia perché è un evento storico impareggiabile. Secondo me Venezia ha avuto un ruolo trasformativo nel modo in cui noi concepiamo le mostre, sia per una questione di spazi sia per la conformazione della città. Andare a Chicago non è la stessa cosa che andare a Venezia, non lo sarà mai. Tuttavia, percepisco un’enorme difficoltà a pensare queste mostre come una sorta di competizione a livello globale.
Sebbene Venezia, essendo un punto di riferimento internazionale, suscita inevitabili confronti…
Farei questo ragionamento. Prima di tutto Chicago non è la prima Biennale dopo Venezia che ha un budget significativo: esistono Guangzhou e San Paolo del Brasile. Tuttavia c’è da dire che gli americani quando decidono di fare una cosa la portano avanti bene. Venezia e altri poli internazionali si troveranno a fare i conti con questo. Bisogna ricordarsi di un periodo, soprattutto negli anni settanta in cui esistevano a Milano due importanti riviste di architettura come «Casabella» e «Domus»: l’ovvia rivalità esistente era positiva per entrambe perché nasceva un dialogo. Nel caso dei grandi eventi internazionali si tratta proprio di un dibattito su determinati temi comuni, perché al contrario la competizione implica invece che uno vinca e domini sull’altro.
Perché una Biennale come questa, alla sua prima edizione, può essere messa in dialogo con Venezia?
Proprio per la storia di questa città che non ha paragoni con nessun’altra al mondo, comprese New York e Venezia. A Chicago è nata l’idea di città e di urbanità come la conosciamo oggi. Non è un evento nato nel Kansas da un’idea astratta di marketing; è qualcosa che costituisce l’ultimo passo di una storia ultrasecolare. Bisogna anche ricordare che la Columbian Exposition del 1893 è l’inizio di questa storia che vede Chicago come luogo di accoglienza internazionale di visitatori per mettere in mostra un’idea di città. Inoltre è una cosa che aumenterà l’impatto di Venezia stessa, in quanto nessuno deciderà di non andare più a Venezia perché c’è Chicago.
Hai lavorato a eventi simili sia in Europa che negli States. Quali sono le differenze nell’organizzazione culturale?
Qui negli States c’è una visione più conservatrice rispetto al passato, sebbene ciò che l’architettura rappresenta sia più finalizzato a una visione utilitaristica. La cosa interessante è che si sta cercando di perseguire, con realtà come ad esempio Storefront a New York, una visione meno accademica e scientifica ma più sperimentale. Adesso Chicago si sta ponendo l’obiettivo di diventare uno dei grandi poli globali del discorso intorno all’architettura. Penso che l’America, anche insieme al Messico e al Canada, stia diventando una realtà interessante. Poi tendenzialmente gli americani quando decidono di fare una cosa la fanno al meglio. Se uno considera che questa è la prima edizione è pazzesco. C’è un’incredibile capacità di produrre e implementare con efficienza una visione. Qui si possono fare cose che altrove risultano più difficili.
Dal tuo punto di vista, su scala globale, dove vedi maggiore vitalità nella ricerca architettonica?
Città del Messico è un punto caldissimo di progetti estremamente interessanti e di studi professionali. Poi Bruxelles e il Belgio in generale e poi, nonostante tutto, Londra. Per quanto riguarda le motivazioni, sinceramente è abbastanza difficile dire perché Città del Messico ha questo impatto sproporzionato. Penso al fatto che è una città con un’abbondanza di spazi a basso costo: cosa che ad esempio la accomuna a Bruxelles. Sono contesti in cui uno studio può prendere dei rischi perché non è esposto a grandi esposizioni economiche.