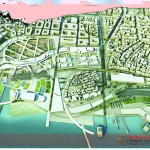Il sito
Un luogo quasi dimenticato, coltivato a orti da sempre, circondato da edifici con storie singolari di abusivismo, ai margini dellhighway che fiancheggia le mura della città bizantina, inserito in un tessuto tanto complesso quanto privo di disegno urbano, in cui è unarchitettura quotidiana ai limiti del paradosso,- come la casa che sarrampica su un piano sfruttando uninesistente parcella fondiaria su quella che dovrà diventare la piazza Aksaray, a definire il paesaggio urbano. È spesso il caso ad accompagnare la storia delle città. Così è per Yenikapi. La costruzione di un nodo intermodale, che dovrà scambiare la ferrovia che sottopassa il Bosforo con il sistema metropolitano, porta a scavare unarea, rimasta per secoli una riserva agricola in ambito urbano.
Lo scavo ne cambia il destino. Vengono progressivamente alla luce reperti e memorie dimenticate o del tutto inattese, come il porto di Teodosio o linsediamento di epoca neolitica, prima forse neanche mai sognato. Ma quel che più colpisce oggi che è ancora possibile visitare un sito archeologico in divenire, è la rilevanza (quantitativa e qualitativa) dei reperti di una vita quotidiana che ci accompagna quasi per mano dal neolitico a uno dei porti più importanti del Mediteranno, tra quarto e sesto secolo dopo Cristo. Non è unarcheologia monumentale a emergere e arricchire di altre perle la già ricca collezione di Istanbul. È, al contrario, una suggestione ben più intensa a emozionare il visitatore: quella di entrare in case, botteghe, navi di epoche tra loro lontane nel tempo. È larcheologia dellabitare a emergere con una forza che certo le navi con i loro carichi o le impronte dei piedi degli abitanti del neolitico enfatizzano ma non esauriscono.
Il concorso
Le scoperte quasi impongono il concorso, che seleziona, su 42 pretendenti, 9 gruppi. Il concorso è un paradigma su cui la cultura architettonica ha costruito dalla sua scuola più famosa (lEcole des Beaux Arts), alla sua capacità di far diventare una trasformazione architettonica o urbana un problema di opinione pubblica: è il caso appunto di Yenikapi. Come tutti i paradigmi, è una cartina da tornasole unica dello stato della cultura chiamata a metterli in pratica. In particolare, due sono i nodi che il concorso enfatizza: il contesto (tra i più difficili che si possano proporre) e la complessità, lo scambio tra mobilità e memoria dove, quasi per paradosso, sono a confronto anche due modelli di mobilità (il porto in epoca bizantina e il nodo intermodale oggi). E sono forse i nodi più critici per una cultura architettonica che ha fatto della globalizzazione una riedizione stanca e ripetitiva della standardizzazione dinizio Novecento.
I progetti
Sette su nove rivelano la difficoltà della cultura architettonica anche solo di porsi il problema del sito. Al di là di retoriche sullascolto, o su altre metafore abusate, i progetti delle star internazionali (Peter Eisenman, Mvrdv, Selgas / Rubio e Cano Pintos), o di grandi professionisti turchi, appoggiati o meno a studi stranieri (Emre Arolat, Tabanlio?glu Architecture, Han Tumertekin e Hashim Sarkis), non denunciano solo la ripetitività (alla base della cultura dello standard) ma anche un rilancio, forse inatteso, dellautonomia dellarchitettura, ancor più del suo disegno. Assieme alla ripetizione vi è una riduzione quasi drammatica della complessità non solo del sito, ma del groviglio di problemi infrastrutturali, di disegno urbano e ambientali che il concorso pone. Emerge un formalismo, anchesso ormai ricorrente, che dalle soluzioni linguistiche si estende a quelle tecniche o tecnologiche e che bene può essere letto, scorrendo le relazioni di progetto, dallabuso quasi scaramantico della sostenibilità chiamata a funzionare come ideologia che copre scelte autoreferenziali. La complessità, nume tutelare di tante semplificazioni che oggi attraversano le culture costruttive, economiche, sociali, qui esplode nelle mani di chi la manovra come pura evocazione, anche solo guardando larea dello scavo.
Lesito
La giuria assegna tre ex aequo. Il che potrebbe aver un senso a fronte di un progetto urbano di questa scala e complessità ma che, purtroppo, rivela, almeno per uno dei vincitori (Eisenman), quanto la pratica di appoggiarsi a gruppi locali, per poi sostenere retoricamente il progetto in sede di discussione finale, sia consumata. La metafora, in questo caso cartografica, è una figura fondamentale della conoscenza contemporanea, ma anchessa non può essere banalizzata oltre certi livelli, non certo recuperando da una cartografia il segno di una permanenza del disegno urbano in unarea che, come detto, ha una storia di lungo periodo di tuttaltra natura.
Due progetti paiono essersi posti il problema della complessità del sito: quelli dei gruppi Mecanoo / Cafer Bozkurt e Atelye 70 / Francesco Cellini /Insula. Mecanoo dà una lettura paesaggistica, estendendo al disegno urbano la radice di area non costruita che Yenikapi si porta dietro. Come tutti i progetti preliminari, si può discutere se le soluzioni paesaggistiche siano o meno coerenti con una storia difficilissima di rapporto tra natura, artificio e paesaggio che attraversa le culture bizantine e ottomane. Ma è un modo legittimo di porsi il problema.
Lunico progetto che tuttavia tenta dintrecciare sito e complessità è quello del gruppo Cellini, nel cui lavoro si avverte il ruolo di memoria storica e stratigrafica di Hüseyin Kaptan. Il cuore di questo intreccio tentato è ledificio che propone di tenere assieme il transfer point e lArchivio storico della città. Un progetto che cerca la contaminazione, senza tuttavia troppo spettacolarizzare il reperto, tra larticolazione del nodo infrastruttuale (1,7 milioni di viaggiatori attesi dal 2013) e la struttura temporale del luogo. Lo fa scommettendo sulla possibilità di tenere assieme lo «sguardo distratto» di benjaminiana memoria e la curiosità dellabitante della metropoli. Il progetto ha una forte valenza simbolica (lallusione alla nave) ma entra anche nei temi della complessità funzionale e strutturale, soprattutto sismica, che il sito propone, con soluzioni che fanno riflettere sulla possibilità per larchitettura di recuperare la sua necessità di sintesi di saperi che verrebbe da chiamare politecnici. Ma il progetto è convincente soprattutto su un altro piano, quello di tentare di contaminare due vite quotidiane: quella che emerge da unarcheologia del frammento e della traccia, e quella del cittadino di una metropoli oggi di quasi 15 milioni di abitanti.
Morfologia urbana
e problemi irrisolti
Il concorso è anche una rilevante proposta di valorizzazione fondiaria e immobiliare. Al di là del futuro edificio che ospiterà lArchivio storico e i reperti più importanti che si scaveranno (parco archeologico, parco culturale, problema di non fare delledificio del trattamento rifiuti un tema che metta a rischio lintera operazione archeologica e infrastrutturale), la parte più aperta rimane proprio la rigenerazione urbana dei quartieri che si affacciano su questo fantastico trou sul tempo. Progettare alla grande scala implica saper ridare significato a due topoi della cultura urbanistica oltre che architettonica: da un lato il boulevard (in particolare Vatan e Millet Streets) e i livelli di mobilità (ad esempio la pedonalizzazione è una dimensione che a Istanbul si vive con una declinazione commerciale che non è certo quella della metropoli senza luogo), che non debbono ridursi a temi di progetto tecnico e dingegneria delle infrastrutture; dallaltro la piazza, Aksaray in questo caso, chiamata a ridistribuire non solo flussi e gerarchie immobiliari ma anche a definire, insieme allulteriore piazza che dovrebbe connettere transfer point ed edificio dellArchivio (tenuti separati e monumentalizzati da quasi tutti i concorrenti), un sistema di piazze pubbliche che la storia della città non conosce e che non può essere sovrapposto alla forma urbana esistente come una griglia astratta.
La rigenerazione urbana pone allamministrazione due altri problemi, non certo irrilevanti. Il primo, affrontato solo dal gruppo Cellini, riguarda i modi di gestire il trasferimento delle attività e della socialità che vive intorno a Yenikapi, senza compiere solo unoperazione di sostituzione autoritaria di persone e attività. Ma ancor più a valle, come costruire una nuova e fondamentale centralità urbana che sappia davvero interpretare lanima cosmopolita di Istanbul, che non sia cioè solo un trasferimento di modelli internazionali, oggi usurati e spenti, né forme di nostalgia urbana, fallite persino nei recuperi delle piazze italiane, più o meno spinte da revival «regi» o accademici.
Se questo concorso è una cartina da tornasole davvero scioccante sul momento che sta attraversando la cultura architettonica internazionale, ancor più lo sarà per la gestione che degli esiti farà lamministrazione cittadina.
Istanbul è forse la metropoli più metropoli dEuropa, facendo una forzatura che vivendo la città è tale solo per gli equilibri politici. Scelte che non accettassero la sfida posta da memorie che non appartengono a nessuna cultura, ma anche sfide di una modernità non subalterna a modelli che si chiamano globali per non riconoscerli come standardizzati, sarebbero doppiamente perdenti.
Questo giornale tornerà a Istanbul come torna sui progetti che sceglie, per offrire una finestra aperta alle scelte architettoniche, urbane, archeologiche che si spera non siano troppo bizantine.