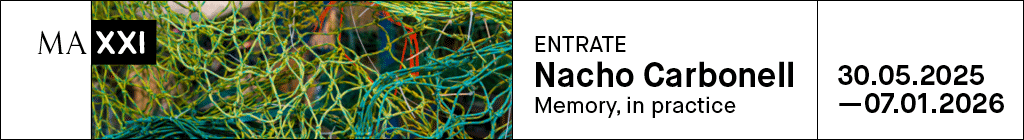Genova. Nel 2006 Time lo ha definito uno dei 100 uomini più influenti del pianeta: dopo il Texas (Houston, Atlanta, Dallas), dove segue ora un nuovo ampliamento del Kimbell Art Museum a Fort Worth, ha conquistato New York con lampliamento della Morgan Library, la torre del «New York Times» nel 2007, i progetti per il Mind, Brain and Behaviour Building (the Greene Science Center di Columbia) e lampliamento del Museo Whitney in corso; poi ha raggiunto San Francisco (California Academy of Science, 2008), Chicago (The Modern Wing dellArt Institute, 2009), Los Angeles (Resnick Pavilion del Lacma, 2010), quindi Boston (Harvard Art Museum e fine dellampliamento dellIsabella Stewart Gardner Museum prevista per gennaio 2012). L«era Piano» è diventata un fenomeno Usa, ma Rpbw sta progettando a Santander, Lisbona, Londra, Oslo, Atene, Beirut, Hanoi, Seul.
Ora rischia grosso: a pochi metri da Le Corbusier a Ronchamp, accanto a Louis Kahn e Philip Johnson a Fort Worth, la casa di Tom Pritzker ad Aspen, la famiglia Obama che passeggia allArt Institute. Queste non sono «mossette» di un profilo mediatico da star architect?
Sarei un traditore se facessi il «mossettaro». Cerco di capire da che parte viene il vento, quello dei problemi veri, nella realtà e nella metafora, perchè appartengo a quella generazione cresciuta subito dopo la guerra, convinta che le cose diventino sempre migliori: figlio di costruttori, mi innamoro di Albini e poi a 33 anni vinco il Beaubourg con Richard Rogers innanzitutto contro il senso dintimidazione. La mia vita è dentro i miei disegni e attorno ai miei cantieri. Larchistarismo distoglie dalla concentrazione creativa, ti proietta diabolicamente, gentilmente e quotidianamente solo sul riconoscimento pubblico. Confonde il pubblico con il popolo, fa diventare chi progetta maestro di parole, a volte di menzogne.
Quello dellarchistar è comunque un processo professionale che distorce il modo con cui si arriva alla committenza.
Per me è energia vana e superflua. Ho fatto parte della giuria per lassegnazione dei Pritzker per 5 anni, vivendolo come servizio. Il mio rapporto con Tom Pritzker poi è stato da costruttore: ho declinato inizialmente perché non sono un architetto di case ma poi non ho resistito ai pini e ai colori del Colorado, al progettare una sua residenza che ho appena finito.
Non crede che quello tra critici e star system sia un rapporto viscido di mutua legittimazione?
La riconoscibilità rischia dimprigionarti in un mondo narcisista e autoreferenziale. Per fortuna ci sono le «trombature»: leali e non di principio, come quelle di Luis Fernandèz Galiano ad esempio. È vero che si corre il rischio di accomodarsi sul divano di un amico critico psicanalista. Ma sono debolezze che si pagano. Le critiche fanno sempre soffrire, ma quelle sincere sono quasi medicine alleccesso di narcisismo.
Quanto e come è cresciuto il Building Workshop?
Lufficio ha una vita sana. Siamo 13 partners e 6 associati; alle azioni non corrisponde un valore economico ma di appartenenza, perché conta il gruppo e non lindividuo. I talenti sanno stare insieme, dove cè partecipazione e anche rapidità nel capirsi. Non ho scelto di avere studi grandi con centinaia di estranei: siamo 130 persone (Genova, Parigi e New York), tra cui 15 studenti provenienti da tutto il mondo. Il bilancio del Building Workshop è quasi fisso da dieci anni (circa 30 milioni di euro allanno), un terzo del margine viene distribuito, un terzo sostiene la Fondazione Renzo Piano, un terzo va in riserva. La stabilità di peso è un buon principio, così come indossare giacche un po strette per non ingrassare. Molti studi hanno scelto la strada di correre dietro al mercato. Noi abbiamo scelto la dieta che ci consentiva di vivere le crisi, non solo le congiunture fortunate. Proprio in questi mesi ho ceduto una parte delle azioni del Building Workshop ai miei partners. È un punto di arrivo di unidea forse nata dal mondo, quello tra fine anni sessanta e inizio settanta in cui molti di noi sono cresciuti. La condivisione è anche prevenzione delleccesso di narcismo, anche se sarebbe stupido negare che un certo narcismo nasce dal riuscire a far vivere quello che si è pensato, magari sognato.
Quanti lavori riuscite a seguire contemporaneamente e qual è il limite tra ripetizione e coerenza?
Circa 30, di cui 10 sono cantieri in essere, altrettanti stanno partendo e 7/8 in progetto. Larchitettura è un processo prima lento e poi veloce, è ritmo dato dallalternarsi di queste andature. Il lavoro nello studio è organizzato per gruppi quasi solo di architetti. Così con lentezza e concentrazione capisco dove sta la specificità del progetto. La lentezza fa maturare linvenzione. Ripeti, ripeti, sino a quando trovi, o ritrovi, lidea che ti convince. La velocità è la capacità di costruire il dialogo dentro il gruppo e di non forzarne le gerarchie, che si ritrovano nel progetto come nel cantiere. È la capacità di accettare che anche la ripetizione aiuta a dimensionare il progetto. Poi riusciamo a stare al passo perché abbiamo imparato a gestire i cantieri. Io lavoro al massimo su tre progetti nello stesso tempo. Nella prima settimana di giugno ho lavorato sui progetti di Santander e del Whitney; lunedì volo a Ronchamp e poi vado a Parigi. In cantiere, proprio perché sappiamo organizzarli, vado ogni tre mesi, come a Londra.
La Fondazione accumula e custodisce memoria e anche per questo sarà luogo dincontro e confronto, ma forse parla anche a voi.
La Fondazione non è unesposizione di trofei di guerra ma la raccolta di tante istantanee: come ogni lessico familiare si crea con la consuetudine e crea la consuetudine di una lingua condivisa. La Fondazione è qualcosa di più dellarchivio, anche se nasce da esso. Larchivio è un po il giardino della nostra infanzia. Ritrovi quello su cui ti sei formato o se preferisci è leducazione sentimentale che ogni persona che lavora nello studio può ripercorrere. Non è solo un racconto autobiografico, né unicamente un deposito che può essere esplorato. È unidea della memoria come stratificazione di segni, un po come nei racconti di Borges. E anche una cura contro lidea che il successo porterebbe con sé la pacificazione dei sensi, che il raggiungimento della fama sia lobiettivo, neanche dichiarato, di un lavoro come quello dellarchitetto che peraltro si misura con la materia. Larchivio ti stimola ad andare avanti, quasi ti ammonisce. E per questo è nata la Fondazione: per consentire a giovani architetti non solo di lavorare e di apprendere facendo, sebbene del learning by doing, in anni passati, mi hanno fatto diventare la bandiera. La Fondazione nasce perché lo studio, la riflessione sulle opere, sul percorso per raggiungerle, parlano di difficoltà, di concentrazione, di riflessione. È vero che provengo da una famiglia di costruttori, che la costruzione è lanima dellarchitettura. Ma leducazione alla riflessione, rubando nuovamente ad Albini, il suo valore dentro il silenzio (che lui praticava), è almeno altrettanto importante.
Chiudiamo tornando a Ronchamp. A settembre le clarisse potranno andare ad abitare le loro celle
Sì. È stata eliminata la casa che funzionava da portineria e che costituiva forse lelemento che più disturbava la comprensione delledificio, si è abbassato e riorganizzato il parcheggio, bisognerà tornare a conquistarsi Ronchamp, salendo attraverso il bosco, che è tornato a essere non solo una barriera ma un elemento vivo di un paesaggio che deve rimanere spirituale. Lintervento è stato certo complicato, si sono scontrate idee legittime sul moderno, non solo sulla sua conservazione. Io credo che oggi lopera sia tutta la zona, che la discussione abbia favorito un recupero di una dimensione non solo feticista dellarchitettura. Questo è forse il senso più autentico dellascoltare i luoghi, con cui mi piace iniziare ogni mio lavoro.