VENEZIA. A pochi giorni dalla vernice della 15° edizione diretta da Alejandro Aravena, il presidente della Biennale Paolo Baratta anticipa aspettative, obiettivi e temi fondamentali, rivendicando la centralità dell’architettura come arte politica per concorrere alla costruzione di uno spazio pubblico, stimolando le risposte di istituzioni e collettività. Alla Biennale affida il ruolo di agente provocatore continuando, nella sua ricerca, a suscitare desideri e domande. Perché – afferma Baratta – «la verità è che noi non sappiamo cosa chiedere agli architetti. Abbiamo perso il desiderio». A questa Biennale «molto ottimista» il compito di concorrere a risvegliarlo, magari cominciando ad allargare lo sguardo oltre «la nostra compiuta tranquillità».
Presidente Baratta, quali sono le sue aspettative per questa 15° Mostra internazionale di Architettura?
Primo: che ci si accorga che la Biennale ha una linea-guida seguita nel corso degli anni. Ogni mostra costituisce il momento di una ricerca che, da un’edizione all’altra, procede intorno ad alcuni dei temi fondamentali suggeriti dall’evoluzione dell’architettura nel tempo presente. Mi attendo che questa mostra sia valutata in relazione allo sforzo di indagine che la Biennale conduce da tempo con i diversi curatori e non sia quindi considerata un “evento” di architettura.
Secondo: che l’esposizione si dimostri utile nel riprendere un dialogo con il pubblico, nel far riconoscere l’architettura come elemento indispensabile per ciascuno in quanto cittadino. Abbiamo da tempo superato un modello che vedesse un vernissage seguito da una mostra il cui scopo è il pubblico. La Biennale Architettura è la nostra creatura più giovane, di gran successo, ed è necessario il suo arricchimento e cioè che all’esposizione si accompagni sempre più il colloquio diretto con coloro che vi sono rappresentati. Non solo quindi il colloquio con le opere, ma con le persone.
Mi aspetto che anche le autorità e le istituzioni vi trovino degli spunti per dare una più precisa sostanza all’aspetto normativo, in merito ad esempio al consumo di suolo, al tema delle periferie, della riqualificazione… Tutti dicono di condividere questa esigenza ma in realtà vi è una sostanziale vaghezza. Speriamo ad esempio che Renzo Piano (tra i partecipanti invitati n.d.r.) espliciti le sue riflessioni ma speriamo anche che le istituzioni comincino a considerare sempre più l’architettura come uno degli strumenti di governo e non come un eclatante ripiego alla loro mancanza. Troppo spesso in passato abbiamo avuto un’architettura chiamata a porre un bell’oggetto in mezzo alla città non potendoci occupare della città.
Non teme che un tema così attuale e delicato possa subire una strumentalizzazione?
Se per strumentalizzazione intendiamo la consapevolezza che l’architettura può finalmente essere strumento di un processo in cui sappiamo cosa vogliamo sapendo chi è incaricato di definirlo, chi deve farlo nascere (l’autorità comunale? statale? i singoli individui?), ben venga. L’architettura deve esser intesa come fenomenologia del controllo dello spazio nel quale viviamo e del suo arricchimento. Saper domandare agli architetti è già un enorme passo avanti nel chiarimento del rapporto tra noi e lo spazio nel quale viviamo. La verità è che noi non sappiamo cosa chiedere agli architetti. Abbiamo perso il desiderio. I bisogni elementari sono soddisfatti anche in modo mediocre e il bisogno elementare di volumi spesso coincide con l’escluderci dagli altri per raggiungere la nostra compiuta tranquillità. I nostri sviluppi urbani sono un io per me stesso, non un costruire insieme a.
A discapito dell’aspetto qualitativo.
Anche formale e a discapito della presa di coscienza di uno spazio pubblico. Non si può progettare lo spazio privato senza avere nella nostra testa il problema dello spazio pubblico. Questo è il mio manifesto. [Baratta volge lo sguardo verso una grande immagine fotografica nel suo studio (Immediate Surroundings, 2014, Tommaso Bonaventura, Alessandro Imbriaco, Fabio Severo. Monditalia – Biennale Architettura 2014) ritraente una strada e alcune villette che vi si affacciano; n.d.a.]. Chi ha progettato tutto per il proprio benessere, con evidente desiderio di opulenza, si chiude dietro una ringhiera lussuosissima. Osservi questa striscia di terra di incerta proprietà che costituisce il confine tra lui e il resto del mondo, ovvero tra lui e lo spazio pubblico. Guardi in che stato è. L’architettura risponde a un altro fabbisogno: il mio rapporto con quello che c’è fuori, io che concorro a costruire lo spazio nel quale vivo. Questo scatto non ritrae un fabbisogno: qui manca il desiderio. Me lo tengo qui perchè è una sorta di manifesto dove lo spazio pubblico è ignorato, non esiste.
Perché ognuno pensa al proprio confine privato…
Il sentire lo spazio pubblico come facente parte dei fabbisogni è frutto di un’operazione che sollecita il desiderio di un qualcosa di più, è un concetto di benessere leggermente dilatato rispetto al benessere privato che conduce ciascuno a farsi la propria tana. Riflettendo su questi aspetti si può giungere a considerare il problema delle periferie prive di spazio pubblico (nel Padiglione che realizzeremo con la London School of Economics, grandi riproduzioni di città illustreranno proprio la perdita di quest’ultimo nelle grandi conurbazioni).
Negli anni cinquanta e sessanta gli urbanisti si atteggiavano a salvatori del mondo, quasi fossero i soli ad avere la chiave per risolvere il fenomeno dell’aumento demografico. Oggi non siamo più in condizioni di avere un’unica persona che risolva tutti i problemi. Piuttosto dobbiamo avere un fenomeno che coinvolga più soggetti. I centri decisionali siamo noi. Concepiamo quindi la rinascita dell’architettura come strumento di vita, di organizzazione della nostra esistenza, di autogoverno. L’architettura è un’arte politica perché è essa stessa la manifestazione di una polis, di un cittadino dimezzato o compiuto. È la cartina di tornasole della civiltà.
In merito all’aspetto espressivo, quali sono i vincoli allestitivi di una Biennale d’Architettura?
L’architettura ha bisogno di un mezzo espressivo per essere rappresentata in mostra. A tal riguardo la storia delle Biennali è istruttiva. Il primo padiglione, che fu quello di Paolo Portoghesi (se si escludono le operazioni precedenti di Vittorio Gregotti) partì con una rappresentazione in scala 1/1 all’interno della quale molti architetti risposero con dei coup d’artiste. Poi, nel corso degli anni, vi furono le Biennali dei blueprint (cioè dei progetti rappresentati), delle maquette… Con Massimiliano Fuksas abbiamo conosciuto il dualismo totale tra le maquette da una parte e uno schermo lungo quasi 300 metri alle Corderie dell’Arsenale che esprimeva la necessità di trovare rappresentazioni evocative, emotive, per dare alla Biennale un forte senso di dialogo con il pubblico. Abbiamo poi avuto un periodo nel quale abbiamo commesso qualche indulgenza all’idea dell’architetto-artista ossia: poiché non posso portarti la mia opera, porto le mie idee nel loro divenire, le utopie. È stato un fenomeno inevitabile. L’architetto come artista o come pensatore ha prodotto Biennali molto interessanti. Poi è arrivata la serie di Biennali in cui le domande son tornate: «esiste un Common Ground tra gli architetti? Esiste l’architettura o esistono soltanto gli architetti-artisti?». Non parliamo poi di Rem Koolhaas che dice: le forme sono banalità perché creiamo scatole vuote e quindi l’architettura deve ripensarsi come strumentazione dell’organizzazione della vita individuale e collettiva.
Che cosa si vedrà in questa edizione?
Si vedranno alcuni esempi che si riferiscono alle conurbazioni, alle realtà urbane, oltre a quel confronto tra tecnologie tradizionali e forme utili per affrontare domande d’oggi. Quali domande posso porre all’architetto e quali alle tecnologie? In questa Mostra non vedremo il trionfo del computer, al contrario, il computer sarà un ausilio per risolvere problemi complessi utilizzando materiali tradizionali. Ci saranno anche pezzi singoli di costruzioni per dare modo di leggere il tessuto vivo della realizzazione. La Biennale continua insomma a manifestare il problema del suo linguaggio, quello di scegliere le forme. È un processo sempre vivo, non c’è una ricetta definitiva.
In un panorama in cui attraverso la circolazione d’immagini e rendering tutto suona come già visto o inflazionato, vi sarà anche qualcosa d’inedito?
Questa è un’osservazione che poteva riferirsi a quando la Biennale aveva la forma della rivista d’architettura, cioè far vedere maquette e progetti… Da tempo ciò non avviene più. La Biennale deve provocare la voglia di sperimentare qualcosa di diverso, anche con noi stessi in quanto pubblico. Non deve essere una rivista che fornisce le ultime novità. Fare cultura vuol dire questo: trovare connessioni e stimolo nelle relazioni tra le cose.
Quale sarà la linea che caratterizzerà le prossime edizioni? Dopo Aravena ritiene possibile un ritorno all’archistar?
Le archistar sono presenti anche in questa Biennale ma non da archistar. L’archistar è tale perché noi gli chiediamo di esserlo. Lo diventa perché gli si richiedono fenomeni comunicativi, spettacolari. L’architettura è indubbiamente anche comunicazione ma vi sono molte cose che per paradosso non vengono comunicate. Credo che i problemi del tempo presente impongano un momento di attenzione e tra questi vi è il rapporto individuo-comunità. Mi riferisco anche a cose minute e semplici. Perseguire questa linea credo sia inevitabile, a meno che di nuovo non si pensi che il pessimismo possa tornare a dominare. Questa è una Biennale molto ottimista: vuole risvegliare attenzioni, domande, desideri.
In riferimento a un particolarismo locale, qual è il “fronte” veneziano e che cosa lascerà questa Biennale a Venezia e al territorio circostante?
I discorsi che qui facciamo sono rivolti alla drammaticità dei problemi sociali delle grandi conurbazioni dei paesi poveri e allo stesso tempo alla banalità con la quale sono stati risolti nei paesi ricchi. Le periferie in Italia non sono particolarmente qualificate. L’assenza di domanda ben organizzata vale nella metropoli di Bangkok, nella periferia delle nostre province sparse così come in una regione come il Veneto, con tutti i problemi che ha in merito alla riqualificazione degli spazi industriali e del rapporto tra città e campagna. Sulla città di Venezia non ho molto da aggiungere; certo, se anch’essa avesse maggior capacità di porsi delle domande, non sarebbe male.
Ciò detto noi proseguiamo nella nostra ricerca. Abbiamo osato molto anche per il pericolo di equivoci tra problematiche politiche che vengono interpretate come problematiche sociali. Poi, certo, non siamo qui per risolvere i problemi del mondo. Siamo qui per provocare. Siamo agenti provocatori che sono necessari perché abbiamo davanti a noi un’infinità di agenti pubblicitari. Per fortuna abbiamo un’eco altrettanto potente. Ed è tanto più potente quanto più il mondo ci guarda con rispetto e fiducia. Il risultato non si misura in fatturato. Una Biennale deve lasciare molti interrogativi.
A quando un curatore italiano della Biennale Architettura?
L’ultimo fu Fuksas. Siccome siamo una Mostra Internazionale, se lei fa la proporzione della popolazione italiana sul globo…
Una risposta molto diplomatica…
Non abbiamo scelto Aravena perché fosse tempo di avere un cileno, bensì perché era tempo di avere un architetto che ragionasse così.
Girando allora il quesito, pensa che un domani un italiano potrà incarnare la linea che intende perseguire la Biennale?
Non mi sembra la questione su cui soffermarsi. Piuttosto quello che noto e che mi sembra degno di riflessione è che anche i molti bravi architetti italiani hanno poche occasioni per sentirsi fare domande importanti. Il nostro Paese continua a produrre architetti pur mostrando in apparenza di non averne bisogno, e comunque di non desiderarli. Non sento intorno domande forti, precise, poste agli architetti da parte di soggetti privati (se non pochi), né tantomeno da parte di soggetti pubblici. Dove sono nel nostro panorama nazionale contesti che vedono l’architettura impegnata con domande precise? In ogni caso, quando la Biennale sceglie il curatore egli deve rappresentare, nel suo ruolo, la tensione al tema che vogliamo affrontare, e mai come in questo caso con Aravena c’è identità tra architetto e argomento che si vuol trattare. Rifletteremo sulle prossime Biennali. Se il tema vedrà un architetto che lo rappresenta intensamente lo sceglieremo. Se poi risulterà cittadino italiano, tant mieux…
Immagine di copertina: Paolo Baratta, presidente della Biennale di Venezia (foto di Francesco Galli – Courtesy: la Biennale di Venezia)
















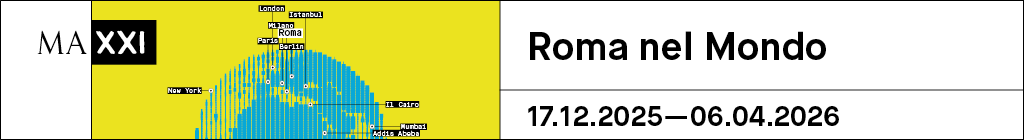










[…] Paolo Baratta: una Biennale ottimista, risveglierà domande e desideri di Veronica Rodenigo […]