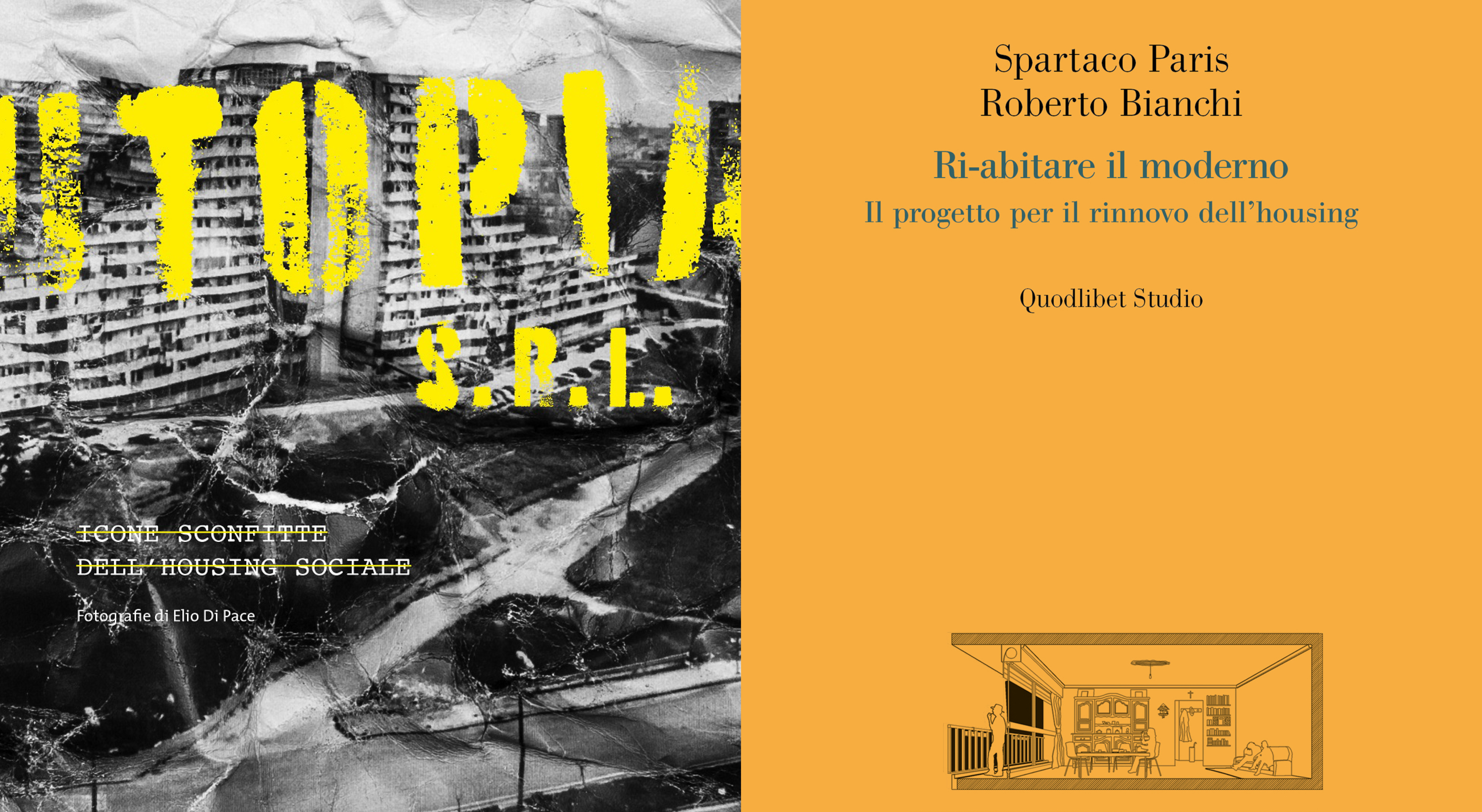Tra le case editrici più interessanti del panorama italiano, LetteraVentidue e Quodlibet aprono il campo ad una riflessione su grandezze, miserie e potenzialità dell’abitare collettivo, attraverso una serie di casi studio internazionali
Il fallimento delle politiche pubbliche per la casa ha quasi sempre il volto di architetture smisurate, sorte sulla spinta di una fiducia quasi mai corrisposta dai fatti. Si tratta d’involucri stropicciati divenuti involontariamente icone del proprio opposto, che il libro Utopia s.r.l. Icone sconfitte dell’housing sociale racconta con una riflessione analitica inedita, giocata su due diverse chiavi di lettura. Se da un lato la lente critica delle due autrici (Viviana Saitto e Cristina F. Colombo) pone il tema dei modelli abitativi e architettonici – su tutti prevale il successo dell’Unitè di Marsiglia (1946), non ripetuto dalle altre residenze collettive corbusieriane – e dei fallimenti, dall’altro l’indagine si spinge oltre gli involucri, desacralizzando questi monumenti sconfitti per osservare, attraverso le fotografie di Elio Di Pace, come ogni cellula ripetuta all’infinito sia stata, in realtà, addomesticata. Risiede proprio in questo sguardo indiscreto, oltre la soglia, la tesi del saggio che ricerca le cause del cortocircuito tra progetto e realizzazione di queste utopie a tre dimensioni nei tre decenni successivi alla seconda guerra mondiale. Lo spazio dell’abitare collettivo, immaginato per risolvere il problema della casa in un continente che si risvegliava senza tetto nel 1945, pensato per esaltare la libertà e il completo sviluppo democratico dell’individuo, si materializza con una serializzazione omologante che accomuna queste architetture residenziali ad alta densità alle costruzioni simbolo della coercizione (caserma, ospedale, carcere). Tra progetti realizzati a metà senza la prevista dotazione di spazi comuni, servizi collettivi e programmi di gestione, l’imprevedibile trasformazione sociale degli abitanti, il crollo dei modelli economici che hanno ricostruito gran parte delle città del dopoguerra, vengono analizzati alcuni casi distanti tra loro nel tempo e nello spazio per tracciare un’ideale linea d’indagine sulla soluzione abitativa che si trasforma in problema: i Robin Hood Gardens a Londra, Park Hill Housing a Sheffield, Le Mirails a Tolosa e, in Italia, le Vele di Scampia, il Corviale a Roma, Forte Quezzi a Genova e il quartiere Zen a Palermo. Le Istantanee, 57 foto rigorosamente in bianco e nero, documentano i Robin Hood Garden in fase di demolizione, il dedalo chilometrico di Corviale e gli scorci piranesiani delle Vele napoletane, accompagnando il racconto, quasi in presa diretta, delle loro diverse internità, ovvero di come la spersonalizzazione percepibile dall’esterno, riverberata dalla letteratura, dalla cinematografia e dalla cronaca nasconda, in realtà, storie di privata resilienza capaci di costruire forme visibili d’identità.
Parte dalle medesime premesse Ri-abitare il moderno. Il progetto per il rinnovo dell’housing, che si focalizza sul tema del recupero di questo immenso patrimonio immobiliare, la cui crisi è tutt’altro che recente, mostrando le prime avvisaglie già con la crisi energetica degli anni ’70, come sancito dalle parole dei più lucidi osservatori di quello spartiacque temporale. L’analisi polisemica di queste costruzioni, anch’essa condotta a quattro mani (Spartaco Paris e Roberto Bianchi), ne restituisce valore come risorsa, contro la damnatio memoriae che continua a suggerire progetti di demolizione con i quali, il più delle volte, si tende a risolvere il problema eliminandolo fisicamente. Lo sguardo, rivolto principalmente alle esperienze di paesi come Francia, Inghilterra, Olanda e Svizzera – con una maggiore maturità rispetto all’Italia in termini di costruzione prima e rinnovo poi del parco residenziale collettivo –, individua la matrice industriale del processo edilizio da cui sono derivati interi quartieri popolari; e il riconoscimento di tale valore tecnico porta con sé anche il possibile approccio al rinnovamento. La standardizzazione dei prodotti, infatti, è alla base di un nuovo processo edilizio che permette interventi capaci di agire sulle prestazioni globali degli edifici, sulla loro flessibilità, sul loro rapporto con il contesto urbano in modo aperto e reversibile. L’attenzione è rivolta alla personalizzazione distributiva, alla riduzione dell’impatto del cantiere (in termini temporali e d’interferenza con gli abitanti che possono continuare a vivere nelle loro case), al miglioramento della risposta energetica in fase d’uso, attraverso addizioni, in facciata o in copertura, che reinterpretano – senza mai contestarlo – il linguaggio dell’opera originaria. Nove i casi studio presentati e realizzati tra il 2001 e il 2016 su case popolari edificate tra gli anni ’60 e ’70 del Novecento (solo uno italiano) il cui ridisegno deriva da un diverso e mutato paradigma, una nuova e possibile strategia anti tabula rasa, abbracciata dagli enti gestori nei cui programmi di rigenerazione abitativa trova posto la programmazione del monitoraggio sui risultati attesi (in termini di consumi, modi d’uso, risposta sociale e integrazione territoriale), su un intervallo temporale ragionevolmente lungo per valutare l’efficacia complessiva dell’intervento su strutture nate come bene comune. Chiudono il volume due casi di ricerca in ambito italiano, due proposte progettuali sperimentali elaborate sulla scorta degli esempi critici selezionati, per altrettanti insediamenti residenziali collettivi sorti negli anni ’80 a Roma (Casale Caletto) e Latina (le Vele).
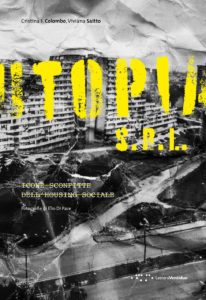 Utopia s.r.l. Icone sconfitte dell’housing sociale,di Viviana Saitto e Cristina F. Colombo (fotografie di Elio Di Pace), LetteraVentidue Edizioni, 2018, 124 pagine, € 18
Utopia s.r.l. Icone sconfitte dell’housing sociale,di Viviana Saitto e Cristina F. Colombo (fotografie di Elio Di Pace), LetteraVentidue Edizioni, 2018, 124 pagine, € 18
—
 Ri-abitare il moderno. Il progetto per il rinnovo dell’housing,di Spartaco Paris e Roberto Bianchi, Quodlibet, 2018, 248 pagine, € 24
Ri-abitare il moderno. Il progetto per il rinnovo dell’housing,di Spartaco Paris e Roberto Bianchi, Quodlibet, 2018, 248 pagine, € 24
About Author
Tag
abitare , libri , social housing
Last modified: 6 Settembre 2019