Profilo dell’architetto irlandese che ha fatto fortuna negli USA con una serie impressionante di progetti a varia scala, premiato dal Pritzker nel 1982
Probabilmente la definizione migliore su di lui l’ha data Mark Noonan, anch’egli architetto, autore di un film sulla sua vita intitolato “The quite architect”. Lontano dai clamori mediatici ma assolutamente presente come progettista, questo sì, è stato Kevin Roche, spentosi a 96 anni lo scorso primo marzo. Autore, assieme al suo socio John Dinkeloo (1918-1981), di una serie impressionante di progetti a varia scala, che da New Haven – sede della prevista trasferta dello studio Saarinen in cui entrambi lavoravano – si sono sparsi in tutta l’America ed oltre. Un soggiorno a Detroit di 11 anni che ha riversato su di loro il compito di portare a termine gli edifici iconici dello studio alla scomparsa di Eero: dall’aeroporto Dulles di Washington all’arco di St. Louis fino al famoso terminal Twa al Kennedy di New York. Formazione alta quindi per il giovane irlandese sbarcato negli Usa nel dopoguerra. Prima, nello studio londinese di Edwin Maxwell Fry, successivamente con i Saarinen (dove c’erano Robert Venturi, Cesar Pelli e Warren Plattner fra i non molti) e a seguire, un semestre con Mies van der Rohe all’Illinois Institute of Technology.
Strani passaggi che dall’«Umanesimo» di Saarinen andavano all’«Assoluto» di Mies, ma che servono a capire l’incredibile traccia di un apprendistato eccellente confluito in un particolare dualismo che è stato il suo modus operandi. Quello di una marcata identità formale da un lato e della straordinaria attenzione al dettaglio dall’altro. Dettaglio concepito come intrinseco alla forma senza peraltro attribuirgli valenze universali da reiterare indefinitamente, alla Mies (si vedano le porte d’accesso alla Ford Foundation a New York). L’altro dualismo sembra rientrare nella persistenza di un forte atto connotativo e formale in grado di mettere a punto un sistema ideale da quarta dimensione, vedi il College Life Insurance Company a Indianapolis, per poi farsi coinvolgere in elementi più “contemporanei”, conservando comunque un incredibile impatto e prorompenza. Tanto nella progettazione orizzontale, quella dei musei o di sedi corporative o sportive, quanto in quella verticale del grattacielo, tema scottante e controverso più del primo.
Così l’orizzontale dell’Oakland Museum, o del Coliseum di New Haven – successivamente ahimè demolito – dove la torre degli uffici e l’area sportiva esplicitano questo approccio, fino alle sedi della Deere&Co a Moline (Illinois) o dei Richardson&Vicks a Wilton (Connecticut) o della General Foods a Rye (NY), dove si passa da un magnifico strutturalismo miesiano ad una simmetria di pianta da edificio classico in alluminio. È la storia, e a volte è la cronaca. Stessa cosa per la progettazione in verticale da lui definita in varie sedi come semplice elaborazione del sistema colonna. Un sistema che mette assieme l’United Nation Plaza e la J.P. Morgan, entrambi a New York. Si passa così dalla sublimazione atemporale del rapporto cilindro-trave del “The Knights of Columbus” a New Haven, adiacente il Coliseum – elaborato in varie situazioni anche dal vocabolario di Kenzo Tange – alle piramidi del College Life Insurance di Indianapolis, al 750 di 7th Avenue a New York [nel ritratto di copertina, il modello]. Dal confronto con il fuori tempo ad ammiccamenti se non coinvolgimenti col contemporaneo.
Coerenza della disomogeneità che inventa magnificamente ma lambisce e subisce qualche moda e poi finisce per dettarne altre. L’avevano anche scritto nel consegnargli il Pritzker nel 1982. Ma è la sua fisionomia: e basta aggirarsi per New York per percepirla. Nel 1968 la Ford Foundation ribalta il concetto di ufficio, delimita l’urbano e apre una sorta di Eden al pubblico del lunchtime e non solo, inglobando il concetto di natura e di serra nella metropoli. Il legame con il pedone metropolitano ed il verde sono la chiave di volta che unisce questo sistema. Non a caso l’amore per la serra è ribadito anche al Metropolitan Museum in condizioni di estrema difficoltà e limitazione di spazio. Poco più ad est della Ford Foundation, sempre sulla 42ma, interverrà successivamente con un progetto – poi limitato dimensionalmente – proprio di fronte al complesso delle Nazioni Unite. L’United Nations Plaza ci svela il meccanismo di fondo della potenza gestuale e creativa, niente affatto succube del vicino. Due blocchi decisi e lievemente scolpiti rivestiti in vetro che non indulge in trasparenze perché esalta nel colore il sistema di questa idea del costruire. Un’idea fatta di “monumentalismo identitario”, associato alla cura del dettaglio conseguente l’attenzione per l’uso del quotidiano. Qui è la pensilina d’angolo a giocare lo stratagemma dell’invito ad entrare nella grande lobby. Un sistema che lo stesso Roche ribadisce in una magnifica intervista a «Perspecta» nel 2006. Il titolo dell’articolo aggiunge un altro tassello alla lettura di questo impianto ideale, ricorrente ma non dogmatico: un modo (dell’edificio) per dire «Ci sono». Sempre a Manhattan la scala “domata” ritorna in un lavoro impossibile che lo impegna a vita. L’estensione del Metropolitan Museum; dove nella serra del tempio di Dendur o nel cemento delle nuove sale ritornano spazi a volte dichiaratamente controversi. Mentre i grattacieli sulla 42° ridefiniscono il profilo urbano in maniera massiva, e dopo la mancata realizzazione dell’edificio per la Federal Reserve Bank – che anticipava lo spazio aperto del Citicorp a livello pedonale – un altro grattacielo s’impone in una zona allora intatta di Wall Street: la sede della J.P Morgan, che emerge dall’assembramento di downtown con un sistema di bay windows e mansarde e con un affaccio privilegiato che ne esalta la presenza nel panorama alto, grazie anche ad un marcato rivestimento a fasce orizzontali. Un convitato di pietra che ha comunque saputo leggere l’intorno. L’attitudine al minimalist abstract che forma scultura (sua ammissione a «Perspecta») permane e si compiace delle proprie capacità d’investigazione sul “contemporaneo” più a nord. È il 1983, per l’appunto. Qui l’indagine sulla massa diviene meno minimalista ed astratta. Al 750 di 7th Avenue – siamo nel cuore dell’effimero consumismo visuale di Times Square – è il pinnacolo terminale vetrato ad assolvere tale funzione e concludere l’evoluzione di un edificio che vuole riscattare la media altezza con ogni artificio, assenza di colore inclusa. Anticiperà a suo modo la sequenza senza fine delle antenne di “culmine” dei grattacieli proliferanti dal Renzo Piano del «New York Times» building a tutta Times Square, appunto. E facendo presagire l’attenzione per il messaggio mediatico esplicitato dai forti volumi del Centro congressi di Dublino. Per ribadire quel ”Here I am“, perseguito costantemente e che da sempre è l’essenza di quell’architettura di cui ci lascia esempi spettacolari.





















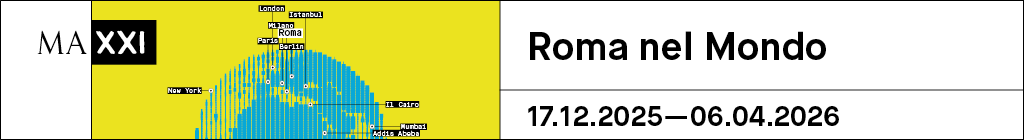










[…] comporta. La recente scomparsa di vari rappresentanti eccezionali dell’architettura (Kevin Roche e Robert Venturi fra gli altri), così come la loro lunga presenza nel panorama costruito, può […]
[…] La conclusione di un periodo fortemente connotato come quello che alcuni di questi personaggi (Kevin Roche, Ieoh Ming Pei) hanno rappresentato – dagli anni ’70 e ancor prima fino ad oggi – […]