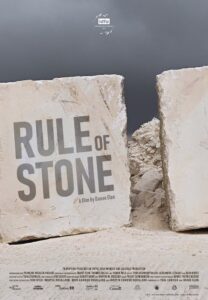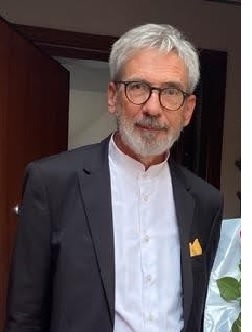Il film-documentario di Danae Elon ricostruisce la vicenda di una norma architettonica che ha impatti indelebili sulla storia stessa della città
È stato presentato in anteprima nazionale al Pordenone Docs Fest il film documentario “Rule of Stone”, scritto e diretto da Danae Elon, regista israeliana-canadese. Indaga con eccezionale vividezza la vicenda dell’espansione e ricostruzione di Gerusalemme dopo la conquista e l’annessione nel 1967 della parte orientale della città abitata dalla popolazione palestinese, con l’istituzione della rule of stone, ossia la norma di costruire edifici che utilizzassero tassativamente in facciata la pietra estratta dalle cave locali.
Dove l’architettura è politica. E viceversa
Il film si sviluppa con un montaggio efficace di riprese della città di pietra e delle cave da cui il materiale è estratto, di introspezioni sul campo nella realtà sociale del popolo palestinese, di qualche inserto autobiografico e soprattutto di interessanti interviste a cuore aperto con alcuni architetti protagonisti della pianificazione e ricostruzione della città, in primis Moshe Safdie e Elinoar Barzacchi, o con docenti dell’università locale come Zvi Efrat.
Ne risulta uno spaccato eccezionale di una realtà complessa e terribilmente problematica, messa a nudo con estrema lucidità ma anche con sorprendente encomiabile pacatezza, che induce lo spettatore a meditare profondamente su temi così scottanti, senza posizioni faziose ma anche con il coraggio di affrontare di petto lo spinoso dilemma tra le ragioni di una e dell’altra parte.
È naturalmente impossibile evitare oggi l’evocazione della tremenda angoscia del conflitto israelo-palestinese, che sta sullo sfondo della vicenda narrata (il film è del 2024), ma interessa qui soffermarsi sulle tematiche ancor più universali che il film solleva, relative al ruolo dell’architetto e dell’architettura nei confronti della realtà sociale e soprattutto delle scelte del potere politico, all’antico rapporto tra istanze etiche e istanze estetiche, all’altrettanto costante ritorno del tema dei rapporti tra valori e simboli della tradizione e dell’innovazione.
Temi cui non si sottraggono i protagonisti intervistati, raccontando con spietata sincerità le contraddizioni che dovettero affrontare nel loro concreto operare. Colpiscono in tal senso alcune affermazioni di una nobile figura dell’architettura internazionale quale è Moshe Safdie – autore della prima larga opera di ricostruzione dei quartieri orientali della città nei tardi anni sessanta, in collaborazione con il sindaco laburista Teddy Kollek – che sostiene le scelte estetiche di buona architettura a fronte della volontà politica cui fu chiamato a rispondere; o, d’altra parte, le amare riflessioni di Elinoar Barzacchi circa il passaggio dall’iniziale coinvolgimento ideale degli architetti e pianificatori impegnati nella ricostruzione in funzione della riunificazione di Gerusalemme al tardivo riconoscimento di quanto tale opera avesse assunto i connotati tragici della colonizzazione e della discriminazione nei confronti della popolazione palestinese.
Colonizzazioni
Emerge così una pesante questione relativa ai problematici rapporti tra architettura e potere (politico-amministrativo) e al conseguente scontro tra professionalità tecniche, scelte estetiche e responsabilità etica, a fronte delle scelte politico-ideologiche e di governo della città e del paese, che nella fattispecie di Gerusalemme si tradussero in una radicale opera di colonizzazione, che continua oggi più atrocemente ancora nei territori occupati della Cisgiordania.
Una problematica che ha una dimensione universale e può estendersi a molti esempi delle opere di colonizzazione, passate e recenti, spesso esempi preclari di architettura: dalle città e architetture coloniali dell’America Latina a quelle dell’Africa (anche italiana), fino a celebri imprese di pianificazione urbana quale la Brasilia di Lucio Costa e Oscar Niemeyer, voluta dal presidente Juscelino Kubitschek (raccontata da Juliana Vicente nel video “Terra Nakupa”). Per non parlare poi di opere di colonizzazione interna, come per esempio gli sventramenti/risanamenti in aree abitative ritenute degradate dei centri storici italiani d’epoca fascista, talvolta seguiti da ricostruzioni architettonicamente pregevoli.
La questione è ancora più drammatica nel caso di Gerusalemme per il sovrapporsi quasi inestricabile delle ragioni dell’eredità e dell’identità del popolo ebraico a risarcimento delle tragedie storiche della diaspora e della Shoah e di quelle del popolo arabo-palestinese là insediato, vittima designata del sogno sionista. Una problematica già peraltro documentata nei suoi drammatici contenuti dal libro-denuncia di Rafi Segal e Eyal Weizman, A Civilian Occupation. The Politics of Israeli Architecture, 2003.
Per non parlare del tema di tremenda attualità della futura ricostruzione di Gaza, sul quale si addensano minacciose le nubi delle orripilanti ipotesi in forma di resort evocate da Donald Trump e non solo, ma anche le non meno problematiche ipotesi di ricostruzione per cellule allo studio dei ricercatori dell’Università IUAV in collaborazione con l’UNDP, che certamente costituiscono contributi tecnicamente virtuosi, ma che è purtroppo ancora tutto da scoprire per quali strategie politico-sociali potranno semmai applicarsi, stante il perdurare della guerra e delle distruzioni e la mancanza di un efficace piano di pace.
L’identità che diventa maquillage
Torniamo al tema più disciplinare che ispira il titolo del film, ovvero l’uso imposto per legge del materiale-pietra come garanzia di continuità con la tradizione figurativa e costruttiva locale. Rimanda al ricorrente dilemma – anch’esso di valore universale – tra continuità e discontinuità con la tradizione delle scelte figurativo-costruttive nel rapporto antico-nuovo e all’interrogativo circa la opportunità o meno di farne non solo una bandiera identitaria ma addirittura una norma impositiva.
Anche in questo caso la tentazione delle politiche di governo (peggio quando dittatoriali) di imporre la scelta ai progettisti è sempre assai forte: basti pensare al ritorno in auge in fase di trumpismo del verbo neoclassico (refrain peraltro accarezzato mille volte in passato, non solo da dittatori e autocrati, ma anche per esempio dal principe, ora re, Carlo di Inghilterra).
Scelte di campo di questo tipo sono state anche oggetto talvolta di strategie e politiche più virtuosamente ispirate alla tutela e alla conservazione dell’ambiente: penso per esempio alla pervicace azione di una nobilissima figura come César Manrique nel guidare lo sviluppo in chiave pseudo-mediterranea dell’edilizia di Lanzarote, e molti altri esempi simili di protezionismo culturale si potrebbero citare. La regola della pietra di Gerusalemme giocò probabilmente a favore, in un primo tempo, della cifra di immagine dei nuovi insediamenti progettati da Safdie, ma si è ben presto tramutata in un espediente superficiale e stereotipato nei successivi sviluppi, riducendosi a discutibile maquillage, e il documentario ciò testimonia con molta appropriatezza.
Il che fa pensare, in generale, che ogni regola o norma rigidamente concepita e gestita tenda inevitabilmente a diventare un cappio pericoloso che impedisce la ricerca di nuove risposte creative. La meditazione su tali argomenti scottanti è d’obbligo.
Peraltro, ahimé, la Gerusalemme Celeste, o anche solo la Gerusalemme pacificamente multi-etnica, è purtroppo di là da venire.
In copertina: immagine del docufilm Rule of Stone, 2024
Rule of Stone
diretto da Danae Elon, prodotto da Danae Elon e Paul Cadieux
2024, Canada
84′, dialoghi in arabo, ebraico (con sottotitoli in inglese) e inglese
Prodotto da Filmoption International
Terra Nakupa
diretto da Juliana Vicente
2023, Brasile
About Author
Tag
cinema , conflitto israelo-palestinese , democrazia , docufilm , Gerusalemme , Moshe Safdie , pietra
Last modified: 7 Aprile 2025