Analogie e differenze in due libri che muovono da esperienze biografiche per affrontare il senso dell’essere architetto oggi
—
In un panorama editoriale ipertrofico e omologato, spiccano pubblicazioni che hanno l’obiettivo di trasformare carriere professionali in occasioni per riflettere, ad ampio raggio, sul senso stesso del progetto contemporaneo. Due di queste sembrano indicare traiettorie originali, raccontando il pensiero teorico e la sua applicazione pratica nell’esperienza di due progettisti della “generazione di mezzo”: Valerio Olgiati e Alfonso Femia.
Il testo di Olgiati (1958) ha la veste grafica del manifesto: piccolo formato, solo testi, nessuna immagine, un solo disegno (una pianta, diagrammatica, di un tempio pre-colombiano messicano), caratteri molto grandi. L’originale (2018) è in inglese, ma Park Books ha pubblicato nel 2019 un’edizione italiana. Il titolo dichiara il campo di azione: Architettura Non-Referenziale si muove lungo i crinali del contemporaneo, tratteggia un mondo in cui si sono perse le ideologie del Moderno e del postmoderno e quindi, in un orizzonte così liber(at)o, il progetto di architettura assume il diritto-dovere di essere generatore di forma e produttore di senso. È il frutto di un dialogo, tra Olgiati (si auto-definisce l’ideatore) e lo scrittore, il teorico dell’architettura Markus Breitschhmid, svizzero ma residente negli Stati Uniti, dove il libro è stato in gran parte redatto, alla Virginia Tech. Ma c’è poco di accademico, nel trattato, che si rivolge – come scritto nella prefazione – «A chi fa architettura: il tipo di architetto che il lettore troverà in queste pagine, ovvero una figura che opera con successo nel nostro mondo non-referenziale, è attuale ed è progressista, poiché mentore e mente direttiva di un team». Il linguaggio è diretto, paratattico, lavora per slogan, ripete spesso concetti, non indugia nella cura del dettaglio, non cerca facili suggestioni. Diviso in 12 capitoli, il testo ha 3 parti: la prima è una Introduzione all’Architettura Non-Referenziale, l’ultima un breve paragrafo dal titolo Autorialità. Ma è nella parte centrale che la teoria di Olgiati-Breitschhmid emerge con forza. I Principi dell’Architettura Non-Referenziale sono 7: esperienza dello spazio («Che un architetto sappia che tipo di spazio vuole progettare è importante anche per il processo creativo»), totalità («Oggi ogni edificio esiste per se stesso»), novità («oggi più che mai, un edificio deve essere in grado di esistere in modo indipendente, e questo richiede la presenza di una certa novità. È grazie a questa novità che diventa libero e indipendente. È tramite questa novità che coinvolge le persone»), costruzione («Gli edifici traggono vantaggio dal fatto di essere costruiti in un unico materiale, perché allora rivelano la propria intenzione formale senza possibilità di equivoci»), contraddizione («Le contraddizioni stimolano la gente rendendola creativa. Possiamo anche dire che una contraddizione è una strategia compositiva»), ordine («l’idea di un edificio è articolata prima di tutto da un sistema ordinatore»), produzione di senso («Un edificio non è l’applicazione meccanica di un ordine astratto, ma una formulazione produttrice di senso»). Più o meno convincenti, i singoli principi hanno il merito di definire un quadro riconoscibile. Sul ruolo dell’architetto («il segugio che cerca di scoprire come funziona il mondo») innanzitutto: «Perché un edificio sia un’opera culturale e sociale è necessaria la presenza di un architetto che metta in sinergia i diversi ambiti: intellettuale, spirituale, speculativo e creativo-sintetico».
I’m an architect è invece un saggio biografico che racconta del viaggio compiuto da Femia (1966) in 25 anni di carriera, dagli esordi genovesi dello studio 5+1 – poi trasformato in 5+1 Agenzia di Architettura – fino all’ultima tappa degli Atelier(s). È un libro nato dall’esigenza di rileggere il sedimento depositato su una lunga strada costellata da molti progetti rimasti sulla carta e da tante opere costruite. Perché è dal cammino percorso che si possono rintracciare i punti fondamentali del proprio modo di essere architetto, scorgere gli elementi ricorrenti che tracciano una sottile linea – a volte palese, a volte celata – che lega i tanti momenti di un mestiere che è anche un credo di vita. Il compito di rileggere l’opera di Femia è affidato a Paul Ardenne, storico, critico e curatore d’arte francese, già autore di monografie di celebrati architetti transalpini. La scelta di una voce esterna garantisce un’interpretazione non disciplinare, evita l’insidioso canto delle sirene autocelebrative e restituisce una letteratura che dovrebbe essere apprezzata anche dai non addetti ai lavori. Il libro si costruisce su un bilanciato rapporto d’immagini e testi: le prime sono tutte raggruppate in due repertori che aprono e chiudono il volume e che raccolgono una selezione di 32 progetti e realizzazioni. Il lasso di tempo considerato va dai Frigoriferi Milanesi (2002-08) al recentissimo concorso per la riqualificazione della prima Zecca d’Italia a Roma (2019). Le immagini delle opere hanno il duplice compito di testimoniare, da un lato, la prolifica produzione degli atelier di Genova, Milano, Parigi e, dall’altro, di offrire il giusto supporto iconografico alle considerazioni critiche. Gli otto capitoli firmati da Ardenne formano il cuore centrale della pubblicazione e focalizzano aspetti peculiari della maniera di fare architettura di Femia, senza dimenticare le implicazioni “umane” coinvolte dal mestiere. Ne emerge un’articolata riflessione che tocca temi fondativi che s’intrecciano sempre con la pratica del progetto e che si confrontano con le sfide della contemporaneità. Nella realtà di oggi, ci ricorda Ardenne, l’architettura è una pratica che ormai sfugge sempre più agli architetti. E in uno scenario complesso e contraddittorio l’opera prodotta in un quarto di secolo da Femia dimostra un impegno a perseguire una dimensione sentimentale, sospesa fra l’immaginario e il reale, da cui possa nascere un’architettura generosa e amichevole, inclusiva ed eticamente consapevole, che sia un dono per l’Uomo e per il territorio che la riceve. Un’architettura la cui essenza è rintracciabile nelle brevi righe scritte da Femia a margine dell’introduzione di Maurice Culot: «l’architettura non è un atto di servizio ma di sentimento… L’architettura deve esprimere la realtà e per questo abbiamo bisogno della ragione, ma anche del sentimento». Perché, come ricorda Leonardo da Vinci, «Ogni nostra cognizione principia dà sentimenti».
—
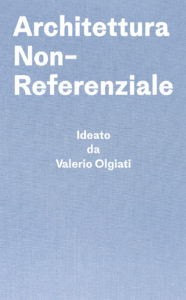 Architettura Non-Referenziale, di Markus Breitschmid e Valerio Olgiati, Park Books, 2019, 144 pagine, € 25
Architettura Non-Referenziale, di Markus Breitschmid e Valerio Olgiati, Park Books, 2019, 144 pagine, € 25
—
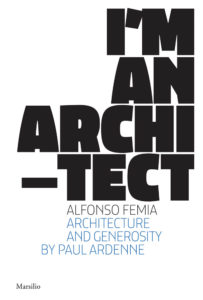 I’m an architect. Alfonso Femia. Architettura e generosità, di Paul Ardenne, Marsilio, 2020, 176 pagine, € 24
I’m an architect. Alfonso Femia. Architettura e generosità, di Paul Ardenne, Marsilio, 2020, 176 pagine, € 24
Per approfondimenti sull’attività di Alfonso Femia:























