Visita alla capitale dell’Islanda, un caleidoscopio di architetture, materiali e colori ancora sospeso tra fiaba e realtà, ma minacciato da sradicamento e anonimato
Reykjavík è stata a lungo una delle capitali europee più ignorate da chi abita nel continente, e spesso l’Islanda non compare neanche nelle mappe dei libri sulla storia d’Europa. Da sempre immaginate come un luogo mitico, dalle Operette morali di Giacomo Leopardi al Viaggio al centro della terra di Jules Verne, l’Islanda e la sua capitale hanno continuato a galleggiare in un mare di riferimenti fiabeschi, tra elfi e vulcani, fino ai giorni nostri. Ancora nei primi anni Duemila, l’Islanda era una terra lontana, fredda, costosissima, e quindi inaccessibile a molti. Poi, in poco tempo, si sono susseguiti due disastri: la crisi finanziaria del 2008, che ha determinato il crollo delle maggiori banche del Paese, e l’eruzione del vulcano Eyjafjallajökull nell’aprile 2010, che ha bloccato il traffico aereo europeo per alcuni giorni (la pronuncia corretta del nome del vulcano si può ascoltare qui). Entrambi gli eventi hanno portato Reykjavík e l’Islanda sulle prime pagine dei giornali internazionali, e soprattutto hanno aperto la strada a qualcosa che sembrava impossibile fino ad allora: l’inizio di un turismo di massa verso l’isola. Complici i prezzi ridotti nel periodo successivo alla crisi, le campagne pubblicitarie vincenti (il video promozionale di Inspired by Iceland è stato uno dei primi tentativi di richiamare turisti dopo la fastidiosa eruzione) e la natura mozzafiato dell’isola, l’Islanda ha richiamato a sé sempre più turisti, raggiungendo oltre due milioni di visitatori nel 2017.
Non solo natura
Il turismo in Islanda non è certo un fenomeno recente. Già gli studiosi dell’Inghilterra vittoriana erano affascinati dalla lingua e dalla cultura locali da spingersi a salpare verso nord: tra i viaggiatori più entusiasti troviamo anche William Morris, che nel 1871 e nel 1873 compie due viaggi nell’isola. La letteratura di viaggio, da parte di visitatori stranieri, è pressoché infinita, come attesta il lungo regesto bibliografico raccolto da Haraldur Sigurðsson nel 1991, in cui sono presenti esploratori, letterati, scienziati, e tante decine di curiosi e semplici turisti. È una letteratura che continua ancora oggi: solo in Italia, la casa editrice Iperborea (grazie al costante lavoro dei suoi traduttori, tra cui Silvia Cosimini) ha pubblicato in anni recenti numerosi testi sull’Islanda, che spaziano dalle leggende popolari a raccolte di saggi contemporanei di carattere socio-politico. Tuttavia, la quasi totalità dei resoconti di viaggio (e la quasi totalità delle occasioni turistiche offerte ai visitatori) riguarda la natura, le montagne, i ghiacciai, i vulcani. In realtà, grazie al supporto di centri di ricerca come The Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies e a numerosi musei locali, come il museo nazionale Þjóðminjasafn Íslands, gli islandesi stanno cercando di educare i visitatori al fantastico mondo delle saghe norrene e alla più che millenaria storia della colonizzazione dell’isola, avvenuta attorno all’874 da parte di popolazioni salpate dalle coste della Norvegia. Ultimamente, anche lo speciale panorama musicale è diventato un’attrazione turistica, complice il successo internazionale di artisti tra cui Björk e la band Sigur Rós, con partecipazioni sentite per festival come Iceland Airwaves e Secret Solstice.
—
E l’architettura?
La risposta pare averla già data il poeta Wystan Hugh Auden, scrivendo insieme a Louis MacNeice le sue Letters from Iceland nel 1937: «There is no architecture here». Nonostante la scarsa popolazione – poco oltre le trecentomila persone – e la lontananza dai centri del panorama internazionale, l’architettura islandese esiste eccome. La sua è un’affascinante storia di sopravvivenza, lotta contro gli elementi, autodeterminazione culturale e indipendenza politica. L’Islanda, infatti, nonostante la sempre maggiore autonomia politica e legislativa ottenuta a partire dal secondo Ottocento, è stata di fatto una colonia danese fino alla dichiarazione d’indipendenza nel 1944.
La quasi totale assenza di alberi sull’isola – si suppone che le foreste, che un tempo rivestivano circa il 40% della superficie, siano state abbattute dai primi colonizzatori, e ora ricoprono solo un 2% dell’intero territorio – ha da sempre causato una cronica mancanza di legno da costruzione. Al tempo stesso, il duro basalto islandese risulta una pietra troppo difficile da lavorare per erigere muri, e sull’isola non si trova argilla per la produzione di mattoni. Queste condizioni estreme hanno determinato un monopolio di quasi mille anni della costruzione in torba (la tradizionale baðstofa), con rari edifici in pietra realizzati dal governo danese, e costose abitazioni in legno d’importazione scandinava, spesso commissionate dai mercanti nei villaggi portuali e rivestite in lamiera dai colori vivaci.
La possibilità di costruire residenze in grado di proteggere tutti gli abitanti dall’umidità e dal freddo è emersa soltanto da fine Ottocento. Il cemento, importato dall’Europa e accolto letteralmente come «pozione magica», è diventato in pochi anni il materiale edilizio più diffuso nella capitale e in tutto il Paese. Il cemento, e quindi il calcestruzzo, è stato fin da subito adottato dai primi architetti attivi sull’isola a inizio Novecento, in particolare da Guðjón Samúelsson (1887-1950), primo islandese laureatosi in architettura e attivo come architetto di stato per tre decenni. Se l’identità islandese si è sempre fondata su valori linguistici e letterari – una lingua antica e una letteratura annoverata tra le grandi epiche della storia –, l’architettura è invece stata intesa come un fenomeno d’importazione. Negli anni tra l’autonomia politica del 1919 e l’indipendenza del 1944, Samúelsson ha avuto un ruolo chiave nella definizione di un’identità nazionale attraverso la costruzione di edifici pubblici che hanno trasformato un villaggio di pescatori e commercianti nella capitale di una repubblica. Il suo progetto più noto è la monumentale chiesa Hallgrímskirkja, che svetta sul centro città e si può scorgere a chilometri di distanza. Progettata negli anni ’30 e terminata solo nel 1986, essa è presto diventata l’edificio simbolo della capitale, grazie alla sua colossale facciata in calcestruzzo che imita le formazioni basaltiche dell’isola, come una gigantesca colata lavica che si è fatta architettura.
Ma la particolarità dell’edilizia islandese non sta solo nella lotta contro il vento e il freddo: l’assenza di una scuola di architettura locale, fino all’apertura di una laurea triennale in architettura presso Listaháskóli Íslands (Iceland Academy of the Arts) nel 2002, ha obbligato tutti gli aspiranti progettisti a formarsi altrove: inizialmente in Danimarca, poi in Germania, in Francia e oltre oceano, tra Canada e Stati Uniti. Questa diversità educativa può essere anche uno dei motivi per cui, in una lingua che cerca sempre di coniare termini d’etimologia norrena anche per neologismi o prestiti linguistici, la parola «architettura» è oggi quasi sempre traducibile come arkitektúr (anche se in passato si utilizzavano termini più locali, come byggingarlist, ovvero arte del costruire, o húsagerð, costruzione di case).
In un’isola dalla forte e omogenea identità culturale, l’educazione così eterogenea dei propri progettisti può apparire inaspettata. Ma è proprio questa varietà architettonica, dai risultati talvolta originali, talvolta stridenti, che si può percepire passeggiando per la capitale. Colorate ville in legno si alternano a residenze che sembrano uscite dal quartiere Weissenhof di Stoccarda o dall’Esposizione di Stoccolma; le monumentali e variegate costruzioni di Samúelsson stanno accanto ai progetti in calcestruzzo ben rifinito dello Studio Granda. Poco fuori dal centro, isolato e luminoso, si trova il centro culturale Norræna Húsið (Nordic House), unico progetto di Alvar Aalto nell’isola, costruito nel 1968. Nonostante i vasti sobborghi di villette prefabbricate che emergono dai campi di lava, il centro di Reykjavík è un sorprendente caleidoscopio di architetture, materiali e colori che rende unica questa piccola e vivace capitale, ben diversa dalle cugine Copenaghen, Stoccolma e Oslo. Senza dubbio l’architettura di Reykjavík riflette la posizione geografica dell’isola, tra l’Europa e l’America, in un oceano Atlantico molto più denso di relazioni culturali e materiali di quanto si possa pensare.
Nel pieno della crisi economica, un ulteriore elemento è stato aggiunto al mosaico di Reykjavík: la trasparente opera house Harpa, collocata sul mare, nel vecchio porto. Progettato da Henning Larsen Architects, l’edificio è interamente rivestito da pannelli tridimensionali in vetro, realizzati insieme all’artista danese-islandese Ólafur Elíasson, che trasformano la struttura in un gigantesco cristallo – d’altronde l’isola per secoli era nota grazie alla produzione del cristallo d’Islanda, in inglese Iceland spar, largamente usato nella produzione di lenti da ottica. Harpa è nata come un’opera ambiziosa, pensata prima della crisi e inaugurata nel 2011, e fin da subito è stata interpretata come il simbolo della ripresa economica, che ha portato Reykjavík in pari con le altre capitali nordiche e i loro maestosi teatri d’opera sull’acqua.
Costruire nel boom (verso un turismo in decrescita)
Ma che cosa accade oggi a Reykjavík, a un decennio dalla crisi e con un turismo che ogni anno porta sull’isola un numero di persone pari a almeno sei volte la popolazione locale? Da un lato, la Reykjavík del turismo è una città piena di risorse e opportunità, restauri di monumenti storici e recuperi di vecchie fabbriche (come il recente recupero della Marshallhúsið sul porto, firmato dallo studio locale Kurt og Pí).
Tuttavia, l’immediata disponibilità di denaro dovuta al boom turistico ha determinato alcune scelte affrettate. Tra queste vi è la costruzione di interi nuovi quartieri, tra cui uno collocato a sud del centro, accanto all’autostazione e all’aeroporto, e un altro a nord, lungo i moli del vecchio porto. In questi mesi sta infatti emergendo una lunga serie di edifici modaioli e mediocri, se possibile ancora più anonimi delle villette prefabbricate nelle periferie, che sembrano pescati a caso dalle bacheche online di Dezeen o Archdaily. Alcuni cantieri sono conclusi, altri in stallo da tempo: le stime di crescita dei visitatori internazionali sono infatti calate nell’ultimo biennio (complici la stessa ripresa economica e l’alto costo della vita, oltre al recente fallimento della compagnia aerea low cost WOW Air), e alcuni costruttori hanno così deciso di rallentare i lavori.
Rimarranno hotel e appartamenti vuoti? Saranno riconvertiti in studentati e residenze per giovani? (L’aumento degli affitti, a causa del fenomeno globale di Airbnb, ha reso quasi impossibile trovare alloggi per giovani e studenti nel centro storico). Di sicuro questi edifici avranno per sempre bloccato parte della vista panoramica sul vecchio porto e sui fiordi innevati che svettano oltre la baia Faxaflói.
Ad aggiungere un elemento surreale alle attuali vicende costruttive, poco lontano dai cantieri di nuovi hotel e negozi di moda del porto, si trova un altro cantiere, il cui cartello di costruzione recita: «Rebuilding of Hafnarstræti 18. The house is actually two buildings originating from the years 1795 and 1799. It was rebuilt in 1924. Current construction will restore the building to the drawings from that time. Same building material and construction methods will be used as in the original buildings». Questa iniziativa sembra fare eco a un dibattito di pochi anni fa, in cui si proponeva di riesumare un progetto di Samúelsson per l’ampliamento del palazzo del Parlamento, in occasione dei cento anni d’autonomia politica islandese (proposta in seguito abbandonata).
Tali iniziative anacronistiche fanno forse sorridere, ma riflettono una delle più grandi paure per la Reykjavík di oggi, e forse per qualsiasi città contemporanea invasa da un turismo fuori scala: la perdita dell’individualità storica e culturale, e l’appiattimento di ogni nuova costruzione a un ripetuto modello prevedibile e senza radici.
Identità vs omologazione
La Reykjavík del 2019 è ben diversa dal piccolo villaggio di pescatori visitato da Morris, o dalla cittadina anonima ridicolizzata da Auden. Ormai la capitale d’Islanda è una città cosmopolita e multiculturale, la cui struttura riflette una storia stratificata, dall’ottenimento dello status di kaupstaður (luogo per il commercio) nel 1786 fino a oggi: dalle prime case in legno al piccolo duomo, costruito e ricostruito dai danesi lungo tutto l’Ottocento; dalla costruzione del porto tra il 1913 e il 1917, all’occupazione britannico-statunitense a partire dal 1940, fino ai grattacieli simbolo del boom economico pre-crisi. Reykjavík è da sempre in balìa delle disponibilità economiche e, come tante città turistiche, deve ora affrontare il maggiore dei problemi, ovvero la perdita della propria identità. L’eclettica mixité architettonica che ne contraddistingue il centro è figlia della sua storia costruttiva e delle diverse geografie in cui i suoi professionisti si sono formati. I nuovi quartieri in costruzione, ironicamente destinati a rimanere vuoti e disabitati, fanno ricadere interi pezzi di città nell’anonimato, distruggendo qualsiasi orientamento di spazio e tempo.
Negli ultimi anni, una delle principali preoccupazioni dell’Islanda è la minaccia d’impoverimento della sua millenaria lingua, resa sempre più vulnerabile dall’onnipresente inglese portato dai turisti e dai media (e da altre ragioni, tra cui l’assenza di traduzioni in islandese per alcuni servizi tecnologici, come i sistemi operativi degli smartphone). Così come accade in tanti contesti a noi più vicini, questo impoverimento di significati abbraccia anche il costruito, trasformando l’architettura della città in un collage di render che, prendendo forma, deludono le aspettative e cancellano le differenze a qualsiasi latitudine.
Nello speciale caso di Reykjavík e dell’Islanda, la speranza è riposta sulla costante curiosità e creatività dei suoi abitanti: nonostante l’isolamento atlantico, nella lingua, nella storia dell’arte e della letteratura (e quindi, si spera anche in futuro nella costruzione della città), gli islandesi sono sempre stati in grado di accogliere e assorbire le influenze esterne pur rivendicando un forte sentimento d’identità culturale. Un’identità comune che va ben oltre la natura da cartolina fotografata dai turisti, e che, oggi come nell’epoca vittoriana, continua ad affascinare chi ne studia la storia.




About Author
Tag
ritratti di città
Last modified: 28 Maggio 2019
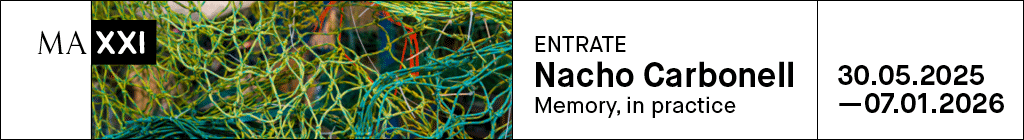


































[…] article originally written in Italian for Il Giornale dell’Architettura (The Architectural Post) by Sofia […]