Quattro nuovi volumi indagano la fenomenologia dell’abitare
—
Non c’è parola che abbia eccitato di più la fantasia di architetti e studiosi. Non stupisce così che nella pubblicistica di settore siano molti i titoli a comprenderla, con diverse sfumature e intensità. La usa Richard Sennet nel terzo e ultimo libro della sua trilogia dedicata al “ruolo dell’Homo faber nella società”. La titolazione originale Building and dwelling diventa nella pubblicazione Feltrinelli Costruire e abitare. Etica per la città. Opera densa, colta, caratterizzata da una struttura complessa, articolata in tre parti (Le due città, Le difficoltà dell’abitare, Aprire la città) e nove capitoli. Complessità – in parte dovuta anche ad un italiano, frutto della traduzione, non particolarmente lineare e scorrevole – che restituisce molteplici livelli lungo i quali l’autore, sociologo, legge le forme urbane e architettoniche da un punto di vista traslato rispetto alla disciplina. Così il racconto, intenso e a tratti coinvolgente, spazia per luoghi e città (con una predilezione per realtà “povere” e in forte cambiamento, dal Sudamerica all’India), citando – in una forma quasi orizzontale, a-gerarchica – i maestri del Moderno così come progettisti contemporanei, al pari di filosofi, sociologi, storici. È un dipinto degli ambienti contemporanei (o meglio delle sue molteplici espressioni) tratteggiato da un “flaneur a spasso per il mondo”. Un mondo agitato da fenomeni enormi (le immigrazioni, la digitalizzazione, i cambiamenti climatici) ma che non impedisce di trarre lezioni universali: abitare oggi, e farlo eticamente, significa – nella prospettiva di Sennet – accettare la sfida dell’apertura e mette progettisti e pianificatori in un ruolo molto meno isolato, più a contatto con la società: «Una “ville” aperta evita di fare l’errore della ripetizione e della forma statica; creerà le condizioni materiali in cui gli individui intensificheranno e approfondiranno l’esperienza della vita collettiva».
Analogo taglio trasversale caratterizza il testo Psicologia dell’abitare. Scritto dallo psicologo Tommaso Filighera e dalla comunicatrice Alessandra Micalizzi, denuncia già nel sottotitolo la multidisciplinarietà dell’approccio: Marketing, Architettura e Neuroscienze per lo sviluppo di nuovi modelli abitativi. Pur non rinunciando in apertura del primo dei sei capitoli all’immancabile citazione heideggeriana, il volume ha il merito di focalizzare, scalarmente, un tema (l’atto dell’abitare e la casa, come luogo deputato a farlo) e di affrontarlo da prospettive diverse. Così da ribadire il valore e il ruolo del progetto («l’esperienza architettonica è talmente pregnante per la vita umana da permearne l’esistenza»), ma al tempo stesso di introdurre una serie di altri fattori che lo devono condizionare: «perché l’oggetto venduto non è semplicemente uno spazio ma un modo di abitare, un modello, uno stile, che prescinde l’aspetto funzionale e intercetta quello valoriale». Da questo quadro emerge una serie di condizioni innovative per l’abitare contemporaneo, capace di trasformare nel profondo i suoi modelli e i suoi riferimenti; in particolare le relazioni che la “macchina per abitare” è oggi chiamata a sviluppare con i contesti fisici e sociali in cui si colloca.
Tema indagato in un altro libro, che ugualmente nasce nell’ambiente del Politecnico milanese, scritto da Stefano Guidarini, volume inaugurale della nuova collana Biblioteca Universitaria di Skira. La prima delle tre parti è un excursus storico disciplinare sui rapporti tra edilizia residenziale e spazio pubblico, in una prospettiva dichiarata chiaramente dall’autore quando scrive «l’abitare contemporaneo ha bisogno di ritrovare il proprio rapporto con la città, soprattutto nel momento storico attuale ossessionato dalla sicurezza». Il secondo capitolo è una lettura di sei casi studio svizzeri, tutti costruiti a Zurigo. Nel terzo e ultimo, New Urban Housing sembra tirare le somme del percorso concludendo che «sembra emergere un nuovo paradigma nella progettazione della residenza, sulla base di criteri che tendono a privilegiare una sorta di situazionismo distributivo rispetto alla purezza tipologica».
Torna ad ampliare il concetto di abitare (quindi non solo housing) il libro, molto più personale e soggettivo, di Raffaele Marone. Ovunque è architettura. Fatti dello spazio che abitiamo è un diario dei sentimenti, una raccolta di sensazioni, una sequenza di immagini. I sette capitoli diventano un espediente per provare a mettere ordine ad un flusso di pensieri e di esperienze inteso come occasione per posizionare l’abitare (nel senso più ampio e inclusivo) al centro dell’osservazione di un architetto.
 Costruire e abitare. Etica per la città, di Richard Sennet, Feltrinelli, 2018, 368 pagine, € 25
Costruire e abitare. Etica per la città, di Richard Sennet, Feltrinelli, 2018, 368 pagine, € 25
—
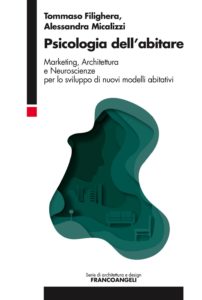 Psicologia dell’abitare. Marketing, Architettura e Neuroscienze per lo sviluppo di nuovi modelli abitativi, di Tommaso Filighera e Alessandra Micalizzi, Franco Angeli, 2018, 128 pagine, € 17
Psicologia dell’abitare. Marketing, Architettura e Neuroscienze per lo sviluppo di nuovi modelli abitativi, di Tommaso Filighera e Alessandra Micalizzi, Franco Angeli, 2018, 128 pagine, € 17
—
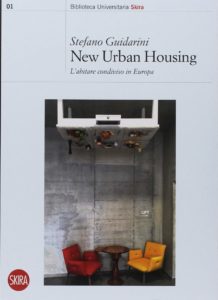 New Urban Housing. L’abitare condiviso in Europa, di Stefano Guidarini, Skira, 2018, 176 pagine, € 25
New Urban Housing. L’abitare condiviso in Europa, di Stefano Guidarini, Skira, 2018, 176 pagine, € 25
—
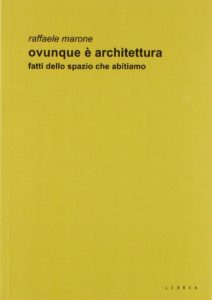 Ovunque è architettura. Fatti dello spazio che abitiamo, di Raffaele Marone, LIBRIA, 2018, 184 pagine, € 18
Ovunque è architettura. Fatti dello spazio che abitiamo, di Raffaele Marone, LIBRIA, 2018, 184 pagine, € 18

























