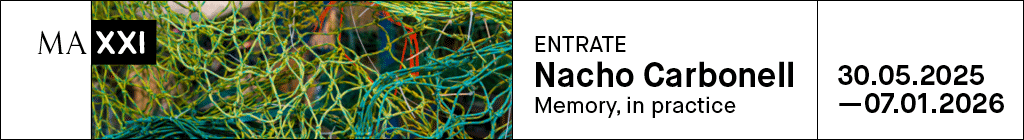Un commento a proposito del recente programma per i Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale bandito dal MIUR a fine dicembre
Esistono forme di provincialismo che fanno tenerezza. L’immagine più icastica resta quella di Alberto Sordi e Anna Longhi in visita alla Biennale d’Arte veneziana (1978). Altre sono tristi, alcune fanno soprattutto pensare. Che il provincialismo potesse toccare il sacro tempio dell’Università, solo un’idea radical chic della cultura poteva escluderlo. Che a promuoverlo fosse un ministro, forse nessuno poteva ipotizzarlo. Un ministro preceduto da un numero non piccolo di rettori, per altro.
La questione non è la difesa della lingua. Se ha bisogno d’essere difesa, una lingua è quasi morta. I nodi sono altri e non tanto complessi da capire anche per rettori e ministri. L’Italia ha un debito di attrazione. Tradotto in parole semplici, in Italia vengono a studiare e insegnare un numero insufficiente di studenti e studiosi e soprattutto pochi si fermano o vi si stabiliscono: ed è quello il nodo vero che va di pari passo con un’altra politica, se vogliamo orgogliosamente chiamarla così.
L’Italia sta imparando a valorizzare i suoi “tesori artistici e paesaggistici”: torna ad essere un paese da “visitare”. Un’Italia da “consumare”, riprendendo un lontano slogan coniato per Milano, ma in cui non si deve venire, se si studia e soprattutto se si fa ricerca! E, cosa ancor più grottesca, non si riesce a diventare paese leader neanche nello studio, gestione e conservazione di quel patrimonio che attira tanti visitatori. Un’Italia del consumo incapace di trasformare una straordinaria opportunità in una vera politica di ricerca, industriale, occupazionale. Un’Italia da bere e non in cui studiare, ricercare, risiedere. E qui il sottofondo provinciale (e un po’ razzista… al contrario) del recente bando PRIN o delle politiche di tanti rettori italiani emerge drammaticamente.
Una ricerca sui beni culturali richiederebbe non solo una conoscenza approfondita di manufatti, opere, paesaggi che senza la conoscenza della lingua rimarrebbero simulacri, ma domanda anche una collaborazione sino a pochi anni fa impensata: dalla scienza dei materiali alla biologia molecolare, dall’informatica alla virtualità, dalla storia delle culture materiali e dei mestieri alla capacità di narrare dal progetto agli usi. E tutto rispetto a universi culturali in cui non solo la lingua è essenziale, ma in cui lo sono persino i dialetti! Non solo. Creare comunità di studiosi che vivono (e godono per primi) di luoghi e opere, significa creare una rete di relazioni che arricchirà città, scuole, ambienti e vite quotidiane. E creerà forme di vita cosmopolita dove la vera ricchezza sarà sapere “tradurre”, non parlare una nuova lingua di corte: e non uso a caso questo termine.
Questa riflessione non vale solo per il mondo dei beni culturali, materiali e immateriali; vale per altri settori della vita economica e sociale italiana. Un ministro che chiede di presentare i PRIN nella lingua di corte, e i rettori che dimenticano la lezione dei più grandi linguisti del XX secolo – quel che “lucida” i neuroni dei nostri studenti è saper tradurre – sono solo tristi conformisti dallo sguardo abbassato e subalterno. Se uno studente cinese o uno studioso sudamericano dopo un anno di presenza in Italia non conoscono a sufficienza la nostra lingua, che legami istituiranno con il territorio, i cittadini, le imprese? E come rientreranno a casa loro, visto che in Italia torneranno da turisti?
Il problema non è quello posto dall’Accademia della Crusca, ma quello delle comunità scientifiche e dei loro territori fisici e sociali, della capacità di trasformare “tesori” in opportunità, di una società capace di “parlare” una lingua e di saper tradurre, entrando così nelle differenze e non in un piatto e conformista multiculturalismo.
Immagine di copertina: Jean Le Tavernier, Jean Miélot nel suo scrittorio (miniatura, seconda metà del XV secolo; © Bibliothèque nationale de France)