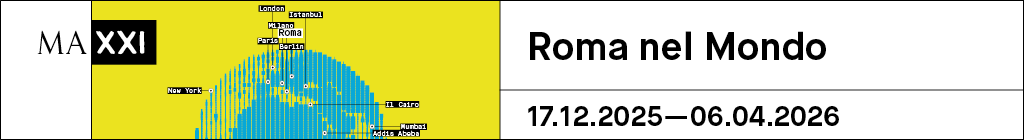Lo studio catalano di Rafael Aranda, Carme Pigem e Ramon Vilalta (semi-sconosciuto solo ai mal informati) vince il più ambito premio per l’architettura grazie alla potenza dei media e ad un corpus di opere concentrato territorialmente (ma in realtà molto “global”)
—
Ha scritto Oliver Wainwright sul “Guardian” che il Pritzker di quest’anno è stato assegnato a uno studio “semi-sconosciuto” ma, detto tra noi, se siete architetti e fino a pochi giorni fa non sapevate chi fossero gli RCR… è che eravate mal informati. Il trio catalano, infatti, sforna edifici di grande interesse sin dalla fine degli anni novanta, tant’è che in poco meno di trent’anni di attività (è il 1988 quando Rafael Aranda, Carme Pigem e Ramon Vilalta fondano il loro studio a Olot, in provincia di Girona) sono stati dedicati loro ben tre numeri del mitico “El Croquis”, la più agognata tra le riviste monografiche di architettura – e si dice che ce ne sia in cantiere un quarto già da un pezzo. Si dice anche che i suddetti tre numeri se li siano pagati interamente di tasca loro: cosa che non mi stupirebbe, data la loro attenzione maniacale a tutti i dettagli della professione, inclusa la presenza nei media che contano.
Gli RCR erano anche alla Biennale di Venezia del 2012, tra l’altro: quella di David Chipperfield e del “Common Ground”. Non già all’interno di “Vogadors”, il padiglione “contro corrente” della Catalogna nel quale si celebrava la materialità, il rapporto con il contesto, la precisione nell’esecuzione e le realtà emergenti; bensì all’interno di SpainLab: il padiglione filogovernativo curato da Antón Garcia-Abril. Sì, proprio quel Padiglione Spagna: quello che faceva finta che la crisi, che da quattro anni stringeva l’economia iberica in una morsa mortale, non esistesse affatto, esponendo una serie di costose e un po’ strampalate installazioni progettate da un ristretto gruppo di studi ben inseriti nell’establishment della peninsula. Tra queste, la dissezione di un water a scomparsa che si può trovare oggi, opportunamente riassemblato, nel gabinetto dello studio degli RCR.
Io l’ho visto, quel super vespasiano, mentre ruotava su se stesso e si nascondeva all’interno delle pareti in corten del piccolo bagno del Laboratorio Barberi, trasfigurandolo così in uno spazio geometricamente perfetto: bruno e freddo come le lastre d’acciaio che lo rivestono. Non che servisse a qualcosa, lo spazio improvvisamente liberato: però vuoi mettere trovarsi all’interno di un volume puro, senza una tazza che ti osserva?
In quel preciso momento ho capito che l’approccio all’architettura degli RCR, che da studente ho amato e copiato – sono infatti autori di alcuni progetti di grande poesia, come il parco della Pedra Tosca, la cantina di Bell-Loc e lo spazio La Lira – è più ambiguo di quanto pensassi. Perché, dietro a progetti apparentemente minimalisti, si nasconde in realtà un formalismo estremo (lo spazio vuoto per lo spazio vuoto), il cui fascino si basa, a mio parere, sull’aver coltivato con cura almeno tre rapporti fondamentali: quello con i dettagli di Mies (il Mies del Seagram, però); quello con la land art di Richard Serra; e quello con la reflex di Hisao Suzuki, fotografo ufficiale degli RCR e di El Croquis, i cui scatti magistrali sono probabilmente responsabili di buona parte del loro successo.
Lo dico perché l’estate scorsa ho visitato una mezza dozzina di loro progetti – pochi dei migliori, purtroppo – e posso garantire che tra l’esperienza in prima persona dell’architettura di RCR e quella filtrata dal sapiente occhio di Suzuki c’è un divario incolmabile. Del resto, che la fotografia possa essere usata come strumento di propaganda, era cosa già ben nota a Le Corbusier, che senza troppi indugi ritoccava le immagini dei propri edifici perché se ne vedessero esclusivamente le parti che gli interessavano. Se aggiungiamo poi che certe scelte progettuali degli RCR, estremamente fotogeniche – come la copertura trasparente del ristorante a Les Cols o la pavimentazione in ferri di armatura del campo di atletica a Olot – si rivelano in realtà ben poco funzionali (pare che la Carpa sia una serra, e avete mai provato a camminare su dei tondini d’acciaio quando piove?), è difficile non pensare che l’entusiastica ricezione dei loro edifici sia più legata alla bellezza delle loro foto, all’atmosfera che comunicano, che a una loro reale comprensione.
Detto questo: gli RCR sono dei bravissimi architetti, che hanno saputo trovare un loro linguaggio (forse un po’ ripetitivo) e costruire nel tempo un corpus di opere degno di grande attenzione – a patto di chiudere un occhio davanti agli edifici meno riusciti, come l’Università a Girona o la casa per il carpentiere a Olot. Ma è forse sufficiente essere dei “bravissimi architetti” per vincere il Pritzker?
Il problema sta a monte, e ha a che fare con le aspettative che un premio promosso da una catena alberghiera ha il diritto di generare. Nella pagina web del Pritzker si legge che l’obiettivo del premio è quello di «onorare un architetto o un gruppo di architetti viventi la cui opera costruita dimostri una combinazione di talento, visione e impegno tali da aver offerto un contributo significativo all’umanità e all’ambiente costruito». Se le cose stessero davvero così, avrebbe senso parlare del Pritzker come del “Nobel dell’architettura”, come viene normalmente definito. Ma chi se la sente di affermare che gli RCR (o Alejandro Aravena, Wang Shu, Toyo Ito o Christian de Portzamparc) hanno offerto “un contributo significativo all’umanità”? Quella del Nobel dell’architettura, in sostanza, sembra più che altro una trovata di marketing, con degli effetti collaterali non da poco, tra l’altro: forse sarebbe il caso di rinominare il Pritzker “l’Oscar dell’architettura”, o il Pallone d’oro… fate voi.
Ciò che più mi interessa, comunque, è la retorica che è stata costruita attorno alla premiazione di quest’anno: sia dalla giuria del premio, sia dai giornalisti e commentatori che si sono espressi negli ultimi giorni. Due sono le linee narrative cui si è fatto principalmente ricorso, per appoggiare le ragioni della scelta della giuria: da un lato, la capacità degli RCR di operare localmente pur sviluppando un linguaggio architettonico internazionale; dall’altro, il fatto di non aver premiato la solita “archistar”, e dunque di aver preso una posizione etica ben precisa nei confronti della professione. Discorsi che, per quanto mi riguarda, non sono altro che ideologia allo stato puro.
Entrambi, infatti, nascondono il medesimo desiderio di sostituire un’idea di architettura ritenuta problematicamente “globale”, con un’altra che si appoggi a valori più rassicuranti, legati a un immaginario di realtà locale, piccola e artigianale (lo studio semi-sconosciuto di modeste dimensioni, che opera nella Catalogna rurale producendo edifici che si ancorano, fisicamente e simbolicamente, al territorio). A tale immaginario, guarda caso, attingono oggi compagnie come la Moretti, che per diversificare i propri prodotti ha recentemente lanciato una linea di birre “regionali” arricchite da sapori legati ai territori italiani, le cui etichette comunicano lo stesso tipo di artigianalità fasulla (continuano infatti a essere birre prodotte industrialmente) che i media stanno ora associando agli RCR, le cui architetture sono infatti pesantemente industriali. Il desiderio latente di un (finto) ritorno del local, in questo senso, non è altro che l’ennesima moda cui la cultura architettonica sta (nuovamente) andando incontro.
Come se non bastasse, il fatto che l’assegnazione del premio sia motivata a partire da tale ritorno, non fa che svilire, con un colpo solo, sia l’opera degli RCR sia il Pritzker stesso. Se la prima, infatti, non è semplicemente riconducibile a una versione contemporanea del regionalismo critico di Kenneth Frampton, il secondo dovrebbe perseguire con maggior coerenza le proprie ambiziose premesse. Tutto sommato, il commento della giuria del “Nobel dell’architettura”, non dovrebbe essere altro che “chapeau!”
Immagine di copertina: Rafael Aranda, Carme Pigem e Ramon Vilalta (foto © Javier Lorenzo Domínguez)