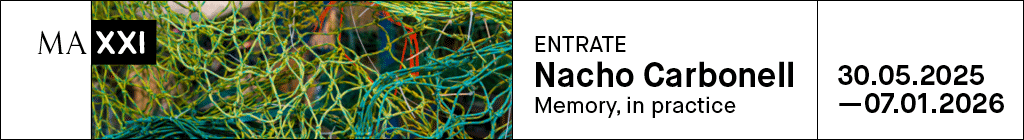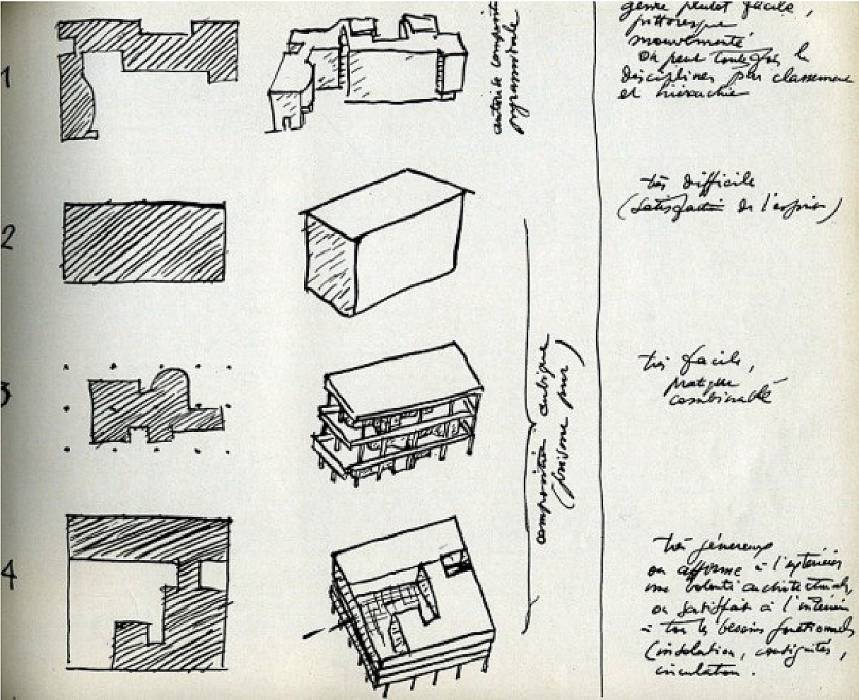Quando Jorge Luis Borges nel 1926 scriveva la quasi omonima raccolta di riflessioni, in Italia cera un’unica Facoltà di Architettura, quella romana. Quella raccolta uscirà postuma e, con macabro sarcasmo, si potrebbe avvicinare questo destino a quello che sembra profilarsi per le scuole di architettura italiane: essere tra un po’ quasi un ricordo.
E, seguendo la parafrasi, mentre il progetto di suicidio per Borges resterà incompiuto, come ricostruisce nella sua biografia Total Marcos Ricardo Barnatan, le scuole di architettura si stanno avviando, come un’allegra armata Brancaleone a una rapida eutanasia.
Chi scrive era presidente della Conferenza dei Presidi quando, nel 2007 e non certo un secolo fa, le facoltà di Architettura erano arrivate allimprobabile numero di 26 e i corsi di laurea in Ingegneria edile-architettura a 23. Sembrava un ballo Excelsior cui tutti potevano essere invitati.
Sette anni dopo, grazie a leggi via via più grottesche, dove a far premio era laggregazione – con un altro paradosso questa volta propriamente Melvilliano, quello delleroe del Benito Cereno – è in atto una rincorsa a trovarsi unaltra patria: che sia lantica Ingegneria civile o i più recenti e seducenti Disegno Industriale, variamente nominato, o Patrimoni (materiali e immateriali), poco importa.
Trionfo in questo di una malattia che ha intaccato la memoria breve delle Università, davvero colpita da improvviso Alzheimer: è infatti del 1999 la legge sui grandi atenei che a fronte di un dichiarato fallimento, didattico e democratico, di aggregazioni troppo ampie, dava lavvio a duplicazioni di sedi, purtroppo gestite troppo spesso con logiche puramente localistiche.
Nel più totale silenzio, la geografia delle scuole di architettura si sta avviando a una riduzione casuale, legata a storie tutte locali, senza che un problema così centrale per la qualità della vita dei cittadini – la progettazione degli ambienti di vita, di cura, di formazione e perché no di gioco, – sia stato oggetto della benché minima discussione.
Non solo grande è bello, ma anche Dio gioca a dadi non rimane più un interrogativo di Albert Einstein, ma la filosofia delle scuole che a preparare qualche buon laureato dovrebbero pensare. Così oggi resistono scuole di architettura a Venezia, Milano, Torino, Roma 3 (che sta conoscendo un cambio generazionale ancor più drastico di quello in atto in altre sedi), Palermo, altre sopravvivono con sempre maggiori, diverse contaminazioni a Firenze e Roma, mentre sussistono alcune piccole sedi rimaste al di fuori dei giochi delloca delle aggregazioni.
Una geografia che se fosse nata da logiche, pure fuzzy, sarebbe stata non solo discutibile ma, credo in larga misura comprensibile: 49 sedi dove si formavano progettisti forse neanche il Gargantua accademico, quello reso emblematico dai concorsi con tre idonei, se lo sarebbe immaginato.
Il nodo è che anche nelle sedi in cui Architettura rimane, i progetti culturali, scientifici, professionali sono scarsamente leggibili, contaminati da un lato dal fascino del mercato delle immagini e dalle luci di ribalte più o meno durature (con in testa una tecnologia quanto meno in crisi da decenni nelle Facoltà di Architettura), dall’altro da un matrimonio davvero contro natura tra diritto e specialismi costruttivi e impiantistici, ambientali ed economici.
E vero che quello che è stato il dna delle facoltà di architettura italiane, il dialogo tra composizione e storia è in crisi da tempo, vittima di una scarsa capacità di contestualizzare e storicizzare in senso alto i saperi, le tecniche, le scelte progettuali e urbane. Ma il destino dellimprendibile agrimensore del Castello di Kafka aleggia con una certa inquietudine nei cieli non sereni delle scuole di architettura italiane.
Se la crisi edilizia è unautentica nuova mise en intrigue di valori (economici, sociali, culturali), la crisi delle scuole di Architettura è in primo luogo la testimonianza dell’incapacità di fare della conoscenza un veicolo di rinnovamento culturale prima che economico, morale prima che politico.
Nel nostro modesto spazio, questo non vuol essere che il primo intervento si spera di una serie che rimetta al centro un destino non fatalistico e il ritorno a un’etica della responsabilità.
Riflessioni
Le considerazioni di Gabriele Pasqui