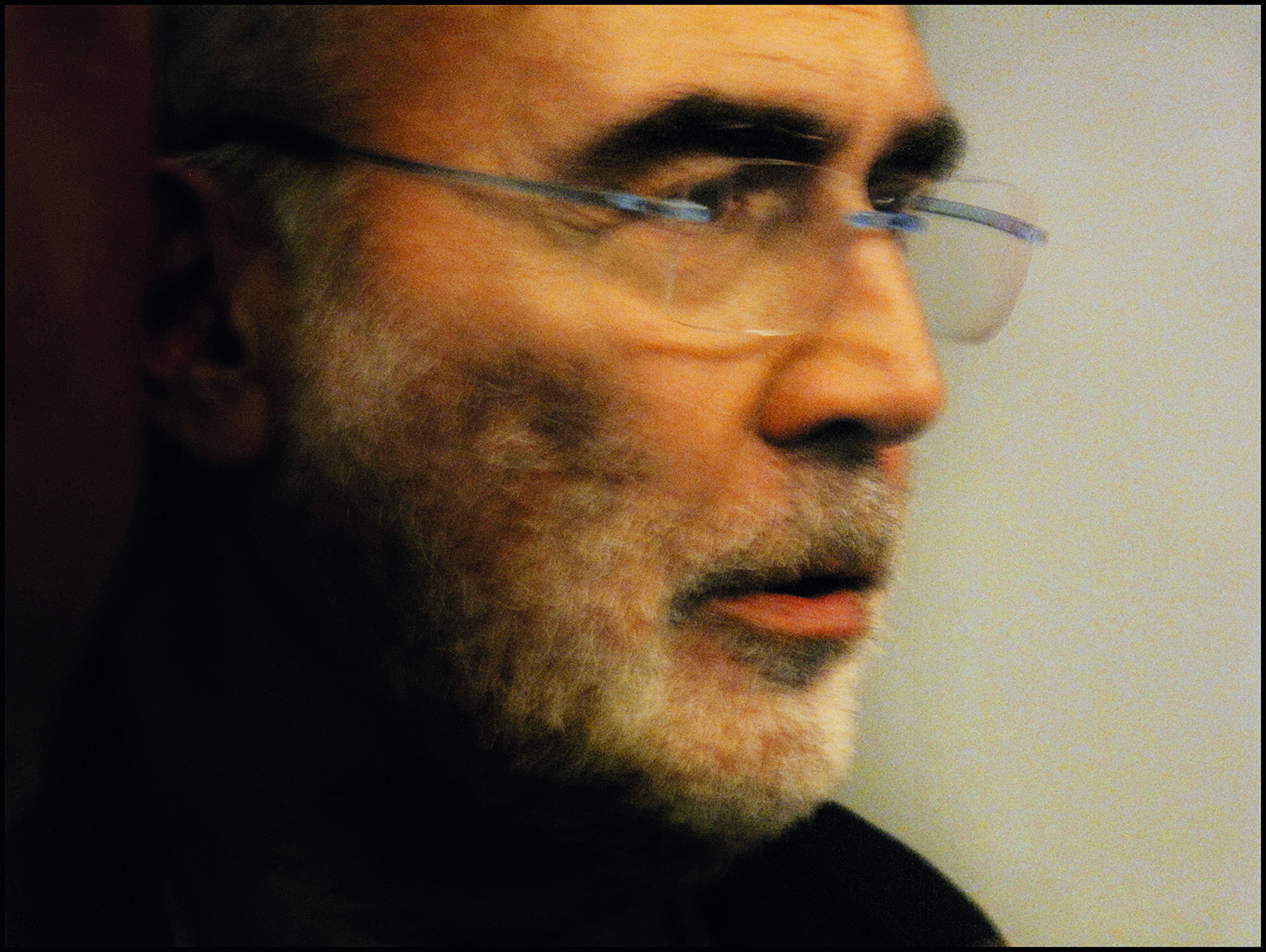Gabriele Basilico, classe 1944, architetto formatosi al Politecnico di Milano nel clima della contestazione universitaria, è stato il fotografo italiano ed europeo che ha coniugato il binomio architettura-fotografia. Fin dallinizio i soggetti delle sue fotografie sono infatti le architetture, le città, i porti, i paesaggi antropizzati.
Erede della tradizione dei fratelli Alinari e di Charles Marville (che fotografò le trasformazioni parigine del barone Haussmann) piuttosto che dellaltro grande fotografo «parisien», Eugène Atget, ha contribuito con la sua fotografia analitica a raccontare gli spazi. Questo accadde per le committenze pubbliche come la «Mission Photographique de la Datar» (1984) sulle trasformazioni in atto sul territorio francese, o le autoproduzioni come «Ritratti di fabbriche», dove, nel 1978, ritrae gli insediamenti industriali periferici milanesi. Le prime commesse delle riviste di architettura, lo stretto rapporto con «Domus», Alvaro Siza, Aldo Rossi e Stefano Boeri fanno di Basilico il fotografo di architettura più noto. Il suo lavoro sinserisce in un panorama di autori che vanno da Yukio Futagawa, fondatore della rivista «GA», a Julius Shulmann, il fotografo che rese celebri i case studies e le architetture mid-century californiane. Ma il fotografo milanese, a differenza dei suoi illustri predecessori, non si limitò alla fotografia di architettura in senso letterale, propose bensì una fotografia autoriale che nasceva dallaver studiato lopera di Walker Evans e, successivamente, dei coniugi Becher. Una fotografia che ha condizionato lo sguardo di generazioni di fotografi, scrivente compreso, nel descrivere le architetture in bianconero.
Proprio larchitettura ritratta per le riviste diventa un veicolo importante nella diffusione delle opere degli architetti. «Fotografare unarchitettura è come fare il ritratto di una persona», scrive Basilico in Architetture, città, visioni, «spesso è più importante quello che si nasconde rispetto a quello che si vede […] Latto del fotografare ci aiuterà a capire la forma semplice o complessa dei luoghi a coglierne analogie o differenze fino a illuderci di poter possedere e manipolare il reale attraverso la sua immagine».
Col tempo il linguaggio degli esordi, espressivo e formale, era divenuto più asettico nelle tonalità dei grigi e nel passaggio al colore, fino ad allora usato solo per i redazionali. Negli ultimi anni, con lavvento dei fotografi globetrotter e il cambiamento del mercato editoriale dellarchitettura, erano diminuite le commesse delle riviste e il suo interesse era sempre più orientato, come in una magnifica ossessione, sulle città, da Roma a Mosca.
Leredità che lascia Basilico è uno straordinario atlante di spazi, architetture famose e ignote, periferie e paesaggi che ci aiutano a comprendere meglio il mondo, senza pregiudizi ma con una curiosità nel lasciarsi sorprendere ancora dai luoghi.
Nelle sue fotografie architettura, città e paesaggi erano antropizzati