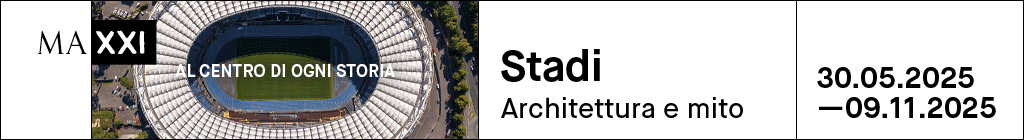Invitato a Perugia il 20 maggio nellambito della iniziativa «Larchitettura che cambia», Will Alsop ha tenuto una lectio magistralis dal titolo «Red, green & blue», unoccasione per riflettere sullarchitettura di questo maestro nel riscrivere il linguaggio high tech con quella libertà che, in ambito anglosassone, con esiti altrettanto individuali e anticonvenzionali, ricorda James Stirling. La personale rielaborazione tra architettura, arte e tecnologia di un edificio griffato Alsop si deve anche a una concezione costruttiva che consente di scomporre ledificio nelle sue componenti strutturali, funzionali e artistiche, pensate quasi come layer di un software, cioè autonome e integrate al tempo stesso. Lelemento generatore è la scatola («the box») a cui sottrarre o addizionare volumi, anche come scenografici pod, le capsule autoportanti sospese nello spazio con cui Alsop spesso «firma» i suoi progetti. Daltro canto, se questo è vero per le opere realizzate in Gran Bretagna, i masterplan per le città cinesi di Pechino, Shanghai, Chongquing, Haikou, Langfang e Zhuhai rivelano oggi uninterdisciplinarietà ancora maggiore. Daltronde, la libertà creativa, lassenza di significati prestabiliti e di teorie è un obiettivo progettuale che Alsop persegue da sempre. Unarchitettura che non si limita, quindi, al trasferimento tecnologico da settori industriali evoluti, ma che rincorre quellideale di Architecture as a necessary Art che Alsop apprende da Cedric Price durante gli anni del suo privilegiato tirocinio, dopo gli studi allArchitectural Association di Londra.
Nel 2009 si dissocia, con clamore di stampa, da Alsop Smc e inizia una nuova vita professionale con il colosso Rmjm. Quale bilancio può fare oggi, dopo due anni con loro?
Rmjm ha unidentità corporativa con un management aziendale e un network globale che costituisce unindispensabile infrastruttura per il mio ruolo di responsabile per lEuropa. Da un punto di vista personale, questa collaborazione ha coinciso con il trasferimento dello studio in una sede molto più grande. Questo mi ha permesso di realizzare un centro per le arti che ho chiamato Testbed1, che inauguriamo a ottobre. Così, verso le sei, quando lo studio chiude, apriamo Testbed1 che prende vita con conferenze, manifestazioni, workshop dedicati alla cultura e alle arti. È in programma anche Doodle Bar, un bar pubblico dove gli architetti dello studio potranno ritrovarsi e scambiarsi idee.
Lei indipendentemente da Rmjm ha interventi in corso di realizzazione in Cina che sarebbero impensabili in un contesto europeo e forse anche americano. Quali condizioni culturali o di committenza consentono questa maggiore libertà espressiva del progetto?
La committenza cinese esige una qualità molto alta, che va ben oltre il livello di molta architettura speculativa americana che ricicla formule tipologiche in modo asettico e internazionale. Oggi la Cina ha maturato una volontà di ricerca di una nuova identità che rappresenti la sua idea di modernità. La tradizione non si è mai evoluta in valori che possono costituire un quadro di riferimento prestabilito e, quindi, esiste apertura culturale da parte dei committenti e libertà per i progettisti. La nuova classe dirigente cinese non ha paura di mettersi in gioco, ma è molto attenta agli aspetti commerciali ai tempi di realizzazione.
E dal punto di vista dellingegnerizzazione?
Lingegneria locale è estremamente capace di raggiungere livelli di dettaglio paragonabili a quelli degli studi anglosassoni. Penso che tra cinque o dieci anni anche gli architetti cinesi saranno in grado di progettare in modo competitivo. Ciò non significa che tra dieci anni non si potrà più lavorare in Cina, perché le logiche con cui si sceglie un architetto sono anche legate alla fiducia e al piacere di lavorare insieme.
A Shanghai ha inaugurato a gennaio lintervento di Gao Yang, con uno scenografico portale a cui sono ancorati tre «pod». Che ruolo riveste questo elemento centrale, già rinominato lo «Shanghai Chandelier», nella composizione generale del progetto?
Volevo mantenere una sequenza lineare di edifici, ma al centro non potevamo scavare fondazioni profonde perché sono previsti i tunnel della metropolitana. Così, ho progettato questo portale che segnala lingresso in città e ho voluto che fosse il più luminoso possibile. La sera i pod, dove si trovano bar, ristoranti e un night club, si accendono di Led multicolore e linsieme diventa molto spettacolare. È una struttura appesa molto complessa che credevo non sarei mai riuscito a realizzare ma ce labbiamo fatta! Da un punto di vista progettuale più generale, non procedo con un metodo seriale, ma mi avvicino al progetto con la stessa apertura con cui mi metto a dipingere un quadro. Inizio a disegnare e non ho idea del risultato finale. È latto stesso di dipingere che determina il risultato; proprio come con larchitettura dove la soluzione è una scoperta in divenire.
Oggi un grande architetto deve avere accanto una grande engineering. I suoi edifici nascono anche grazie alla collaborazione con studi come Arup, Buro Happold e Adams Kara Taylor. Segui lingegnerizzazione del processo o lascia che altri se ne occupino?
In Inghilterra la relazione tra architetti e ingegneri è molto salda; ci sono anche molta amicizia e rispetto reciproco. A me piace sviluppare insieme il progetto senza aspettare di coinvolgere gli ingegneri nella fase conclusiva. Non progettiamo un edificio e poi ci aspettiamo che qualcuno trovi la soluzione per farlo stare in piedi! In Inghilterra, già nel corso degli studi universitari, vengono forniti ai futuri architetti gli strumenti per comprendere le logiche strutturali; così anche se non sai fare i calcoli, sei sempre consapevole della costruibilità di un edificio. Invito spesso tutto il team di progetto, ingegneri compresi, a partecipare a workshop dove esploriamo insieme le prime fasi della progettazione, a volte anche dipingendo insieme grandi quadri.
Si è spesso definito un «outsider», confessando anche un certo disagio con il dibattito internazionale. Cosa non condivide dello scenario architettonico contemporaneo, tutto sommato caratterizzato da un forte pluralismo?
I miei docenti erano gli Archigram e ho fatto tirocinio con Price. Sono cresciuto con lidea che larchitettura fosse uno strumento dindagine per lavanzamento sociale, linnovazione tecnologica e la trasformazione urbana. In un certo senso se guardi Londra da Waterloo Bridge ti accorgi di quanto sia diversa da dieci anni fa; a Parigi non si sarebbe mai permesso uno stravolgimento di questo genere. Così, gli inglesi sono più favorevoli alle logiche evolutive e meno conservatori di quanto pensano di essere. Il pluralismo è una grande conquista del millennio, anche se oggi assistiamo a uno strano fenomeno: se da un lato possiamo dire di aver raggiunto quella maturità culturale che ci ha liberato da movimenti totalitari e ideologici, dallaltro sono gli stessi architetti a volersi imporre delle regole. In questo senso certa architettura minimalista o la stessa high tech, quando ridotta a codici linguistici preconfezionati, possono avere uninfluenza negativa quanto il conservatorismo del principe Carlo. Questa riduzione dellarchitettura alla ricerca di uno stile mi trova del tutto dissenziente. Adottare le regole di un linguaggio prestabilito toglie la gioia dellinvenzione che a me piace ricercare insieme ai miei committenti. Per quanto si possa pensare che i miei edifici siano riconoscibili, sono però anche molto diversi luno dallaltro.
Renzo Piano definisce larchitettura «arte corsara», cioè una battaglia multidisciplinare. Una definizione che si addice anche alla sua visione del progetto. Dopo trentanni dedicati allarchitettura, quale pensa sia la tua più grande conquista?
Due sono le conquiste di cui posso dire di sentirmi orgoglioso. La prima è sentire la soddisfazione delle persone che abitano i miei edifici. La seconda è aver avuto come collaboratori architetti di talento che ora hanno la loro vita professionale autonoma, ma a cui penso di aver comunicato una scuola di pensiero.