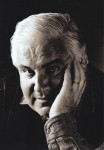Santiago de Compostela (Spagna). L11 gennaio sono stati inaugurati larchivio e la biblioteca, una parte del megaprogetto della Città della cultura a Santiago de Compostela firmato dallo statunitense Peter Eisenman.
Santiago è una di quelle città che danno la sensazione di essere state ricavate da un unico materiale, in questo caso il granito. Le strade, le piazze, i monasteri e le chiese, di qualunque epoca storica, ricreano un insieme radicato in un paesaggio antico. Compostela è ovviamente la meta finale del nocelebre percorso di pellegrinaggio che attraversa la Francia e la Spagna settentrionale, e la cattedrale indica il punto indica il punto in cui si pensa sia sepolto lapostolo Giacomo. Nel corso dei secoli la città ha importato da fuori i modelli architettonici mescolandoli alla propria topografia e geologia dal sapore vernacolare e caratteristico.
Negli anni ottanta e novanta Santiago de Compostela è stata modernizzata con intelligenza sotto la leadership del sindaco socialista Xerardo Estévez, che tentò di raggiungere un equilibrio tra la tutela degli edifici e degli spazi storici e la realizzazione di una nuova infrastruttura culturale. Furono indetti vari concorsi per progettare i palazzi istituzionali. Il culmine fu il Centro Galego de Arte Contemporanea (1989-1994) di Álvaro Siza, che riuscì a porre rimedio al degrado del tessuto urbano di una zona della città astraendone il contesto storico e il terreno digradante nella sua forma complessiva.
Alla fine degli anni novanta sono stati i conservatori del governo locale sotto la presidenza di Manuel Fraga Iribarne (un residuo del regime franchista) a proporre la «Città della cultura» in cima al Monte Gaias, a tre chilometri circa dalla collina sormontata dalla città vecchia e dalla sua cattedrale. Questo progetto megalomane prevedeva in origine un Museo della Galizia, una biblioteca, un centro per le nuove tecnologie e persino una sala per concerti su un appezzamento di oltre 700.000 mq. Ipnotizzati dall«effetto Bilbao», gli organizzatori del concorso hanno invitato esponenti dello star system quali Rem Koolhaas, Jean Nouvel e Peter Eisenman, ma è stato il progetto di un architetto locale, Manuel Gallego Jorreto, a comprendere meglio di tutti il sito e il programma.
Il cliente e la maggior parte dei membri della giuria volevano un edificio «iconico» di una star internazionale, così hanno optato per il progetto sensazionalista di Eisenman che, si diceva, rispondeva alla topografia. Il progetto era esplicitato attraverso un modellino di cartone che comprendeva il paesaggio circostante e la città vecchia; in quella scala, e con un solo materiale, limmagine di un paesaggio artificiale a pieghe tagliato dalle strade era piuttosto seducente. I disegni al computer di Eisenman davano la falsa impressione che il progetto fosse stato «generato» scansionando la struttura della città vecchia per poi distorcerla in una geometria fratturata. Il progetto era inoltre a forma di conchiglia, lemblema di San Giacomo e del percorso del pellegrinaggio. Insomma, i consueti vezzi di Eisenman: frammenti e griglie sovrapposte.
Allepoca le pieghe erano molto in voga e Eisenman cucinava ripetutamente i suoi dossier con un pizzico di «teoria francese», con citazioni di Gilles Deleuze su «le pli» («la piega»). Dietro la cortina di fumo del suo teorizzare pretenzioso, Eisenman è in realtà un formalista che razzia le fonti e manipola le forme per il puro gusto di farlo, lasciando da parte il problema del contenuto. Il suo progetto per la Galizia sembra aver tratto ispirazione da un esempio di «Land Art»: il «Grande Cretto» di Gibellina in Sicilia (1985-1989), disegnato da Alberto Burri come memoriale per il terremoto del 1968. Una «mappa» di cemento della città distrutta con pieghe e strade incise.
Il progetto, promosso per la sua «sensibilità topografica», ha invece richiesto la totale decapitazione del Monte Gaias. Le «pieghe delicate» del plastico di concorso sono state realizzate con ampie curve ad anello che ricordano l«ottovolante» di un luna park invece delle astrazioni del paesaggio. Le curve sono incrostate con una sottile patina di pannelli di granito (importato dal Brasile!) e tagliate da immensi solchi che ne erodono la forma. Eisenman non è uno scultore e a quanto pare non è riuscito a tradurre le sue stesse intenzioni in spazi e forme tridimensionali convincenti.
Non cè niente di nuovo in tutto questo: persino i suoi fan ammettono le difficoltà dellarchitetto a realizzare le proprie idee. Le pareti vetrate ricordano una banale architettura commerciale. Ledificio è un incubo tettonico di sgraziate collisioni. Linterno rivela una tavolozza ininterrotta di pannelli in cartongesso bianco. Gli effetti della luce sono piuttosto gradevoli, ma una simile complessità finisce per essere monotona e ignora luso umano. Alcune geometrie sono puramente cosmetiche. È un caso emblematico di quella che Le Corbusier chiamava: «lillusione dei progetti». Hanno unaria stravagante e banalizzano ulteriormente il progetto anche le due sfortunate torri che si stagliano sullo sfondo del complesso progettate da John Hejduk nel 1992, ma fatte costruire da Eisenman in memoria dellamico con cui aveva fondato i New York Five.
Nellatrio un bizzarro video presenta Eisenman come un guru che ripete formule magiche e incantesimi. «La Città della cultura aiuterà la Galizia a capire qual è il suo posto nel mondo, sarà un«icona» per Compostela [manco ne avesse bisogno!], ricorderà la conchiglia di San Giacomo, riecheggerà il paesaggio locale di granito e le tradizionali facciate di vetro…». Tutto questo si cerca invano nelle immense sale contorte di materiali epidermici e dettagli in collisione che ricreano la pacchianeria di un centro commerciale. Fraga aveva davvero sogni faraonici di un monumento e di un memoriale pubblico? Con questo gigantesco supermercato, i contribuenti della Galizia potrebbero far naufragare lo star system che ne sintetizza i gesti vuoti e le illusioni spacciate dalla politica. La Città della cultura, il cui budget iniziale di 100 milioni è più che quadruplicato, è ancora lontana anni luce dal completamento (mancano ancora il Museo della Galizia, previsto per settembre, il teatro auditorium, il centro internazionale darte e i servizi generali) e la gestione e la manutenzione costeranno una fortuna. È assai possibile che in questoccasione il magico «effetto Bilbao» non funzioni.
Articoli recenti
- Tragico crollo nella Torre dei Conti: no a scelte frettolose 8 Novembre 2025
- Jean Prouvé double face: tra valorizzazione e conservazione 5 Novembre 2025
- Un grande, raffinato, magazzino per rivoluzionare l’agricoltura 5 Novembre 2025
- La migliore architettura: politicamente corretta, poche sorprese e archistar 5 Novembre 2025
- Vitra Campus, Balkrishna Doshi celebra il silenzio 5 Novembre 2025
- Il porto di Marsiglia ha il suo nuovo, vecchio, faro 4 Novembre 2025
- Impermeabilizzazione del terrazzo: Icobit Italia il tuo alleato 4 Novembre 2025
- Il Museo più grande, simboli e nazionalismo: l’Egitto si celebra 3 Novembre 2025
- Forma e relazioni in mostra alla Sapienza 3 Novembre 2025
- Ritratti di città. Hanoi, topografie del cambiamento 29 Ottobre 2025
- Smart vs Green: una sola intelligenza non basta 29 Ottobre 2025
- Dolci attese: forme che misurano il tempo 28 Ottobre 2025
- Agenda Urbana: a Brescia un laboratorio condiviso per la sostenibilità 28 Ottobre 2025
- Alice Rawsthorn: il mio design, un’attitudine più che una professione 28 Ottobre 2025
Tag
Edizione mensile cartacea: 2002-2014. Edizione digitale: dal 2015.
Iscrizione al Tribunale di Torino n. 10213 del 24/09/2020 - ISSN 2284-1369
Fondatore: Carlo Olmo. Direttore: Michele Roda. Redazione: Cristiana Chiorino, Luigi Bartolomei, Ilaria La Corte, Milena Farina, Laura Milan, Arianna Panarella, Maria Paola Repellino, Veronica Rodenigo, Cecilia Rosa, Ubaldo Spina. Editore Delegato per The Architectural Post: Luca Gibello.
«Il Giornale dell’Architettura» è un marchio registrato e concesso in licenza da Società Editrice Allemandi a r.l. all’associazione culturale The Architectural Post; ilgiornaledellarchitettura.com è un Domain Name registrato e concesso in licenza da Società Editrice Allemandi a r.l. a The Architectural Post, editore della testata digitale, derivata e di proprietà di «Il Giornale dell’Architettura» fondato nell’anno 2002 dalla casa editrice Umberto Allemandi & C. S.p.A., oggi Società Editrice Allemandi a r.l.
L’archivio storico
CLICCA QUI ed effettua l’accesso per sfogliare tutti i nostri vecchi numeri in PDF.
© 2025 TheArchitecturalPost - Privacy - Informativa Cookies - Developed by Studioata