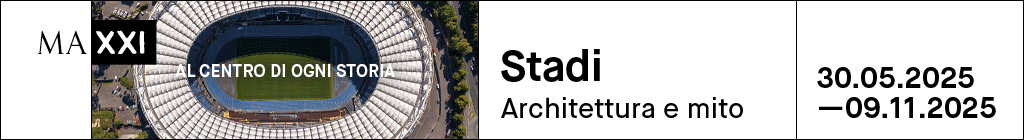Il ruolo assegnato, nella storia dellarchitettura, alla distribuzione come momento del progetto inclusivo di ragioni funzionali e sociali, ha delineato un rapporto privilegiato tra spazio costruito e «vie sociale», fino alla modernità. Oggi invece, sempre di più, lo spazio sembra definirsi lontano da queste ricerche, come pura conseguenza dellinvolucro. Il dibattito avviato da questo Giornale nel numero scorso intende stimolare lattenzione del contesto professionale, coinvolgendo affermati progettisti italiani su un tema fondativo del fare architettura. Dopo baukuh, rispondono a 4 domande Paolo Iotti e Marco Pavarani (www.iotti-pavarani.com).
La qualità dello spazio è sempre un enigma. Una miscela dingredienti di scala, rapporti tra le parti, proporzioni, colori, materiali ed eventi «accidentali» o valori sedimentati che producono unatmosfera costruiscono un «sapore». Lo spazio architettonico produce una risonanza fisica sulle persone (anche se ovviamente niente affatto codificabile: come scrive Rem Koolhaas, uno stesso modello di «città generica» agisce in modi sempre contraddittori e dinamici, per cui «ad A i complessi residenziali a torre portano al suicidio, a B alla felicità duratura»). Tale risonanza la sperimentiamo con intensità – in un caso estremo – ogni volta che entriamo nel Pantheon, una delle poche esperienze in cui si può percepire lo spazio assoluto, puro, senza uso né relazioni, «vuoto» ma con una presenza solida, palpabile. Che cosa trasforma uno spazio geometricamente così semplice in unesperienza spaziale così intensa? Non certo (o non solo) la scala: ad esempio, la sala interna della Neue Wache a Berlino – di dimensioni decisamente più contenute – trasmette una stessa forza. Come progettisti (e con ambizioni più contenute!) cinterroghiamo su come dosare le nostre attenzioni alla ricerca di una fantomatica «qualità dello spazio». Guardando al nostro lavoro – come più in generale alla produzione architettonica contemporanea, o anche al paesaggio delle nostre città – ci accorgiamo che basta la mancanza o un inciampo in uno solo degli ingredienti sopracitati a generare spazi sterili o zoppi o inutili o, ancora peggio, affettati.
Gli strumenti di lavoro e di controllo del progettista (piante, sezioni, modelli, prove sui materiali, esperimenti vari, aggiustamenti e ripensamenti in cantiere) non bastano mai veramente a verificare e descrivere le sensazioni che unarchitettura immaginata debba poi trasmettere, o la capacità di un luogo di accogliere veramente pezzi di vita; rimangono tasselli con i quali si tenta un avvicinamento. È come se la bellezza si potesse poi presentare solo come un effetto secondario, quasi non voluto. La distribuzione, lorganizzazione spaziale che si mette in campo in fase di progetto, può quindi funzionare da canovaccio, da storyboard, quale sequenza d«inquadrature» con cui lo spazio si andrà via via svelando. Per questo il disegno a mano, lo schizzo, è per noi così importante, come successione di annotazioni veloci sulle intenzioni del progetto stesso. Più tardi arrivano i modelli reali (il plastico) per il controllo di proporzioni ed equilibri. Infine il 3D. Ma più come racconto per lesterno (oltre che per perdere milioni di ore in attività extra-architettoniche come desaturare cieli in tempesta e comporre belle immagini).
La riflessione sul tema della distribuzione non può però prescindere dalla reale efficacia del contributo dellarchitettura contemporanea a generare una qualità «diffusa» dello spazio, allargando il punto di vista alla città e al territorio. Troppo spesso gli architetti si concentrano su macchine straordinarie e sofisticate su cui fare convergere tutta la propria passione e intelligenza e che tuttavia solo in rari casi sanno farsi parte attiva e pulsante di un ambito più vasto del singolo lotto di progetto; nel frattempo la gestione del territorio è affidata – o presa in ostaggio – da altri soggetti; così, molte occasioni dintervento sensibile a scala urbana vanno perdute e interi brani di città si popolano di edilizia inutile: e ciò che non qualifica non è semplicemente indifferente, ma distrugge.
Da tempo, buona parte del nostro lavoro si è concentrato sulla scala allargata, principalmente attraverso occasioni concorsuali, anche allestero, nelle quali sperimentare la nostra ricerca sui rapporti tra architettura e paesaggio, ricerca in cui lo spazio dellabitare, del lavoro, della ricreazione, si confrontano – non solo visivamente ma operativamente – con un contesto più ampio, nella possibilità di unorganizzazione spaziale alla scala vasta. Tra questi, i masterplan per le aree di Tiefes Feld a Norimberga e di Jugla a Riga, il quartiere residenziale in classe A per 50 case monofamiliari e una scuola a Ferrara. Questultimo incarico nasce da un concorso privato indetto da una società immobiliare, alla ricerca di una soluzione non scontata per un intervento caratterizzante nelle immediate vicinanze del centro storico. La soluzione individuata propone unaggregazione «a tessuto» di una tipologia abitativa bassa con corte centrale. Crediamo infatti che le caratteristiche dellintervento possano connotare un approccio urbano al tema, attraverso uno schema aggregativo continuo che tuttavia garantisca le caratteristiche di privacy e intimità, bellezza dellaffaccio, possibilità di unarea verde privata, possibilità di personalizzazioni, che rappresentano le esigenze più sentite e più richieste da chi cerca una casa di proprietà. Linsediamento proposto rifiuta infatti il sistema «a costruzione isolata», tipico della periferia e incapace di generare spazi coinvolgenti e piacevoli, la cui appetibilità risulta ormai in forte crisi.
Per troppo tempo non è esistita una domanda «consapevole» ed esigente nellambito delledilizia residenziale; così, il mercato immobiliare non ha sentito alcuna esigenza di aggiornare modelli consolidati o incentivare approcci più sensibili al territorio. Ci auguriamo che le cose stiano lentamente cambiando.