I volumi di Carlo Tosco e Pietro Valle invitano a osservare la storia con sguardo contemporaneo
Per materica e fondata identità, e in quanto catalizzatori di fatti tecnici, economici, culturali, politici e sociali, i manufatti architettonici non sono isolabili dalla città e dai luoghi di cui sono parte costitutiva. Fenomeni complessi, a un’attenta lettura essi rivelano infatti la propria natura multidisciplinare, coinvolgendo non solamente l’arte del costruire ma una pluralità di attori e situazioni che, nel tempo, contribuiscono a determinare varianti, adattamenti e trasformazioni. Per questo le analisi intelligenti non si limitano a considerarne gli aspetti estetici ma li intendono come pratica di com-posizione processuale, campo d’intreccio fra idea ed esperienza, di tensione fra autonomia del progetto e vincoli e di confronto in itinere con le logiche del cantiere. Due recenti volumi presuppongono, appunto, una concezione dinamica e relazionale del costruire nel costruito attraverso sintassi non prefissate, osservandolo nell’architettura trecentesca e rinascimentale.
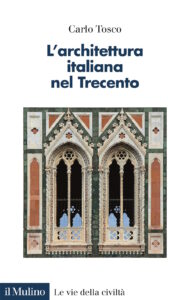 Ricco e articolato, L’architettura italiana nel Trecento di Carlo Tosco (Il Mulino, 440 pp., 29 euro) è impostato per temi e luoghi ma innervato da letture puntuali di edifici di carattere monumentale civili, ecclesiastici, militari e talvolta residenziali, protagonisti della stagione che l’autore definisce la “grande svolta del costruire in Italia segnata da quella spiccata vivacità regionale guidata dalle città comunali”. Il libro completa una trilogia dedicata all’architettura medievale e caratterizzata dalla rinuncia alle tradizionali etichette stilistiche (Romanico e Gotico) per riconoscere il XIV secolo come grande campo di sperimentazioni e di articolate varianti regionali intrecciate e talvolta divergenti, identificandovi i caratteri specifici di un’architettura svincolata dalla deformante ipoteca rinascimentale. La competenza d’architetto consente a Tosco di sostanziare i paragrafi proprio ricorrendo a esempi concreti, a edifici esemplari di cui indaga struttura, materiali, fasi costruttive, tecniche e stratificazioni, mentre la distanza critica gli permette di svolgere “una lettura di sistema” che connette l’oggetto architettonico a una rete di significati e di rapporti sociali, storici, estetici, religiosi, politici e culturali.
Ricco e articolato, L’architettura italiana nel Trecento di Carlo Tosco (Il Mulino, 440 pp., 29 euro) è impostato per temi e luoghi ma innervato da letture puntuali di edifici di carattere monumentale civili, ecclesiastici, militari e talvolta residenziali, protagonisti della stagione che l’autore definisce la “grande svolta del costruire in Italia segnata da quella spiccata vivacità regionale guidata dalle città comunali”. Il libro completa una trilogia dedicata all’architettura medievale e caratterizzata dalla rinuncia alle tradizionali etichette stilistiche (Romanico e Gotico) per riconoscere il XIV secolo come grande campo di sperimentazioni e di articolate varianti regionali intrecciate e talvolta divergenti, identificandovi i caratteri specifici di un’architettura svincolata dalla deformante ipoteca rinascimentale. La competenza d’architetto consente a Tosco di sostanziare i paragrafi proprio ricorrendo a esempi concreti, a edifici esemplari di cui indaga struttura, materiali, fasi costruttive, tecniche e stratificazioni, mentre la distanza critica gli permette di svolgere “una lettura di sistema” che connette l’oggetto architettonico a una rete di significati e di rapporti sociali, storici, estetici, religiosi, politici e culturali.
 Arricchito dall’importante apparato fotografico di Giuseppe Dall’Arche, il volume Rinascimento Adattivo di Pietro Valle (Libria, 2023, 360 pp., 35 euro) evidenzia in modo accurato e problematico le correlazioni tra idea progettuale e realtà costruita in opere autoriali del Quattro e Cinquecento. Le ventisei opere visitate, illustrate e analizzate sono riunite in nove capitoli, ciascuno dei quali affronta temi progettuali che avvertiamo come contemporanei (aggiunta, adattamento, infrastrutture abitabili, ricostruzione, deformazione, montaggio, interruzioni), intervallati da considerazioni sul rapporto tra paesaggio ideale e sito reale e sulla processualità d’interventi successivi e differenti. Dai montaggi additivi di Leon Battista Alberti e Andrea Palladio agli adattamenti di Giulio Romano e di Mauro Codussi, dall’architettura assoluta e flessibile di Filarete all’efficienza difensiva dei collage di Francesco di Giorgio, e altri ancora, l’autore osserva un susseguirsi di atteggiamenti adattivi a luoghi, tempi e programmi, dove l’universalità del classico diviene “reinvenzione continua di una regola”, fondamento flessibile e strumento di verifica anche nella dimensione diacronica, poiché “il tempo è anche quello della permanenza del classico che si adatta alle esigenze di più periodi storici”. Gli edifici sono indagati come architetture sensibili, portatrici di microstorie che testimoniano il divenire in opera del progetto, sintesi che suggerisce la sottile distanza tra i problemi architettonici del passato e del presente, tra reinvenzione di regole e di modelli e dinamismo tra programmi, intenzioni, possibilità e stato di fatto.
Arricchito dall’importante apparato fotografico di Giuseppe Dall’Arche, il volume Rinascimento Adattivo di Pietro Valle (Libria, 2023, 360 pp., 35 euro) evidenzia in modo accurato e problematico le correlazioni tra idea progettuale e realtà costruita in opere autoriali del Quattro e Cinquecento. Le ventisei opere visitate, illustrate e analizzate sono riunite in nove capitoli, ciascuno dei quali affronta temi progettuali che avvertiamo come contemporanei (aggiunta, adattamento, infrastrutture abitabili, ricostruzione, deformazione, montaggio, interruzioni), intervallati da considerazioni sul rapporto tra paesaggio ideale e sito reale e sulla processualità d’interventi successivi e differenti. Dai montaggi additivi di Leon Battista Alberti e Andrea Palladio agli adattamenti di Giulio Romano e di Mauro Codussi, dall’architettura assoluta e flessibile di Filarete all’efficienza difensiva dei collage di Francesco di Giorgio, e altri ancora, l’autore osserva un susseguirsi di atteggiamenti adattivi a luoghi, tempi e programmi, dove l’universalità del classico diviene “reinvenzione continua di una regola”, fondamento flessibile e strumento di verifica anche nella dimensione diacronica, poiché “il tempo è anche quello della permanenza del classico che si adatta alle esigenze di più periodi storici”. Gli edifici sono indagati come architetture sensibili, portatrici di microstorie che testimoniano il divenire in opera del progetto, sintesi che suggerisce la sottile distanza tra i problemi architettonici del passato e del presente, tra reinvenzione di regole e di modelli e dinamismo tra programmi, intenzioni, possibilità e stato di fatto.
I due studi invitano a osservare la storia con sguardo contemporaneo, dove ogni edificio interviene in modo critico nei confronti di un contesto attivo. Propongono inoltre una riflessione sul progettare come intelligenza applicata, come concordia discors finalizzata alla risoluzione di problemi componibili nell’eleganza della forma costruita. Ogni edificio studiato rappresenta pertanto una lezione di composizione architettonica in cui, per dirla con La mente inquieta di Massimo Cacciari, “l’attenzione al passato è complementare alla riflessione sul futuro”.
Immagine di copertina: la corte della Villa Imperiale di Pesaro (XV-XVI secolo)
About Author
Tag
libri , palladio , Rinascimento , Storiografia
Last modified: 12 Dicembre 2023


























