Itinerari di lettura attraverso gli slittamenti di senso e d’uso dei luoghi contemporanei
—
Quasi prodromi di un futuro non avverato – che nel volgere di poche settimane si è tramutato in un presente già passato – ci troviamo a considerare gli effetti di quel processo d’ibridazione, che si credeva ricaduta positiva di una globalizzazione già scricchiolante, ma irreversibile, in una condizione del tutto nuova e inattesa. Parliamo del mondo che improvvisamente si è chiuso fra le mura domestiche, di quei confini che si sono alzati nuovamente impervi, anche perché non superabili con mezzi di trasporto che giacciono: aeromobili solitari a terra sulle piste o treni e bus chiusi nelle stazioni e nelle rimesse come animali dormienti. Quel mondo che ha il cielo in una stanza ma che, forse non paradossalmente, ha ancora più bisogno di un’ibridazione degli spazi nuova e cosciente, questa volta, per disegnare la ripartenza in una visione globale rinnovata e riprogettata. In questa chiave possiamo leggere quattro testi che, in modo diverso, hanno affrontato il tema dell’ibrido al finire dell’epoca precedente e che, nell’epoca che va ad aprirsi, possono quasi costituire capitoli di un manuale d’istruzioni per l’uso del nuovo mondo. Se l’etimo incerto di ibrido ha forse favorito il suo ondeggiare fra valenze positive e negative, sta di fatto che il termine è passato dalla sua specializzazione in linguaggi tecnici – come risultato di incroci di varietà, generi, cellule, Dna, parole, sistemi – a diventare parola chiave per denotare e leggere stati di fatto, cambiamenti, prospettive ed anche, soprattutto nel campo delle scienze spaziali dell’architettura e del design, a diventare simbolo di categorie d’uso e anche di metodologie di progetto. Lo spazio, sappiamo, si esplica a tutte le scale nel nostro vivere e del nostro abitare. L’implosione degli spazi che da locali sono diventati domestici nella pandemia e che, nel dopo, forse si replicheranno in un’atomizzazione suddita del distanziamento fisico – nel pubblico, nel lavoro, nella scuola, nella vita in generale – porta con sé l’ibridazione come matrice diffusa, minimo comune multiplo di un equilibrio tutto da ricercare ma che, se non è ibrido e flessibile, non ha alcuna possibilità di affrontare l’incognito futuro.
Così, partendo dalla grande scala, non possiamo che leggere con rinnovato interesse Lo spazio ibrido. Culture, frontiere, società in transizione, di Simone Casalini per i tipi di Meltemi che parte dallo spazio del Mediterraneo, quel Mediterraneo che Braudel vedeva come «mille cose insieme. Non un paesaggio, ma innumerevoli paesaggi. Non un mare, ma un susseguirsi di mari. Non una civiltà, ma una serie di civiltà accatastate le une sulle altre», per arrivare a definire lo spazio ibrido come condizione del mare nel quale siamo immersi e dei paesi che vi si affacciano. Anche nel valutare le frontiere – che fino a poco fa volevano difendere gli stati ed ora sono arrivate sulla soglia delle nostre case, a proteggerci dal virus – la spinta contenuta nel libro sembra ancora più attuale. «Lo spazio ibrido […] vuole sottolineare le intessiture e gli accavallamenti che quotidianamente si verificano nella collettività e che da secoli modellano il sistema di relazioni sociali, accolgono il contagio culturale, trasgredendo le raffigurazioni statiche e ancestrali. Vuole ancora, modestamente, situarsi nell’oltre, nello spazio che si interpone, esser parte di un tempo di re-visione, di un ritorno al presente per ri-descrivere la nostra contemporaneità e ri-scrivere la nostra vita comune».
Non è forse questo il compito che ora ci attende? Anche perché il paradosso del nostro tempo presente ha portato ad una totale inversione dei ruoli e delle possibilità dei viaggiatori nel regime delle frontiere. Quelli che prima erano i viaggiatori non qualificati, quali migranti, profughi, persone prive di documenti e per i quali le frontiere si chiudevano, ora continuano ad arrivare, mentre le frontiere chiuse, anzi sbarrate, sono per quelli qualificati, i turisti, gli espatriati e gli avventurieri che ora si vedono confinati in casa. E così è straordinario vedere i centri delle nostre città deserte ove chi non ha dimora alberga in una città quasi più accogliente, mentre il turismo di massa è totalmente annullato. Riprendiamo la riflessione del sociologo Rodolphe Christin che nel suo Turismo di massa e usura del mondo, saggio pubblicato da Elèuthera, ci ammonisce sul fatto che «Se si è passati in poco tempo dall’uso del mondo all’usura del mondo, è perché la massificazione del desiderio turistico, camuffata da libertà di movimento, è avvenuta all’interno di una logica industriale che ha distrutto la dimensione simbolica del viaggio, trasformandolo in una “fuga d’evasione” da fare in tempi e luoghi deputati, e soprattutto passando sempre alla cassa». Non è certo una consolazione che – reclusi i cittadini – ora si vedano volpi, cervi e scoiattoli circolare nelle città e che le acque di Venezia siano limpide. Sempre seguendo Christin, «Il turismo è diventato, insieme alla televisione, agli antidepressivi e al calcio, uno dei più potenti anestetici che la società contemporanea elargisce ai suoi logorati cittadini, immersi in una ipermobilità che dà la misura della loro insoddisfazione. Eppure, nonostante la standardizzazione dei desideri e il saccheggio ambientale, il turismo mantiene intatto il suo potere incantatore. Forse perché il turista, lontano dal suo territorio originario, che ormai non conosce più, nutre la confusa speranza di trovare altrove ciò che gli manca a casa: una vita conviviale in un territorio ancora carico di senso. Senza accorgersi però che con la sua stessa presenza distrugge ciò che è venuto a cercare». Non è certo la reclusione di massa forzata dal virus la soluzione al problema; reclusione che non è altro che il rovescio della stessa medaglia raffigurata dall’usura del mondo: l’insostenibilità di parte del nostro modo di vivere nel territorio, nel paesaggio, nelle città, finanche nelle nostre case.
Il processo d’ibridazione fra i luoghi simbolo del progresso del secolo breve – uffici, negozi, abitazioni, musei, luoghi d’incontro e di svago, spazi pubblici e privati – è del resto cosa nota da tempo. Il Retail ibrido è considerato da Maria Grazia Cardinali, nel suo saggio per Egea, come condizione di quella distribuzione grocery (beni di largo consumo si diceva una volta) nella quale «I big players della distribuzione internazionale, sullo sfondo di mercati ormai maturi, mettono in atto strategie proattive orientate a conquistare nuovi clienti che integrano i propri acquisti e si rivolgono a diversi format distributivi per la spesa». L’avvicinamento tra i format stava avvenendo in un contesto nel quale i confini tra i canali diventavano sempre più liquidi, lasciando gradualmente spazio ai nuovi format ibridi. Se la domanda suonava: «…nell’era del “tutti contro tutti”, come cambierà la customer journey del cliente?», che cosa succederà ora? Certo pochi avrebbero pensato ad una condizione tale da costringerci a fare la spesa da casa e a rinunciare addirittura a tutta una serie di beni: ma sicuramente la situazione cogente ha velocizzato il processo e i negozi che riapriranno, le catene di distribuzione che resisteranno, si ripenseranno con grande attenzione nei confronti di quella specializzazione che non è certo stata un vantaggio per affrontare l’epoca del Covid-19. Anche perché tutto è ibrido e liquido, anche solo per questioni di sopravvivenza: si tratta di far diventare la pratica d’ibridazione un processo virtuoso e non solo un’ancora di salvezza nel nostro momento votato alla sopravvivenza.
Ne sono ben coscienti Francesco Scullica ed Elena Elgani che, nel loro Living, Working and Travelling. New Processes of Hybridization for the Spaces of Hospitality and Work, edito da Franco Angeli, raccolgono i risultati di una ricerca del Dipartimento di Design del Politecnico di Milano, volto ad indagare soluzioni di interior design capaci di produrre nuovi scenari fra spazi di ospitalità e luoghi del lavoro. Anche in questo caso profetico appare l’assunto di base che nella visione di Anthony Elliot e John Urry (Vite mobili, Il Mulino, 2013) illustra come nella società contemporanea siamo testimoni di vite mobili sia reali che virtuali. Il testo raccoglie esempi di come le nuove modalità di vivere, lavorare e viaggiare hanno prodotto nuove tipologie di spazio, generate dalle trasformazioni della contemporaneità che, nel frangente attuale, rimettono prepotentemente la casa al centro del problema progettuale.
Tempi duri oltre che ibridi, ma colmi di sfide da cogliere e vincere facendo della velocità, della sostenibilità e della reversibilità, insieme all’ibridazione, le armi per affrontare il futuro dei nostri spazi.
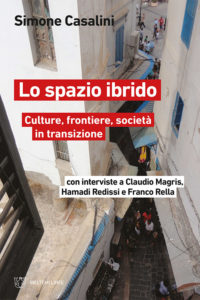 Lo spazio ibrido. Culture, frontiere, società in transizione, di Simone Casalini, Meltemi, 2019, 210 pagine, € 18
Lo spazio ibrido. Culture, frontiere, società in transizione, di Simone Casalini, Meltemi, 2019, 210 pagine, € 18
—
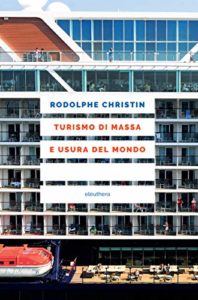 Turismo di massa e usura del mondo, di Rodolphe Christin, elèuthera, 2019, 134 pagine, € 14z
Turismo di massa e usura del mondo, di Rodolphe Christin, elèuthera, 2019, 134 pagine, € 14z
—
 Retail ibrido, di Maria Grazia Cardinali, Egea, 2018, 190 pagine, € 24
Retail ibrido, di Maria Grazia Cardinali, Egea, 2018, 190 pagine, € 24
—
 Living, Working and Travelling. New Processes of Hybridization for the Spaces of Hospitality and Work, di Francesco Scullica ed Elena Elgani, Franco Angeli, 2019, 290 pagine, € 27 (e-book)
Living, Working and Travelling. New Processes of Hybridization for the Spaces of Hospitality and Work, di Francesco Scullica ed Elena Elgani, Franco Angeli, 2019, 290 pagine, € 27 (e-book)
—

























