Il co-fondatore dello studio Tamassociati prosegue la serie di interviste sul ruolo odierno del progettista e della didattica dell’architettura
Dopo quella a Mario Abis, prosegue con Simone Sfriso, architetto e socio co-fondatore di Tamassociati, il ciclo di interviste ai relatori del convegno “Architettura Oggi. L’evoluzione nel ruolo del progettista e nella didattica dell’architettura” (Ravenna, 22-24 novembre 2018).
Quali competenze ritiene siano necessarie per la formazione dell’architetto oggi? Nuove competenze date da specificazioni differenti della professione o permanenze di un sapere legato alla tradizione?
Personalmente non credo veramente in nuove competenze. Ci siamo formati guardando maestri come Giancarlo De Carlo da cui abbiamo cercato di trarre quell’attenzione verso i temi del sociale e di apprendere quella capacità di dialogare con la società per costruire percorsi partecipativi. In questo modo d’intendere il processo di progettazione l’architetto esce dall’idea di autonomia disciplinare per confrontarsi con le discipline sociali, necessarie per mettere il tecnico in vibrazione con le committenze. Non ho mai veramente creduto in questo mito dell’autonomia disciplinare dell’architettura. L’architetto è un regista che si pone in un tavolo di lavoro e cerca di tradurre gli stimoli derivanti da tante competenze. Questi devono essere portati all’interno del progetto che si configura inevitabilmente come un processo complesso in cui la forma è il risultato finale di una serie di riflessioni, domande, richieste che vengono dai luoghi fisici e sociali in cui l’architetto si trova ad interagire. Questo vale in ogni luogo geografico, sia vicino che lontano in cui abbiamo avuto la fortuna di operare. In questi anni il lavoro di Tamassociati è stato un viaggio di andata e ritorno tra i nostri contesti ed il sud del mondo, ed in questo confronto con altri luoghi e culture abbiamo avuto l’opportunità di capire che cos’è veramente importante all’interno di un progetto: il luogo, fisico e sociale, fatto dalle persone. L’architetto deve mettersi a servizio di questo luogo.
Questo tema del progetto come strumento di dialogo tra le diversità sta emergendo con forza specialmente dai quartieri periferici delle grandi città, dall’Europa al Sud America. Un tema in larga parte sviscerato dalla Biennale 2016, “Reporting from the Front” curata da Alejandro Aravena, dove proprio TAMassociati era responsabile del Padiglione Italia. Nella vostra esperienza, quali conoscenze si devono apprendere per svolgere un processo partecipato? La diversità delle persone, delle problematiche e dei contesti, implica che si riparta ogni volta da una tabula rasa?
Ci sono delle tecniche e delle competenze. I processi partecipativi sono fondamentalmente delle buone pratiche che a partire da una formazione tecnica necessaria, si modulano e si reinventano ogni volta. Si costruiscono su misura sui progetti e suoi luoghi specifici. Noi lavoriamo con facilitatori, con esperti di sociologia, antropologia, di semiotica che di volta in volta in base ai progetti, ci aiutano ad entrare in vibrazione con i temi del progetto ed a far emergere le vere domande. Questo perché il processo di progettazione partecipata non serve a dare risposte automatiche alle domande evidenti, ma serve a portare in luce le domande corrette, perché non c’è nulla di più sbagliato di una risposta giusta ad una domanda sbagliata. Quindi l’architetto è osservatore partecipante, è chiamato a dare risposte e fare sintesi.
Osservatore partecipe o promotore? Si delinea per l’architetto un doppio registro che va forse compreso meglio.
Oggi l’architetto è comunque chiamato a trovare nuove capacità per collocarsi all’interno del settore e del mondo del lavoro. La crisi economica del 2008 ha evidenziato quello che era un processo verticale e dominante nell’architettura generando una frattura. Il mercato era sostanzialmente determinato da una filiera verticale che partiva da un luogo, poi una committenza, una capacità economica, un programma e sempre a scendere coinvolgeva un architetto che cercava di tradurre una volontà imprenditoriale in un progetto, immaginando un’utenza e conseguentemente degli edifici. Questa filiera “perfetta”, che oggi esiste solo in certi segmenti di mercato, si è spezzata, perciò l’architetto è chiamato ad avere capacità imprenditoriali, immaginare progetti intorno alle idee, generare interesse ed essere motore di cambiamenti fisici ma anche economici.
Si delinea insomma un allargamento nei confini di quello che abbiamo sempre concepito come progetto d’architettura, per un cambiamento di visione dei ruoli della professione a cui non si è istruiti ed abituati, specie in Italia. Cosa pensa rispetto a questi temi della formazione universitaria nel nostro paese?
Nel mondo anglosassone si è naturalmente abituati a pensare che in un progetto l’architettura è una componente ma l’altra è la capacità di costruire il processo economico. Rispetto a questo approccio in Italia siamo molto indietro. È importante quindi avere anche gli strumenti culturali e linguistici per dialogare con quegli attori che all’interno del mercato controllano i processi economici. Il rischio è altrimenti restare alla periferia dei processi per l’assenza del vocabolario specifico, perché ai progettisti mancano le parole. Ciò non significa che sia il mercato a dettare il linguaggio ma certamente bisogna conoscerne le dinamiche ed i meccanismi per acquisire una più completa capacità di sviluppo dei progetti.
La nostra professione è sempre più complessa e deve confrontarsi con altre discipline. In questo l’università avrebbe un ruolo cruciale: si deve uscire dagli steccati dell’insegnamento dell’architettura per portare gli studenti a confrontarsi anche con altre discipline. Questo significa essere all’interno di poli universitari da cui si può attingere ad insegnamenti che vengono dalle scienze sociali, dall’economia, dal mondo scientifico. La caratteristica principale che ancora si apprezza e si riconosce negli studenti e negli architetti italiani è la formazione umanistica, quella capacità di apertura e di visione complessiva che tuttavia si sta progressivamente cancellando. Nel mondo anglosassone invece si tende a formare tecnici specializzati che rispondono molto bene ad un settore specifico di competenza. Quella che ritengo essere sempre stata una virtù della formazione offerta dalla scuola italiana, di costruire menti che hanno capacità speculative, si sta perdendo. Questo è un vero peccato. Credo che l’università si debba aprire e confrontare con il mondo della professione, perché sono fondamentali le competenze accademiche ma è altrettanto importante tale confronto. Non credo che ci sia una superiorità tra chi svolge la professione o chi ha scelto il percorso accademico. Queste due componenti si devono confrontare, per offrire agli studenti una formazione complessa ed integrata, approfondita ed aggiornata.















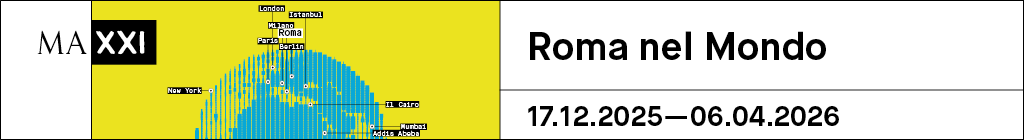










[…] gli interventi di Mario Abis e di Simone Sfriso, il ciclo di interviste ai relatori del convegno “Architettura Oggi. L’evoluzione nel ruolo del […]