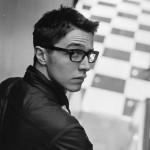Tra progetti incompiuti o arenati, e nonostante la sua collocazione strategica, la città stenta a ritagliarsi un ruolo nello scacchiere veneto
BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA). Nell’introdurre Il commissario Pepe, Ettore Scola si affida ad un efficace escamotage per creare il collage della città veneta dove ambientare il suo film con Ugo Tognazzi: brevi riprese a bordo di una volante, girate tra il centro storico di Bassano del Grappa e quello di Vicenza, tagliate e mixate a scacchiera, preparano lo spettatore ad entrare nel centro città del pudico Veneto di fine anni sessanta. La progressione d’inquadrature ci porta in un luogo che non esiste ma, riguardata oggi, racconta una realtà urbana senza soluzione di continuità: il grande sprawl che caratterizza questa zona ai piedi della Valsugana, un unico esteso agglomerato che lega piccoli e grandi centri urbani tra le provincie di Vicenza, Padova, Trento, Treviso e che si spinge fino a Verona, Rovigo e Venezia. In questa “no-stop city” Bassano del Grappa ha sempre giocato un ruolo strategico al fianco dei capoluoghi di provincia. Infatti, la sua posizione l’ha resa luogo di tensioni per secoli e, non a caso, anche il Ponte di Bassano stesso deve la sua conformazione all’essere stato una vera e propria frontiera dove poter attendere, coperti, il nulla osta per raggiungere l’altra sponda della Brenta, fiume che una volta lasciata la Valsugana disseta il padovano per giungere poi a Venezia.
A Bassano, forse a causa dell’idea ormai consolidata che la strategicità della posizione geografica sia una condizione sufficiente per la sopravvivenza economica dell’area, negli ultimi decenni è mancata una visione progettuale capace di valorizzare il tessuto economico e sociale del territorio.
Opere inutilizzate vs infrastrutture
Della città è difficile restituire un quadro complessivo senza soffermarsi sui progetti che non hanno trovato un completo sviluppo. In tale ottica, è opportuno partire da uno dei casi più eclatanti della storia locale recente. Infatti, a pochi passi dal Municipio di questa cittadina di quasi 50.000 abitanti, dietro un alto e severo muro bianco (memoria dell’invalicabile presenza delle carceri) troviamo la Cittadella della Giustizia.
Progettato dal serbo Boris Podrecca, il nuovo corpo della Cittadella è una struttura degna di nota, tra i progetti pubblici più interessanti della regione (segnalato alla XV edizione del Premio Architettura Città di Oderzo). Dopo anni d’impegnativi e delicati interventi, che insieme alla costruzione del nuovo tribunale hanno restaurato Palazzo Cerato (un tempo sede della Procura), nel 2012 la scure della spendig review del Governo Monti è calata anche sul progetto di Bassano: il taglio ha portato alla chiusura di una trentina di palazzi di giustizia sparpagliati su tutto il territorio nazionale, con la conseguenza che la Cittadella della Giustizia bassanese, costata nel complesso più di 20 milioni, una volta completata non è mai stata aperta.
A seguito dell’accorpamento della sede bassanese a quella vicentina, il Comitato per l’istituzione del Tribunale della Pedemontana Veneta ha proposto un nuovo disegno della geografia giudiziaria che meglio si adatta alla morfologia di questa zona del Veneto. L’iniziativa, anche grazie all’appoggio dei vari portatori d’interesse, dei sindaci e dei cittadini di ben 68 comuni, sta registrando una sempre maggiore attenzione da parte della politica locale, regionale e nazionale. La proposta di posizionare la Cittadella di Podrecca al centro del progetto giudiziario risponde meglio alla geografia, al tessuto sociale ed economico della zona e alle infrastrutture, tra cui, indubbiamente, la nuova Superstrada Pedemontana Veneta (SPV) gioca un ruolo da protagonista.
Realizzata in finanza di progetto con un importante coinvolgimento della Regione Veneto e ancora in fase di cantiere nell’ultimo tratto che la collegherà all’autostrada A4, la SPV meriterebbe un capitolo a parte per la complessità del suo iter e le conseguenze che ha avuto sul territorio: come un grande canyon, l’infrastruttura attraversa il Veneto congiungendo l’area del vicentino con quella del trevigiano e riducendo i tempi di percorrenza. Tuttavia, questa infrastruttura, anche a causa dell’urgenza politica con la quale è stata realizzata, evidenzia l’arretratezza di una rete infrastrutturale che vede gli spostamenti su gomma come l’unica alternativa possibile.
Osservando l’impatto che la superstrada ha avuto sul contesto su cui insiste, appare disarmante l’assenza di un progetto del paesaggio capace di armonizzare infrastruttura e territorio, laddove è stato adottato un atteggiamento distaccato che ha trasformato il rapporto dell’oggetto antropico con il paesaggio in un freddo collage.
Progetti senza futuro? Dal museo alla fabbrica delle idee
La posizione geografica di Bassano, e soprattutto il suo relazionarsi con la Valsugana e Trento, sono stati visti come elementi propulsivi per un altro progetto ormai arenato: il Polo Museale Santa Chiara. Dopo lo stop dei lavori iniziati nel 2012 per la realizzazione di un primo progetto firmato dallo studio Pession Associato, Sintecna srl e Carlo Aymonino, l’amministrazione ha tentato di legare l’ambizione bassanese di mettere in mostra il proprio museo naturalistico con il ben riuscito MuSe-Museo delle Scienze di Trento. L’accordo di messa a sistema delle rispettive risorse siglato nel 2017 ha rappresentato uno degli ultimi tentativi d’inserire il progetto del polo all’interno di un impianto di ben più ampio respiro che potesse così far ripartire un cantiere ormai fermo da tempo.
All’arenarsi di questa proposta sono seguiti anni d’immobilismo che hanno portato l’attuale Amministrazione a tentare una manovra shock: a seguito di una manifestazione d’interesse da parte della società Pleiadi srl (azienda italiana che si occupa di STEAM Education), si è deciso di abbandonare la vecchia visione per il polo museale e avviare l’iter per un accordo pubblico-privato che porterebbe il Comune ad impegnare una cifra (ancora indicativa) di 22 milioni complessivi di finanziamento e interessi. La nuova proposta, denominata Genius Center, ha sollevato numerose perplessità legate soprattutto alla sostenibilità economica dell’intera operazione e alimentate dal poco rassicurante parere espresso della commissione DIPE (Dipartimento Programmazione e Coordinamento Politica Economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri). L’amministrazione, però, non sembra preoccuparsi di costruire un’alternativa e prosegue l’iter per portare in città il Polo Urbano per l’innovazione. Di fatto la proposta di partenariato porterebbe nelle mani del Comune un’offerta all inclusive comprensiva di progettazione esecutiva, realizzazione dei lavori, finanziamento, manutenzione ordinaria e straordinaria e gestione per vent’anni del polo culturale.
Il progetto dello studio GrisDainese per il Genius Center fa tesoro di quanto già realizzato per quello di Aymonino, andando a creare una quinta alle spalle di una piazza urbana a quota -5,30 m: qui, una letterale “fabbrica delle idee” fa da sfondo alla nuova piazza cittadina. All’interno, una sala conferenze da 100 posti circondata da spazi espositivi con installazioni multimediali dove mettere in mostra il sapere industriale dell’intera area geografica.
La fabbrica dello studio GrisDainese è da inscrivere in un masterplan più ampio che coinvolge tutta l’area che si affaccia su viale delle Fosse (lo storico tratto bassanese del percorso che collega Trento a Padova), l’area delle scuole e il giardino monumentale Parolini. Il masterplan, firmato sempre dallo studio GrisDainese, le cui immagini sembrano abbandonare ogni tentativo di relazionarsi con la realtà, ben descrive la difficoltà di progettare il futuro di un’area in progressivo e quasi inarrestabile declino in un contesto dove non solo mancano le risorse per fronteggiare la crisi della città e delle sue infrastrutture ma, soprattutto, mancano le visioni economico-politiche per tracciarne la rotta verso possibili sbocchi.
Ascensori: pro e contro
Altrettanto avveniristici appaiono gli ascensori che collegheranno la zona del Prato Santa Caterina, parco urbano dal grande (e poco sfruttato) potenziale, a viale dei Martiri, luogo noto per il tragico eccidio del 26 settembre 1944 che è valso alla città la Medaglia d’Oro al valore militare. Di questo progetto si parla da almeno quarant’anni: le due zone della città sono divise da un forte dislivello e la presenza delle due cabine vetrate che risaliranno il pendio favorirebbe il transito. Nonostante il progetto sia frutto di un fitto dialogo tra amministrazione, progettisti e Soprintendenza, resta poco comprensibile la scelta di un percorso di risalita che sembra compromettere il carattere monumentale ed evocativo di un luogo come viale dei Martiri. Le immagini presentate alla cittadinanza portano lo sguardo verso il paesaggio, narrando il basso impatto che l’infrastruttura avrà sul contesto, ma non raccontano l’impatto su viale dei Martiri stesso. La realizzazione degli ascensori, che ha superato la fase di progettazione esecutiva, si è scontrata con l’attuale caro prezzi. La prossima gara d’appalto, se indetta, sarà la terza.
Un altro intervento arenato?
Altro progetto che coinvolge il paesaggio e un contesto delicato, altro accordo pubblico-privato che non trova pace è quello per l’ex macello, un’infrastruttura cittadina del 1858 a pochi passi dal Ponte vecchio. Chiuso per motivi igienico-sanitari negli anni sessanta, poi sede del Centro sociale Stella Rossa fino ai primi anni Duemila, l’edificio ospiterà l’importante collezione d’arte Fluxus della Fondazione Bonotto. Il progetto di riqualificazione era parte di un masterplan del 2010: firmato dallo studio David Chipperfield Architects e promosso da Renzo Rosso e Luigi Bonotto, proponeva il restyling del tratto urbano della Brenta e l’inserimento di un terzo ponte pedonale onde rivitalizzare le due sponde.
Il progetto per la nuova “piazza d’acqua” non è mai andato oltre la maquette se non per l’avvio, nel 2011, del cantiere per la trasformazione dell’ex macello di proprietà della Fondazione Bonotto in un Centro culturale polifunzionale. Il progetto dell’architetto Massimo Muttin per l’ex macello prevede un intervento sul corpo di fabbrica con il restauro della parte più antica, la demolizione dell’addizione novecentesca e la realizzazione di un nuovo volume accompagnato da una terrazza/belvedere pensata per essere cardine tra strada e greto del fiume. Dopo anni di cantieri a singhiozzo, nell’autunno del 2022 la sponda destra della Brenta è stata liberata dalle impalcature a seguito della realizzazione della terrazza. Questa, una volta aperta al pubblico, consegnerà una vista evocativa sulla città. Attualmente, però, forse per il senso d’incompletezza e abbandono in cui versa l’area d’intervento, questo punto delicato della città resta ancora avvolto da tanti punti di domanda.
Al posto delle torri di Portoghesi… il nulla
Lasciamo ora le sponde della Brenta per raccontare un’altra porzione della città toccata dalla mano di una famosa firma. A pochi passi dalla stazione si trova un’ampia area schiacciata tra i capannoni dalla Baxi (azienda leader nella produzione di caldaie), i binari ferroviari e la strada statale che si incunea nella Valsugana: qui avrebbero dovuto trovare casa le dibattute Vele di Paolo Portoghesi. Dopo proteste, comitati, dibattiti, a cui l’architetto romano non si è mai sottratto, nonché mirabolanti performance, come il volo di un dirigibile ad ammonire la popolazione sull’impatto delle due torri nello skyline urbano, nel 2009 il progetto di Portoghesi si è scontrato con il muro del Consiglio Comunale.
Dalle sue ceneri è nata un’interessante proposta che potrebbe dare un nuovo significato ad una zona ora abbandonata e marginalizzata della città. Il progetto, vincitore di una competizione privata indetta dai promotori orfani delle torri, ha portato qui altri progettisti di fama come lo studio trevigiano C+S architects e il paesaggista Andreas Kipar. Ahinoi, anche l’intrigante masterplan per un quartiere multifunzionale, dove inserire in un verde ben progettato residenze, uffici e negozi, non è mai andato oltre i render. Per quest’area, negli anni si sono susseguite proposte per ulteriori cambiamenti di destinazione urbanistica, piani del traffico che prevedevano l’apertura di nuove vie carrabili e tante altre alternative. Purtroppo, quello che resta è un costante abbandono e lento declino.
Il caso Baxi-Pengo e il consumo di suolo
Un’altra proposta che recentemente ha alimentato il dibattito cittadino e politico riguarda il futuro di una porzione di terreno agricolo nella zona sud-ovest del territorio comunale. Qui, la prossimità ad uno dei caselli cittadini della SPV e la vasta quantità di terreno non ancora urbanizzato avevano spinto un gruppo di industriali a chiedere la variazione della destinazione d’uso. L’iter, che all’inizio richiedeva la variazione a produttivo per ben 160.000 mq di terreno, ha collezionato una serie di pareri negativi e ha spinto uno dei committenti a cambiare approccio cercando un accordo pubblico-privato per la variante al Piano, che però ha trovato sul nascere l’opposizione del Consiglio Comunale.
Il caso, poi rinominato “Baxi-Pengo” (per il coinvolgimento delle due società), è interessante non tanto per le dinamiche all’italiana che, come spesso accade, viziano il dibattito e la pianificazione urbanistica, quanto perché ha costretto cittadini, associazioni di vario genere, gruppi d’interesse e amministrazione a una riflessione interdisciplinare sul tema. Indubbiamente, la nuova sensibilità post-Covid e post-disastri climatici non concede più alle amministrazioni di prendere iniziative senza prima fare sintesi tra le molteplici sensibilità che una trasformazione urbanistica coinvolge. Non possiamo più, quindi, pensare a una trasformazione urbanistica che nel suo compiersi non dia priorità alla rivalorizzazione del patrimonio costruito. Infatti, in una regione con più di 92.000 capannoni non possono più passare in sordina ricerche come quelle di Federico Dalla Puppa e Fiorella Angeli (Smart Land srl) sul patrimonio industriale e artigianale del Veneto, presentate durante la Settimana dell’Architettura di Bassano, o progetti come ON/OFF promosso da Assindustria Veneto in collaborazione con le CCIAA di Padova, Treviso-Belluno Dolomiti, le Provincie di Padova e Treviso e il consorzio BIM Piave di Treviso, dove una piattaforma monitora i capannoni in disuso a cui nuove attività potrebbero dare un futuro.
Vocazioni territoriali e ruolo dell’architettura
Quello che emerge da questa carrellata di progetti è il ritratto di una città che non è certo stata resiliente rispetto ai cambiamenti economici e sociali degli ultimi trent’anni. Anzi, in aggiunta all’impossibilità di costruire un’immagine chiara all’interno dei propri confini amministrativi, emerge anche la difficoltà di dialogo con i comuni limitrofi per costruire una visione corale per l’area Pedemontana. Forse, solo il caso della proposta dell’istituzione del Tribunale della Pedemontana è riuscito a varcare i confini comunali senza retorica e strumentalizzazione.
Anche se i progetti incompiuti sono purtroppo lo specchio di una Bassano che fatica a trovare una nuova posizione nella geografia regionale, c’è da dire che in città ci sono anche progetti compiuti recentemente e nuovi cantieri da raccontare. C’è il restyling del Ponte della Vittoria, più noto ai bassanesi come Ponte nuovo, che nonostante la necessità di un intervento su una struttura in cemento armato ormai in evidente stato di sofferenza, ha dimostrato per l’ennesima volta la fragilità del sistema viario cittadino. Ci sono le scenografiche Bolle di Nardini aperte nel 2004 per festeggiare i 225 anni della Distilleria Nardini, uno dei pochi progetti che lo Studio Fuksas ha realizzato in Italia. Da registrare anche l’ampliamento dell’Istituto agrario Parolini a firma dello studio MIDE: il progetto, che si realizzerà grazie ai fondi Next Generation EU del PNRR, porterà un’architettura di qualità nella conca degli Ulivi, al confine con il comune di Pove.
Questa sensibilità per l’architettura sta lentamente tornando tra le priorità dei committenti, come registrato anche dalle prime due edizioni del Premio di Architettura Città di Bassano del Grappa, un’iniziativa che accompagna il racconto sull’architettura contemporanea mettendo sotto i riflettori i progetti dell’area Pedemontana e dei territori della Brenta.
Uno spunto per il futuro: l’iniziativa forse dovrebbe dialogare meno con i professionisti e gli addetti del settore e provare a coinvolgere maggiormente la cittadinanza per riavvicinarla a un’architettura che, soprattutto in quest’area del Veneto, fa fatica a diventare parte attiva di grandi e piccoli cambiamenti urbani.
Immagine di copertina: Vista da Ponte della Vittoria (© Tommaso Mauro)
About Author
Tag
concorsi , david chipperfield , fuksas , infrastrutture , Paolo Portoghesi , pianificazione urbana , ritratti di città , veneto
Last modified: 12 Dicembre 2023