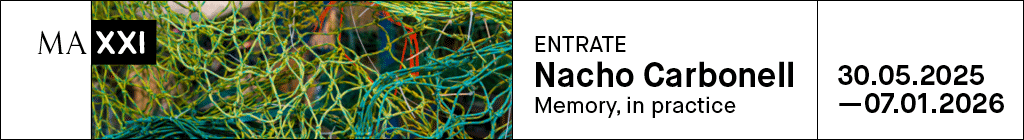Un ricordo dell’architetto ticinese, a partire dal suo pensiero radicalmente anticonformista sulla città e sul territorio
Lio Galfetti è stato un grande maestro. Dava il meglio di sé quando aveva in mano la matita e raccontava agli studenti, con pochi segni espressivi sulla carta, i concetti insediativi che voleva comunicare. Guardava avanti, spiazzando le convinzioni più consolidate sulle opzioni in campo, per trasformare il territorio compromesso dal disordine e dalla diffusione insediativa, escludendo dal suo pensiero ogni forma di nostalgia.
Il suo pensiero – poco conosciuto fuori dal Ticino – era radicalmente anticonformista. Riconosceva il territorio così configurato come “strato di fondazione” della nuova città. “La città diffusa”, scriveva nel 1996, “è il primo strato, quello che è stato costruito dove l’uomo non aveva mai costruito, è la prima occupazione di un territorio… Invece di proporre la tabula rasa, occorre rinnovare lo stesso processo che ha creato le nostre belle città storiche: un lavoro di continua trasformazione che sa leggere, negli spazi embrionali della città diffusa, la speranza di una città migliore”.
“Gli architetti sono, per lo più, in preda ad una specie di schizofrenia”, sosteneva ancora Galfetti, “per cui progettano e costruiscono la città diffusa, approfittano e vivono della libertà che questa città offre, ma nello stesso tempo non accettano la vera natura della città che loro stessi, tutti i giorni, costruiscono”. La sua vera natura è di essere casuale, non progettata, e di apparire brutta, indefinita, consumistica, ecologicamente sbagliata, inquietante, ma anche di essere aperta, ottimista, democratica, corrispondente al nostro tempo. È una città diversa perché diversi sono i valori che l’hanno costituita, a cominciare dal dominio culturale del mezzo di trasporto individuale, e dalla libertà che esso consente.
Attenzione, non c’è alcun giustificazionismo nella riflessione di Galfetti. Al contrario il suo realismo c’indica la strada percorribile dalla disciplina urbanistica per riscattarsi dalla sconfitta completa subìta negli ultimi decenni. La strada di non rifiutare in blocco la condizione data ma di partire da essa, di conoscerla come un sistema spaziale in via di formazione, in continua evoluzione, nel quale “ogni progetto parziale è un’occasione per trasformare il tutto“. E sono gli spazi pubblici la chiave progettuale che Galfetti indicava per modificare l’attuale situazione. Gli spazi pubblici che distinguono la città storica (quel “grumo di materia più densa” nella galassia del territorio), che la rendono rassicurante e che mancano nella città diffusa.
È falso, diceva, il luogo comune per cui la periferia sia uguale in ogni città ed in ogni regione, che sia il simbolo della modernità che avrebbe cancellato le identità locali. “In qualsiasi periferia mi dovessi trovare”, scriveva Galfetti, “riconoscerei il paese, il paesaggio e la città a cui appartiene… Permane sempre un legame tra centro e periferia, profondo e vitale, una relazione che connota chiaramente qualsiasi periferia in qualsiasi parte del mondo”. La verità è che la città contemporanea nasce nella periferia, che “la periferia è il cantiere della nuova città”. È il luogo della speranza, bisogna saperne cogliere i segni positivi per attribuirvi durata e spazio.
La scuola, aggiungeva, è ancora inadeguata ai nuovi compiti, perché più spesso ospita una cultura urbanistica storicista: “Tutti sanno cosa fare nei centri storici, pochi sanno progettare la periferia”, senza mimetizzare nel verde lo svincolo autostradale, costruito unicamente con criteri viabilistici, oppure senza mimetizzare i ghetti produttivi, concepiti come mali necessari. La nuova città aperta ha bisogno di una dose massiccia di progettazione territoriale, di nuova cultura del territorio, di una poetica fondata sulle relazioni tra fatti urbani finora sconosciuti o considerati solo come funzionali. Non si tratta più di declinare extra moenia le regole insediative accumulate nel passato per la città storica, ma di affrontare un nuovo spazio disciplinare esteso, frammentato e ibrido, dove ricostruire regole e ordine, usando le vecchie regole come materiale da scomporre e ricomporre, per governare la nuova realtà senza perdersi nella sua dimensione inusitata. È una nuova vastissima dimensione, offerta da queste riflessioni a chi si occupa del territorio a tutte le scale. Ed è anche una sfida aperta a chi sostiene che il mestiere dell’architetto è destinato ad esaurirsi. Negli anni successivi a queste riflessioni, pensatori importanti come Rem Koolhaas hanno elaborato pensieri paralleli e assonanti con il suo.
Le sue opere costruite – certamente più conosciute del suo pensiero – sono una prova di formidabile coerenza con le sue riflessioni, a cominciare dal progetto del Bagno di Bellinzona (1967-70, con Flora Ruchat e Ivo Trümpy), che è forse l’architettura più significativa di quella epica fase fondativa della modernità ticinese. Un’opera relativamente piccola, che dimostra la capacità dell’architettura di interpretare un luogo intessendo relazioni importanti con il contesto di un territorio più vasto. Il restauro di Castelgrande a Bellinzona è un esempio, invece, di trasformazione di un bene culturale abbandonato in uno spazio legato alla città e alla sua storia e, insieme, così contemporaneo da divenirne il simbolo. Come La Rotonda di Locarno, che risolve un grande tema viabilistico ribaltando l’ingresso alla città e realizzando un nuovo importante spazio collettivo.
L’intensa sensazione dell’umanità straordinariamente dolce e generosa di Lio Galfetti ci accompagna nel suo ricordo.
Immagine di copertina: Aurelio Galfetti (a sinistra) all’Accademia di Mendrisio, con Martin Bösch, Sergio Crotti e gli studenti
About Author
Tag
canton ticino , svizzera , teoria dell'architettura
Last modified: 14 Dicembre 2021