Intervista al presidente della Biennale di Venezia alla vigilia dell’apertura della 16. Mostra Internazionale di Architettura
L’ambizioso fine d’una mostra unica al mondo, il prioritario dialogo con il visitatore, il proprio personalissimo Freespace. Intervista a Paolo Baratta, presidente della Biennale di Venezia, che in merito al tema della 16. Mostra Internazionale di Architettura confida: “Ho sempre desiderato si parlasse anche di spazio, quello che si crea attraverso l’architettura, che si fa segno della sua presenza, che a tutti appartiene. Il bello di questa mostra è che sotto le mentite spoglie di una piccola utopia aggraziata, alla Candide (il dono, le sue meraviglie…), si cela la provocazione, il netto richiamo ad altri tipi di problematiche, alle condizioni che non consentono a quei doni di emergere. Sono doni tutti potenziali ma in prigione. Il nostro problema? Farli uscire dal carcere”.
Il tema di quest’edizione segue la linea programmatica tracciata nel 2016: l’architettura è intesa come strumento di organizzazione della società civile ed è investita d’un ruolo di responsabilità sociale. Alla Biennale è affidato il compito di stimolare la riflessione. Nei sei mesi precedenti la vernice abbiamo avuto a disposizione il Manifesto delle due curatrici che si presta a molteplici interpretazioni, linee guida, parole chiave ed exempla. Non crede che fornendo maggiori dettagli, non tanto allestitivi quanto su ciò che concretamente avremmo trovato in mostra, si sarebbe aiutato lo sviluppo del dibattito da parte della stampa, specializzata e non?
Dobbiamo rimanere sempre fedeli a che cosa sia una Biennale. La Mostra di Architettura, nata dalla costola della Mostra d’Arte e costruita con gli stessi modelli, si fonda sull’aspetto visivo, sull’impatto emozionale che induce pensieri, riflessioni, dialoghi. È certamente un qualcosa di molto lontano da una conferenza internazionale sull’architettura, un dibattito o una mostra storico-monografica. La Biennale Arte è un tappeto di scherma tra il visitatore e l’opera; quanto vi viene esposto non è ordinato secondo modelli preconcetti bensì è offerto al pubblico come sfida.
Così anche la Biennale Architettura deve alla fine parlare direttamente al visitatore: i messaggi che comunica possono essere diversi e i fili conduttori possono esser più d’uno ma la discussione difficilmente può avvenire prima sulla base di un documento scritto. Se così fosse allora si tratterebbe d’un congresso e io non chiedo ciò ai nostri curatori. L’architettura in Italia è molto accompagnata dalla parola parlata e scritta delle riviste, dei convegni, dei congressi. Io non voglio aggiungere un ulteriore dibattito sull’architettura in un Paese che ha bisogno esattamente dell’opposto. 70.000 studenti d’architettura non vogliono un dibattito, vogliono un luogo nel quale l’incontro con l’architettura possa generare maggior desiderio della loro opera. Per questo c’è una mostra lunga 6 mesi. Abbiamo fiducia che quegli oggetti così disposti e il dialogo che nasce attorno ad essi possano indurre a mutamenti nei visitatori. È un’ambizione sconfinata che va, forse, oltre il realistico ma questa è la funzione che attribuiamo alla nostra Biennale.
Quindi lei ribadisce la necessità del momento esperienziale che può concretizzarsi solo con l’apertura della mostra…
Direttamente attraverso la visita. Il periodo di apertura della Biennale a cui sono più affezionato coincide con le settimane del mese di ottobre, quando vi sono più visitatori che non durante il Vernissage. Noi non spendiamo un soldo di campagna pubblicitaria così come non facciamo propaganda per attirare Paesi: non ho mai alzato il telefono in questi anni per sollecitare una partecipazione nazionale e tutti quelli che vengono lo fanno per loro scelta. Abbiamo il compito fondamentale di stabilire con il visitatore un rapporto di fiducia, senza condizionamenti. Io devo portare il visitatore all’architettura come all’arte nel suo momento germinale. Poi ben vengano i critici, le riflessioni, le discussioni, le classificazioni… Ribadisco che la Biennale non è tra gli strumenti che promuovono una conoscenza per classificazione. Essa va considerata tra gli strumenti che promuovono la conoscenza attraverso l’emozione visiva.
Pensi anche al titolo di quest’anno, Freespace. Personalmente ho sempre desiderato che si parlasse anche di spazio, quello che si crea attraverso l’architettura, che si fa segno della sua presenza, che a tutti appartiene… Lo spazio gratuito in questa mostra è ricondotto alla qualità del progetto e all’atto di generosità che sta nel promotore. In Aravena (nel 2016, ndr.) c’era la fenomenologia che ci porta alla realizzazione di opere di architettura. La scelta di questa edizione (la parzialità di visione è propria a ogni Biennale) è quella di concepire l’architettura come dono, come Freespace della generosità… È chiaro che bisogna poi attuare una serie di processi affinché questa generosità si manifesti.
Ci saranno anche esempi del fallimento di Freespace, ossia di ciò che nell’idea progettuale nasce come tale e poi non lo diventa per ragioni diverse: sociali, politiche, gestionali?
Mi auguro di sì. Ricordo che nella mostra di Koolhaas (nel 2014, ndr.) erano molti i fallimenti. Monditalia era una sorta di “festival” di una decina di fallimenti su come non si deve gestire il territorio. Quest’anno stiamo lavorando ad esempio con il Victoria and Albert Museum per un progetto specifico (nel Padiglione delle Arti applicate, ndr.) che presenta un bel fallimento: la demolizione dei Robin Hood Gardens, il quartiere popolare nell’East London che ha lasciato una voragine. Certo, se dovessimo fare la mostra del freespace mancato, avremmo bisogno di una superficie ben superiore a quella ad oggi disponibile, ma io continuo a pensare che la Biennale debba fornire utopie, sollecitare le menti a considerare che le cose potevano essere fatte in modo diverso. Utopie però non intese come utopiche soluzioni, bensì come progetti. C’è necessità di esempi. Non avendo più fiducia nei grandi disegni, nel delegare le conquiste a un disegno sociale, politico, tutti ci ritroviamo individui più soli e siamo così chiamati ad arricchire il nostro bagaglio di conoscenze per orientarci. Io chiamo questo una “necessità di riattrezzarci culturalmente”. Per questo facciamo una mostra così lunga: perché abbiamo la consapevolezza di un ruolo di trasmissione di strumenti, di “riattrezzatura” culturale dei visitatori, tra i quali ci sono anche personalità investite di responsabilità pubbliche.
Prima lei citava le partecipazioni nazionali: come giudica la loro risposta al tema?
Mi sembra che il tema sia stato compreso. Mi aspetto anche diverse declinazioni riferite, ad esempio, ai processi di urbanizzazione e conurbazione che hanno conosciuto uno sviluppo stratosferico negli ultimi 50 anni. Poi però si viene a scoprire che in megalopoli come Città del Messico o Mumbai il vero nodo è la mancanza di spazio pubblico.
Su questo sembrano riflettere Paesi come gli Emirati Arabi con un’inversione: dalla grande alla piccola scala nello spazio del quotidiano…
Dobbiamo fare attenzione a indirizzi compiacenti, come quello che afferma che lo spazio pubblico oggi sia da ritrovarsi negli aeroporti e negli shopping center (che ormai sono la stessa cosa), ma lì siamo accolti come consumatori e non c’è nulla di free.
C’è poi un altro pericoloso compiacimento: noi proponiamo una Biennale che riguarda lo spazio pubblico fisico in un’era in cui può serpeggiare il concetto che non ne abbiamo più bisogno, perché abbiamo ottenuto lo spazio libero virtuale. L’essere collegati con i molti (dunque a troppi) ha sedotto di più che sviluppare concrete connessioni con i pochi. Io invece sono stato catturato dalla grande vetrata che caratterizza l’edificio della Bocconi a Milano, progettato da Farrell e Mc Namara, attraverso la quale la città di Milano “entra” nella sua università.
Qual è il suo personale Freespace?
Non sono romano ma adoro Roma e la sua architettura. Lì ho imparato il concetto di freespace, lì l’architettura mi è sempre parsa lo strumento in base al quale il singolo, nel momento in cui realizzava, pensava contemporaneamente a se stesso e a ciò che era lo spazio davanti a sé. Quest’idea dell’architettura come arte bifronte, duale, quindi arte politica per eccellenza… passeggiando per Roma l’avverto intensamente, così come l’avverto quando arrivo a Venezia, la notte, e attraverso il Canal Grande.
Non ha quindi un luogo d’elezione in cui lei si sente particolarmente libero o accolto?
In realtà ci sarebbe un altro freespace che però non è proprio mio in particolare. Quando vado a New York salgo su un taxi a Central Park e dico che ho un appuntamento urgente a Wall Street perché adoro correre come un matto lungo le strade di New York e percepirne gli spazi ad alta velocità… La sento come una città che ha pensato prima al freespace e ha stabilito una prima griglia sulla quale ai privati è stata data la possibilità poi di costruire.
Quanto racconta sembra in linea con il padiglione russo che, secondo le anticipazioni, nel proprio Freespace include non solo la stazione e le linee infrastrutturali ma anche la percezione dello spazio che l’individuo ha nel percorrere le distanze. Lei però sta citando tutti esempi più urbani che architettonici…
La città è pur sempre il frutto di una moltitudine di pensieri architettonici. Provo un grande senso di piacere quando avverto che uno spazio non è stato creato per me in quanto proprietario o consumatore ma in quanto camminatore e ciò può avvenire anche all’interno di una chiesa, di un edificio, di un cortile. Credo che questo sia il primo passo verso un’educazione al freespace. Esso è parte di una ricchezza nazionale che non è rilevata statisticamente. L’architettura, in questo senso, è intesa come una forma di benessere per dare una compiutezza all’uomo che vive negli spazi creati per sè. Oserei quasi parlare di architettura come “Costituzione nascosta” che riconosce quali siano i miei diritti come parte di una comunità.
Riappropriarci di uno spazio attraverso una mostra di architettura significa molte cose: la prima è desiderare quello spazio, la seconda è la consapevolezza anche di ciò che tutto questo implica in termini di legislazione, risorse e dotazione di poteri. Viviamo in una situazione in cui la legislazione urbanistica ha avuto anni di turbini e decentramenti; siamo un Paese che ha davanti a sé il problema del post edificato e alle spalle una valanga di singoli edifici, intere aree che avranno sicuramente bisogno di un’azione nei prossimi decenni. Ma a riguardo ancora “balbettiamo”.
Queste problematiche emergeranno attraverso il lavoro di Mario Cucinella al Padiglione Italia…
Cucinella ha fatto un lavoro interessante. Sappiamo bene che in Italia esistono tanti bei borghi, ma nell’impostare il nostro futuro dobbiamo avere una politica attiva non solo riferita a una destinazione ricettiva e turistica. Quale sia il futuro di queste realtà è un tema importante. Diversamente una parte del territorio verrà abbandonata a un utilizzo solo di tipo vacanziero e sporadico. Quando si parla di legislazione urbanistica e di poteri decentrati bisognerà tenere conto anche di queste situazioni. Un paese dell’Abruzzo non è uguale a Milano. I soggetti in campo meritano un’attenzione diversa: pensi anche alle isole. È un problema tutto italiano che non mi pare sia al centro del dibattito programmatico e politico di questi giorni. Ecco, noi ci faremo testimoni anche di questa esigenza.
Vede, il bello di questa mostra è che sotto le mentite spoglie di una piccola utopia aggraziata, alla Candide (il dono, le sue meraviglie…), in realtà si cela la provocazione, il netto richiamo ad altri tipi di problematiche, alle condizioni che non consentono a quei doni di emergere. Sono doni tutti potenziali ma in prigione. Il nostro problema è quello di farli uscire dal carcere.
Immagine di copertina: Paolo Baratta ritratto da Andrea Avezzù – Courtesy of La Biennale di Venezia
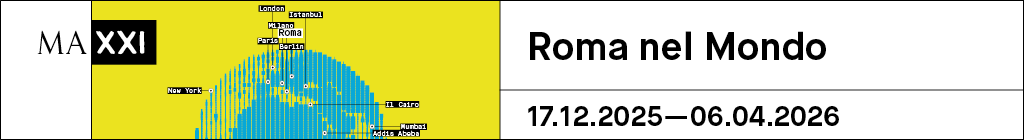

























[…] Paolo Baratta: dietro l’utopia aggraziata di Freespace si cela la provocazione di Veronica Rodenigo […]