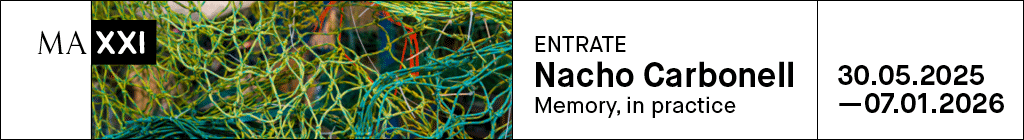Quali sono i problemi maggiori che ha incontrato in questi dieci anni di amministrazione di Torino? Quali i più difficili ancora da risolvere?
Il primo problema che resta da risolvere è quello della pubblica amministrazione e del suo funzionamento, perché la macchina comunale, pur avendo alcune eccellenze di primo livello, si muove troppo lentamente rispetto ai problemi della società. In parte per questioni normative e legislative, in parte anche per un atteggiamento da «depositari della Norma» che rende sempre il rapporto con il cittadino come un qualcosa fatto cadere dallalto, e non viceversa. È secondo me una questione di cultura generale, che spesso si riscontra anche in persone di livello professionale molto elevato. E purtroppo si riesce a superarla solo episodicamente, quando interviene il sindaco, lassessore, quando cè una «spinta esterna».
Un secondo problema è quello del «rapporto con la politica»: una questione che dovrebbe sollecitare una riflessione sulla nuova legge elettiva dei sindaci nei Consigli comunali. Se fossi un docente di Scienze politiche, assegnerei ai miei laureandi una tesi empirica: classificare per tipologia le proposte pervenute alla Giunta dal Consiglio comunale. Probabilmente si scoprirebbe che salvo lodevoli eccezioni (la proposta di istituire il testamento biologico, per esempio) latteggiamento più frequente del Consiglio è molto più frenare ciò che viene proposto dalla Giunta che non promuovere. Questo perché forse la legge è fatta in maniera tale che allesecutivo sia dato il compito dinterpretare la visione del governo e avere un ruolo di promozione, mentre al Consiglio sia attribuito il ruolo dinterpretare una società che, come si sa, tende sempre a essere restia al cambiamento. Varrebbe la pena di pensare a una legge che distingua più nettamente lesecutivo dal legislativo, per esempio dividendo il Consiglio in collegi uninominali. In questo modo si parlerebbe con meno persone, invece degli attuali 50 o anche solo 30 consiglieri, ognuno dei quali però rappresenterebbe le 15-18.000 persone che li hanno eletti. Si parlerebbe con pezzi di città autentica.
Questi sono solo due esempi che ho verificato in tanti campi. Penso a tutto il problema delle aziende «ex municipalizzate» e, in relazione a queste, al problema economico-finanziario del Comune. Si tratta della terza grande questione: non cè dubbio che in quel caso ci sarebbe stata lopportunità e la necessità di avviare interventi innovativi, senza mettere in discussione il dovere del Comune di mantenere il controllo e lindirizzo di queste aziende. Si poteva innovare molto di più di quanto non si sia riusciti a fare. Questo è anche conseguenza dei problemi del rapporto con la politica. Mi chiedo: se il Consiglio comunale fosse stato composto anziché da un certo numero di partiti da 30 consiglieri, magari eletti in maniera meno favorevole alla maggioranza che mi sostiene, chissà se sarebbe stato lo stesso.
A questo proposito, la capacità progettuale di una Giunta, di costruire cioè progetti di medio-lungo periodo, necessita anche di supporti scientifici e tecnici. Quali sono i piani specifici di una dimensione metropolitana su cui bisognerebbe esercitare questa capacità progettuale, al di là del sistema dei trasporti, che certamente oggi è il più evidente e anche il più delicato per Torino?
Penso che la dimensione metropolitana potrebbe essere loccasione per ripensare lintero impianto della legislazione urbanistica vigente. Oggi cè una pianificazione territoriale provinciale, ma questa dimensione è troppo vasta per consentire una programmazione urbanistica che non sia solo di generici indirizzi. Una dimensione metropolitana potrebbe consentire di avere una programmazione urbanistica un po meno «normativizzante» di quella del Prg del Comune, ma che al tempo stesso non sia solo un generico indirizzo, che per grandi realtà cominci a definire criteri per linsediamento, per la trasformazione, lasciando poi al livello dei singoli comuni che la compongono la possibilità di tradurli in vera e propria normativa e regolamentazione.
Attenuerebbe anche i conflitti che si creano sulle funzioni privilegiate
Certo, perchè poi esistono porzioni di territorio che hanno un valore particolare ai fini della programmazione e dellattrattività, e altre meno: bisognerebbe che questi valori fossero condivisi e compensati. Sarebbero forme di perequazione compensativa che una legislazione regionale intelligente potrebbe anche incentivare, per esempio. Tutto questo però si scontra contro il fatto che per ora passi in avanti non se ne sono fatti, né legislativamente, come è noto, né in una politica che parta dal basso: e questo resta un problema.
Una questione particolarmente sensibile è quella della difficoltà di creare futuro per le giovani generazioni. Come lha vissuta da sindaco, quali sono stati i momenti belli e i più difficili?
Per fortuna momenti davvero difficili non ce ne sono stati; è difficile trovare qualcuno che ci addossi errori macroscopici. Non a caso largomento cui si appiglia chi ha ruoli istituzionali di opposizione è quello del debito. Occorre però precisare che cè un debito buono e uno cattivo, perché i Comuni, a differenza delle Regioni e dello Stato, non possono fare debito per pagare i deficit, e quindi gli stipendi e la spesa corrente. Il nostro debito è buono, perché finalizzato a investimenti. Guardiamo alle cose che abbiamo fatto: la metropolitana, una parte degli investimenti per le Olimpiadi, il termovalorizzatore, il teleriscaldamento, ristrutturazioni significative di parti di città: sono opere che restano negli anni; se non si finanziano a debito queste, cosa si finanzia? Oltretutto sono opere che hanno creato lavoro e un effetto positivo, di dimensione della trasformazione che ha fatto scattare un meccanismo di percezione del riposizionamento della città anche in chi vi abita e lavora. Per non parlare dellUniversità e del Politecnico, tra le punte di diamante torinesi nella capacità di riposizionarsi. Anche qui gli atenei non sono indenni dai costi degli enti locali.
Io però non ho lossessione del debito: più si parla più si scopre che non cè ambito della vita cittadina in cui non siamo intervenuti con operazioni strutturali, che quindi hanno costi. Certo, si potrebbe obiettare che si sarebbe potuto fare di meno e più gradualmente, ma non si sarebbe avuto lo stesso effetto: le Olimpiadi erano allora e non torneranno per molto tempo. Aver colto loccasione per fare coincidere opere infrastrutturali e di riqualificazione del centro storico, ad esempio, è servito a produrre anche questo effetto. Ovviamente, ciò ha comportato un aumento del debito, ma è un debito sotto controllo e che tutto sommato sarà pagato anche dalle generazioni che più di noi utilizzeranno queste opere.
Se si pensa allimmagine di Torino ventanni fa e si guarda la città comè oggi, le trasformazioni sono evidenti
Quando abbiamo iniziato, Palazzo Madama era chiuso, il Museo Egizio (salvo alcune parti) sembrava un deposito di beni dinestimabile valore, il Museo dellautomobile era un garage, quello del Cinema era lunico che aveva sembianze visitabili tra i principali musei, il Museo dArte orientale non esisteva. Tutte le riqualificazioni in questo settore hanno creato attrattività a un livello elevato che fa sì che Torino abbia meno di altre città bisogno di ricorrere allestemporaneità di organizzatori di cultura.
Come presidente dellAssociazione nazionale dei comuni italiani, nel riposizionare Torino con queste politiche strutturali sui beni, sui servizi, sullassistenza, qual è la differenza che più coglie con altre «tipologie» di città?
Per esempio, il fatto che Torino si collochi al di sopra dei traguardi indicati dal trattato di Lisbona relativi al rapporto tra posti disponibili e bambini negli asili nido e nelle scuole dellinfanzia è un altro segno di una città che non ha fatto solo mattoni, come dice qualcuno, ma si è impegnata nelle funzioni educative di base. Oppure lo sviluppo delle politiche di assistenza soprattutto sul piano della cosiddetta domiciliarità, che aiuta molte persone in difficoltà, disabili o malate. È molto difficile definire delle tipologie. Cè unarea di città medie, tra i 50 e i 200.000 abitanti, che hanno reti di servizi adeguate, ma che in genere si trovano nelle zone più ricche. La differenza che si vede con nettezza è tra il Nord e il Sud. Al Sud, a eccezione di città come Salerno e in parte Bari, la diversità dai casi omologhi di Toscana, Veneto, Emilia o Lombardia è significativa. Nel Mezzogiorno, tranne Napoli e Palermo, le città capoluogo hanno conosciuto una crescita più che proporzionale rispetto alle risorse delle aree in cui sono collocate.
Vedo piuttosto le difficoltà delle aree metropolitane, legate soprattutto ai problemi della mobilità e dellinquinamento: occorrerebbe dare risposte in tempi brevi e poter disporre subito di tanto denaro, ora non disponibile, finalizzato a interventi precisi. Non so se questa fase federalistica riesca a dare davvero delle risposte: per i Comuni, nella migliore delle ipotesi, nel 2014 si potrà tornare a una situazione simile a quella precedente alleliminazione dellIci, che sarà per certi versi migliore, per altri peggiore. Per quanto riguarda il resto, se non vengono messe in discussione le prerogative e i privilegi, soprattutto dal punto di vista fiscale, delle Regioni a statuto speciale, e se non viene fatto un discorso chiaro su quali sono i fabbisogni e i costi standard con cui soddisfarli, il rischio, se non si vuole aumentare la pressione fiscale, è di non garantire alle regioni che ne hanno bisogno le risorse per raggiungere quegli standard. È unillusione, quella che si racconta alle regioni del Nord, che si potranno avere più risorse per finanziare lo sviluppo, le infrastrutture, a meno di non mettere in conto che occorre aumentare la pressione fiscale. Questo nasce anche dal fatto che un federalismo fiscale senza il riordino del sistema fiscale nazionale è una contraddizione in sé: ciò fa nascere in me molte preoccupazioni sul fatto che i problemi che abbiamo come insieme di autonomie locali possano essere risolti da questa fase federalista, a meno che non intervengano dei correttivi.
Che cosa lascia a Torino, e quali sono secondo Lei le priorità da affrontare da parte di chi governerà la città?
Io credo di lasciare un lavoro in cui le risposte a diverse questioni sono perlomeno imbastite. Penso al tema del lavoro: è chiaro che qui a Torino non possiamo rinunciare al carattere industriale della città. Quando si parla di Mirafiori e di mettere insieme la ricerca universitaria e lindustria, mi sembra si cerchi proprio di rispondere in questo senso. Si lascia un percorso che spero possa conoscere sviluppi successivi. Lo stesso per laspetto infrastrutturale: lasciamo la Variante 200, che dovrebbe accompagnare metà della linea 2 della metropolitana, un progetto che può consentire nel giro di altri dieci anni di dotare la città di un sistema di trasporto finalmente efficace, col quale si può iniziare a pensare significative opere di riduzione della circolazione privata.
Certamente cresceranno i bisogni sociali, perché cresceranno le esigenze che verranno dai nuovi torinesi, dagli immigrati, che sono una realtà sempre più significativa, quindi la funzione educativa non può che necessitare di nuovi sviluppi.
Credo poi che restino due grandi questioni che non dipendono solo da noi. Una è quella del funzionamento della macchina amministrativa. I cambiamenti devono avere un forte carattere strutturale, anche dal punto di vista normativo. Faccio sempre questo esempio: se un privato fosse stato nelle nostre condizioni, avendo lavorato per dieci anni con un pool dimprese che hanno realizzato la metropolitana, senza un infortunio sul lavoro, né condannati, né inquisiti, e avrebbe detto: «cè ancora un km da fare, fatelo voi». E avremmo guadagnato un anno e mezzo di tempo. Invece il pubblico dice no, si smonta, si rifà la gara e si perdono tre anni. Questo è un esempio, che però prevede un cambiamento radicale della concezione della pubblica amministrazione. Non può farlo il sindaco, sebbene sia un problema con cui si misura quotidianamente. Così come il problema finanziario e quello della politica. Su questo, sarò viziato da pessimismo ma è raro vedere la politica laddove essa non sincarna in qualche modo nellesecutivo di unamministrazione che esprima una tensione verso il futuro. Lunica risposta che so darmi è che chi amministra non è per definizione più lungimirante. Chi amministra si deve misurare con la società. Ed è da lì che arrivano gli spunti. È finito il tempo – e bisognerebbe prenderne atto -, in cui era la politica che permeava la società: oggi è il contrario, la politica semmai deve saper stimolare, far lievitare le energie che ci sono nella società.