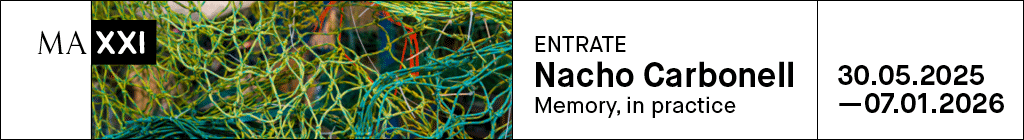Partiamo da qualche considerazione sulla storia e sullarchitettura e sul loro essere considerate, o meno, discipline scientifiche. Esiste il concetto di falso o di autentico in architettura?
Il concetto di copia mi fa pensare in effetti al metodo scientifico: utilizzare le prove sembrava lunico modo per potere evitare ogni tipo di falsificazione, poiché si basa su un processo di natura empirica che conduce a un certo tipo di sperimentazione.
Possiamo copiare idee in architettura?
Non credo, ogni cultura ha una sua diversa tradizione. Condivido completamente ciò che diceva Zygmunt Bauman. Nel libro Cultura come prassi (1973) insiste, soprattutto allinizio, sul fatto che non ci può essere uninnovazione culturale sostanziale senza tradizione, e che non si può avere tradizione senza innovazione. Io credo sia vero. Egli sottolinea inoltre che questi due aspetti non sono separabili, e io lo sottoscrivo per intero. Penso che la tradizione sia essenziale. E sono daccordo anche in un senso più ampio. Cè un aforisma molto bello e provocatorio di un filosofo catalano, Eugenio DOrs, che afferma: «Tutto ciò che non è tradizione è plagiarismo».
Possiamo paragonare questa distinzione tra tradizione e innovazione con quella tra storia e teoria, se consideriamo la storia come legata alla tradizione, qualcosa che può essere scritto solo a debita distanza.
Non sono daccordo con questa distinzione. Pensi ai miei scritti, in particolare alla serie di articoli che ho raccolto sotto il titolo di Labour Work and Architecture riferendomi ad Hannah Arendt (la quale parlava di Labour, Work and Action, ndr). Allinizio dellintroduzione distinguevo tra storia, teoria e critica perché leditore ha suddiviso i miei testi in tre categorie; se non fosse stato per lui forse non lavrei fatto. Nellintroduzione mi domandavo, appunto, cosa sono io? Un teorico? Non credo. Uno storico, non credo nemmeno questo. Un critico. Nemmeno di questo sono poi tanto sicuro. Scrivo di architettura. E in genere ho sempre rifiutato la distinzione tra storia e teoria. Può forse riguardare qualcunaltro ma non me. Ho scritto alcuni testi che avevano un taglio più critico, altri più storici. Non penso di avere scritto molti testi che possano considerarsi come teorici. Towards a Critical Regionalism: Six Points for an Architecture of Resistance è considerabile un testo teorico? Direi di no.
Già allora parlava di unarchitettura che fosse in grado, grazie alle proprie caratteristiche e tradizioni, di fronteggiare una società in cambiamento. Ora larchitettura sembra in un perenne stato di emergenza, di crisi. Cè sempre stata una sorta di crisi allinterno della nostra disciplina?
Un argomento interessante è quello che riguarda la tradizione, un altro è invece quello che concerne il concetto di crisi. Tendiamo a misurare ogni evento in relazione alla nostra vita personale e agli eventi che la riguardano, ma questi sono sempre parte di una traiettoria. Se per esempio ci riferiamo a quella che viene chiamata modernità o anche al contemporaneo, tendiamo a parlarne come di qualcosa che sta finendo o è finito. Non è molto rilevante. E non ha nemmeno molto senso poiché il processo nella sua totalità è più lungo della durata della vita di ciascuno di noi. Uso una metafora, che peraltro non ho inventato io, quella di unonda. Il punto in cui questa si rompe non può essere determinato realmente, non sappiamo quando londa finisce esattamente. La stessa cosa succede con il concetto di crisi. È ciò che ho scritto alla fine della quarta edizione in Modern Architecture: a Critical History. Stiamo ancora vivendo in quel momento.
Torniamo agli scritti di Hannah Arendt, in particolare al libro The Human Condition; lei cercava di teorizzare una metodologia. Abbiamo sempre bisogno di altre discipline? Larchitettura non può proprio rimanere autonoma?
Ultimamente ho letto il libro di Michael Tawa, Agencies of the Frame: Tectonic Strategies in Cinema and Architecture, in cui si constata come larchitettura sia sempre architettura più qualcosaltro e mai concepita come qualcosa di indipendente. Inoltre, se si utilizza il termine «cultura costruttiva» (Building Culture) anziché il termine «architettura», che rimanda a qualche classica idea trascendentale di un rinascimento europeo, il significato cambia? La parola cultura si riferisce anche a qualcosa di materiale, perché dipende da condizioni e tecnologie locali. E credo sia interessante constatare come a un certo punto tecnologia e cultura non possano essere separate. Le culture costruttive sono simili, ci sono delle tecniche costruttive oggettive ma sono anche mediate culturalmente. Ad esempio, una cultura del cibo è sempre mediata in qualche modo dal luogo in cui ti trovi.
In un certo senso, non è strano che larchitettura debba sempre confrontarsi con altre discipline, del resto si confronta con la gente, lo spazio, i materiali
Con la materia e con i materiali. Cè un bel libro scritto dallo storico inglese Edward Hallet Carr, che si è sempre occupato della storia dellUnione Sovietica e ha trasformato una serie di sue conferenze nel libro What is History? In questo libro piccino il punto centrale è come ogni epoca scriva una storia differente, non esiste una storia oggettiva ma ogni età riscrive la propria storia. Ci sono naturalmente i fatti, ma poi esiste linterpretazione di questi e ogni storico, me incluso, deve prenderne atto. Deve rendersi conto che lo storico compie delle scelte. A proposito mi torna in mente un altro aforisma, di Max Planck, per il quale non esistono domande alle quali non si può rispondere, ci sono solo domande mal formulate. In sostanza secondo lui una domanda è già parte della risposta. Non esistono domande ingenue o innocenti. La domanda è già metà della risposta, e soprattutto le domande non sono oggettive.
Dovrebbero esserlo?
No. È unasserzione molto positiva e realistica. E la approvo completamente. Negli anni sessanta eravamo pieni di persone che volevano essere risolutori di problemi (Problem Solvers)
Non è un male se larchitetto si occupa di risolvere problemi anche pratici. O no?
Si ma quello che dico è che non risolvono problemi oggettivi, fenomeni naturali che si trovano indipendenti nel mondo esterno. Sono sempre problemi formulati dagli architetti che ci riguardano direttamente.
Intende dire che larchitetto in un certo modo crea problemi e li risolve. Un demiurgo in qualche maniera.
Larchitetto vorrebbe eliminare alcuni contro-effetti naturali. Gli architetti, come gli storici, possono decidere quali aspetti enfatizzare e quali tralasciare. È interessante paragonare larchitettura a unaltra disciplina: la medicina. La medicina è considerata una scienza, e forse rappresenta la massima espressione della scienza occidentale e si professa come oggettiva. Da esperienze recenti sappiamo che anche la medicina ha i suoi limiti, ad esempio i cosiddetti effetti collaterali dei farmaci. Solo ora vengono messi in discussione questi effetti, ma anche questi fanno parte della storia. E anche questi non possono esserne esclusi.