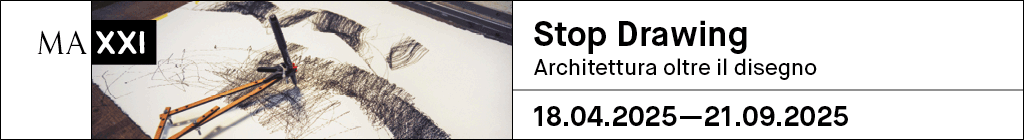La Casa da Musica, progettata dallo studio olandese Oma Rem Koolhaas a Porto (Portogallo) e inaugurata nel 2005, era stata presentata nel n. 33 del settembre 2005 da «Il Giornale dellArchitettura» nellarticolo di Nuño Portas Vendicato Scharoun?
Ripensando al programma definito dalla committenza, il progetto di Oma – Rem Koolhaas per la Casa da Musica di Porto sembrava ben lungi dal soddisfarne le linee direttive (ispirate alla Cité de la Musique di Parigi). Questo nonostante unindiscutibile potenzialità mediatica e una palese differenza con le architetture della scuola di Alvaro Siza, anchessi elementi ritenuti fondamentali per il progetto. Alla sua inaugurazione, in una calda giornata di aprile, il pubblico era rimasto affascinato dalla fantascientifica visione dellabbagliante meteorite sfaccettato, appoggiato su un manto ondulato di travertino biondo come sabbia al sole.
A 5 anni dalla sua inaugurazione – condizioni meteorologiche a parte – lo scenario è variato. Limpressione di volume «solitario» è stata annullata dal nuovo complesso di edifici che fa da scenografia permanente alla visuale verso est. Il cemento armato di rivestimento, progressivamente scurito e macchiato dallo scolo delle acque, non rende giustizia agli sforzi fatti in fase di costruzione per ottenere facciate uniformi e candide. Le vetrate, opacizzate dallaria salmastra, svelano le difficoltà delle operazioni di pulizia ordinaria. Anche il manto di travertino mostra i segni del tempo, sgretolandosi in punti critici (già oggetto di manutenzione straordinaria) e patendo il mancato studio del sistema di smaltimento dellacqua piovana, i cui percorsi abituali si leggono nelle chiazze permanenti sulla pietra o nellaffioramento dei muschi a ridosso delledificio sul lato nord.
Linterno manifesta diversamente il passare degli anni, premiando o castigando le scelte progettuali. I materiali di rivestimento, anche quelli più delicati come il decoro in foglie doro della sala Suggia, hanno dimostrato buona resistenza alluso intenso degli spazi. Elementi architettonici insospettabili e soluzioni tecnologiche teoricamente innovative, invece, tradiscono prestazioni sub-ottimali. La porta di accesso principale, quasi perennemente chiusa, vanifica il ruolo della simbolica scalinata dingresso e modifica la promenade architecturale immaginata. Le vetrate inclinate degli uffici al piano terra sono diventate superfici di appoggio supplementare per ogni sorta di oggetto. Neanche la maestosa vetrata ondulata della sala principale, affacciata sul monumento della vittoria sugli inglesi, è rimasta inviolata esibendo, tra le altre cose, una scarpa da ginnastica a 15 metri di altezza, troppo pesante e ben protetta dalla parte concava della lastra per essere spazzata via solo dal vento.
È innegabile però che dal punto di vista funzionale la Casa da Musica sia un successo, nonostante gli spazi progettati autonomamente dal programma, secondo una logica geometrica di sottrazione di volumi minori irregolari da un volume unico, sembrassero inzialmente incompatibili con le attività da ospitare. A dimostrarlo cè un cartellone concertistico ricco ed eterogeneo, chiaramente lontano dallortodossia elitaria del teatro dopera o dellauditorium tradizionali. Uno spirito egualmente democratico anima i progetti educativi che hanno trovato grande consenso di pubblico.
Per gestire lintrecciarsi delle attività, le gerarchie spaziali delledificio sono state eliminate a favore di un uso pragmatico delle aree che prescinde dalla funzione a loro attribuita inizialmente. In questo modo il workshop di tamburi della domenica pomeriggio è tenuto nel terrazzo panoramico interno affacciato sul foyer: il suono delle percussioni riecheggia in tutta lala sud, accentuando il concetto della «casa» come contenitore di musica in tutte le sue forme. Anche il ristorante in copertura è stato coinvolto nel turbinio delle performance, proponendo cene con concerti jazz dal vivo o aperitivi, tapas e degustazioni pre e post spettacoli. Limpressione è che la committenza avesse chiaro fin da principio che ledificio dovesse essere un insieme di spazi interconnessi, in cui proporre attività musicali e spettacoli diversi anche in contemporanea, nellarco di tutta la giornata e per tutto lanno. In tale ottica, larchitettura intesa come ordinatrice di spazio perde il suo valore primario. Il merito del buon funzionamento della macchina è infatti da trovare nellintraprendenza e adattabilità di utenza e gestione.
Come accaduto in fase di progettazione e costruzione, la partecipazione dei portoghesi si è rivelata decisiva per la qualità del risultato e per risolvere i problemi oltre i quali forma e progettista sembravano non potersi spingere.
Ad ogni modo, Koolhaas ha saputo scatenare il tanto anelato «effetto Bilbao» che, agli occhi dellopinione pubblica, ha riportato il palcoscenico di Porto sotto i riflettori della cultura europea. Al turista contemporaneo, attirato tanto dal tour-degustazione delle cantine di «vinho do Porto» quanto dalla visita alledificio patinato e «griffato» Koolhaas, può capitare di assistere, in una tempestosa serata invernale, a un concerto alla Casa da Musica: il piccolo auditorium immerso nelle note di Beethoven e il quartetto di musicisti illuminato dal fugace bagliore dei fulmini inquadrati dalla grande vetrata alle spalle del palco. Un breve blackout, ma la musica non si ferma.