Articolo pubblicato su “la Repubblica” l’1 aprile 2016. Riproduzione per gentile concessione
Chi domani entrerà al MAXXI a Roma, al London Acquatics Centre, alla stazione della funicolare di Innsbruck guarderà questi edifici strani, improbabili e pieni di fascino con occhi diversi. La morte trasforma opere molto discusse, a volte molto criticate, inizialmente in intoccabili simulacri, per poi spesso precipitarle nell’oblio. Eppure domani l’omaggio migliore a un architetto dalla storia improbabile, lo renderanno i visitatori qualunque che, magari non sapendo neanche della sua morte, visiteranno o, ancor meglio, utilizzeranno quegli edifici. Perché un’architettura esiste e rimane nell’immaginario dei cittadini, se il suo uso è quasi scontato. Certo è ancor più paradossale pensarlo per le opere di Zaha Hadid. Non solo perché ha percorso tutti i passi della strada, non certo lastricata solo di encomi, delle archistar: dall’insegnamento nella scuola europea più venerata, l’Architectural Association, al premio Pritzker. E neanche perché le sue opere segnino, con una volontà di forma quasi esasperata, piccole città come Jesolo o metropoli come Hong Kong.
Oggi il Maxxi, come altre sue opere, sono architetture frequentate e vissute anche, se non soprattutto, come spazi pubblici, come luoghi di incontro, come isole di urbanità in realtà cittadine che stanno perdendo la capacità di sorprendere i propri abitanti con l’incontro inatteso. E questo nonostante la forma che Hadid ha dato a queste, come ad altre architetture, sia fatta per colpire l’attenzione e la fantasia degli utenti. Contraddizione felice, che lo è ancor più per un’architetta che amava utilizzar disegno e pittura per studiare, provare e immaginare le sue opere e poi sperimentava le risorse di un’informatica ormai necessaria e omologante come mai nessuna “tecnica” lo è stata nella storia dell’architettura. Ma quei segni così forti non erano solo il frutto di una modellistica matematica ormai in grado di sfidare le leggi della fisica, spesso con l’aiuto di una scienza dei materiali che ha saputo usare come pochi altri architetti.
Le sue non erano prove muscolari di una nipotina di Nietzsche, nata a Baghdad. Hadid ha portato la sua ricerca formale sempre ai limiti di un gusto che forse non esiste più, ma che condanna chi lo sfida per un gioco puramente intellettuale. Come per altri figli di una generazione e di un contesto ricco di suggestioni – Londra dal 1972, il lavoro con Koolhaas, Zenghelis e Tschumi, OMA e il suo continuo gioco tra la capacità di raccontare la città contemporanea, il saper affascinare clienti e committenti, il rapporto strettissimo con chi quelle opere doveva poi realizzarle –, Hadid ha saputo trovare un suo equilibrio tra esaltazione della tecnica e volontà formale non prestissimo. Un equilibrio davvero difficile perché passare dall’invenzione alla bizzarria, dall’interpretazione di una contemporaneità all’apparenza senza canoni, ma con regole industriali, costruttive, persino linguistiche feroci, era facilissimo. A progettare in questo mondo in cui ballare con l’orso è davvero la prigione che suggerisce Ted Dekker, la ha accompagnata uno dei personaggi più influenti e meno conosciuti dal pubblico, Peter Rice, che già aveva fatto da Pangloss a Renzo Piano e Richard Rogers. Ma, insieme alla capacità di creare spazi che la gente vive, anche quando non sono felicissimi come il Burnham Pavillon a Chicago o la stazione marittima di Salerno, a evitare il più mortale dei rischi che corre la sua generazione e i suoi colleghi archistar – il manierismo di se stessi – la ha aiutata il ricominciare sempre da capo. Hadid non è mai caduta nello specchio di un narcisismo davvero formale e decadente che segna purtroppo lo scenario internazionale e i paesaggi metropolitani contemporanei; oltre che macchiare le brillanti uniformi di tante archistar contemporanee e soprattutto di chi aspira ad appartenere a quel mondo. L’assenza di codici condivisi da scuole o da comunità di architetti, il progressivo disfarsi dei canali che formavano il consenso ma garantivano, anzi costruivano il dissenso, come le riviste di architettura, non la ha portata a far delle sue opere i modelli da imitare: ha rischiato e oggi il rischio intellettuale è merce davvero rara.
Il suo è stato inoltre – e non è inutile ricordarlo – un diritto di cittadinanza conquistato in un universo sociale e professionale che era insieme il più internazionale e il più chiuso. Gli architetti sono davvero animali di un circo segnato da regole spietate e chiuso alle donne: anche se oggi per fortuna è sempre meno così. E forse per questo ancor più dispiace che Hadid ci abbia lasciato: da Pangloss poteva e doveva ormai farlo lei.





















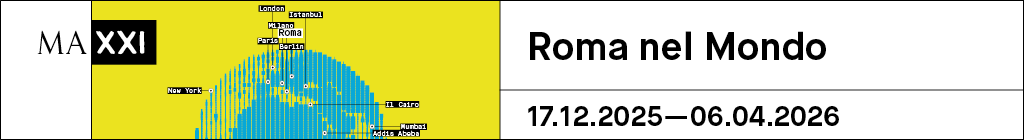










[…] Nel suo commento, Carlo Olmo sostiene che «la morte trasforma opere molto discusse in intoccabili simulacri». Ancor di più, in genere, avviene per le persone una volta trapassate. E allora, eccoci pronti ai distinguo: Zaha sì archistar, ma scevra degli aspetti “degeneri” del sistema. Invece no, lei era una delle anime di quel sistema, considerato sotto ogni aspetto: dal narcisismo formale, all’indifferenza al contesto, all’omologazione dell’immagine, al culto della personalità. Diciamocelo onestamente: anche ascoltando i discorsi privati degli addetti al lavori in questi giorni credo che lei, insieme a Libeskind e Gehry (e ben più dell’intellettualistico Koolhaas, dei tecnologici Piano, Rogers o Foster, dei camaleontici Herzog & de Meuron, del muscoloso Calatrava o dell’eterea Sejima, giusto per citarne alcuni), venisse vista come la punta più esposta di un parafulmine che attirava gli strali di coloro che mal digeriscono l’autoreferenziale sperimentalità di certi approcci (e il sottoscritto non nasconde di rientrare tra quelli, come palesato dalla lettura del Messner Mountain Museum a Plan de Corones). […]
[…] Hadid aveva 65 anni ed era nata a Baghdad, in Iraq, prima di andare a studiare a Beirut e trasferirsi a Londra, dove viveva da molti anni avendo preso la nazionalità britannica. Ma girava molto il mondo seguendo i numerosissimi progetti del suo studio, che l’avevano messa nel gruppo delle “archistar” mondiali già da quasi trent’anni. Tra gli altri, uno dei tre grattacieli della nuova zona Fiera di Milano, quello in costruzione in questi mesi. Hadid era stata la prima donna a vincere il premio Pritzker, il più importante riconoscimento internazionale nel campo dell’architettura, e anche la prima donna a ricevere la medaglia d’oro del Royal Institute of British Architects. Zaha Hadid (1950-2016). La forza di rischiare e saper ricominciare | Giornale dell'Architettura …. […]
[…] pochissimi giorni dalla prematura e improvvisa scomparsa di Zaha Hadid, la conclusione del premio suggerisce alcune […]
[…] Nel suo commento, Carlo Olmo sostiene che «la morte trasforma opere molto discusse in intoccabili simulacri». Ancor di più, in genere, avviene per le persone una volta trapassate. E allora, eccoci pronti ai distinguo: Zaha sì archistar, ma scevra degli aspetti “degeneri” del sistema. Invece no, lei era una delle anime di quel sistema, considerato sotto ogni aspetto: dal narcisismo formale, all’indifferenza al contesto, all’omologazione dell’immagine, al culto della personalità. Diciamocelo onestamente: anche ascoltando i discorsi privati degli addetti al lavori in questi giorni credo che lei, insieme a Libeskind e Gehry (e ben più dell’intellettualistico Koolhaas, dei tecnologici Piano, Rogers o Foster, dei camaleontici Herzog & de Meuron, del muscoloso Calatrava o dell’eterea Sejima, giusto per citarne alcuni), venisse vista come la punta più esposta di un parafulmine che attirava gli strali di coloro che mal digeriscono l’autoreferenziale sperimentalismo di certi approcci (e il sottoscritto non nasconde di rientrare tra quelli, come palesato dalla lettura del Messner Mountain Museum a Plan de Corones). […]
[…] Zaha Hadid (1950-2016). La forza di rischiare e saper ricominciare (di Carlo Olmo) […]
[…] Zaha Hadid (1950-2016). La forza di rischiare e saper ricominciare (di Carlo Olmo) […]