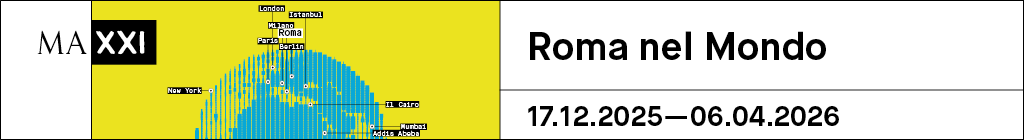La ricezione dell’Expo milanese appare, a chi voglia soffermarsi un solo momento, quasi un paradigma del modo con cui oggi si vive il tempo. Non sembri una riflessione troppo astratta. È sufficiente interrogarsi sul perché nessuno degli attori di una scena che è sempre stata tale dal 1851, dalla prima Esposizione universale a Londra, neanche si ponga la domanda, se la parte che recita in commedia, non sia già stata scritta. Freud ricordava che la ripetizione è la madre di tutte le patologie. E il teatrino dei pupi cui stiamo assistendo, nasce dallincapacità di vivere un tempo che non sia sincronico, senza storia. Non starò ripetendo osservazioni, ricorrendo a retoriche, usando immagini che erano già logorate nella lunga storia delle esposizioni universali alla fine dellOttocento, consumate sulla pista del gran ballo Excelsior che a Parigi festeggia linizio del nuovo secolo? Qualche dubbio legittimo potrebbe, forse dovrebbe nascere.
Levento come strumento per rilanciare uneconomia e per ridisegnare una città, sono due retoriche che accompagnano le Esposizioni universali almeno da quella di Philadelphia del 1876. E che siano retoriche lo si sapeva già, almeno dallEsposizione parigina del 1878, dove Viollet-le-Duc allestisce la prima mostra sul restauro delle proprie opere, ben sapendo, lo testimonia la sua corrispondenza, che lesposizione contava come medium, ben più dello stesso contenuto del suo messaggio. O a Chigago nel 1893 lEsposizione fu pensata anche per contrapporre a una narrazione, non solo letteraria, che voleva la città americana essere black, unEsposizione come white city, radicalizzando la funzione retorica, rispetto anche alla rilevante trasformazione urbanistica che lEsposizione produsse. O ancora a Bruxelles, nel 1958, lEsposizione riuscì a trasformare un’ormai banalità della fisica, nel simbolo stesso dellExpo: lAtomium. Così lEsposizione universale come un caravanserraglio, litania oggi ripetuta da tanti, è già limmagine che ci restituiscono due personaggi non minori, come John Ruskin e Gottfried Semper proprio dopo aver visitato lEsposizione londinese del 1851.
E vale per tanti récit che ci sentiamo ripetere oggi.
Laccusa di etnocentrismo, diventata poi di colonialismo e imperialismo, si ritrova già nei commenti più salaci alle rue du Caire che dal 1878 popolano la scena delle Esposizioni. O ancora, sono gli impressionisti, esclusi dalla stessa Esposizione, che accusano chi le organizza di escludere le ricerche più innovative, toccando uno dei cuori retorici delle esposizioni: la messa in scena dellinnovazione. Così come lEsposizione venduta quale occasione di orgoglio nazionale, strumento e occasione di lanciare e rilanciare unidentità nazionale in crisi o discussa, ha nellEsposizione parigina del 1937 e nei due famosi padiglioni dellURSS e degli Stati Uniti che si fronteggiavano quasi unicona. Ma le Esposizioni universali sono anche la fossa di tanti luoghi comuni o di tante semplificazioni critiche.
Chi le affronta, come oggi accade ai laudator o detrattori, che guardano allExpo come il luogo dove trovare le ricerche architettoniche o tecnologiche più sofisticate, non si avvede che quando ci si opera, come accade allo stesso Gustave Eiffel, si usa linnovazione per meravigliare: e forse la più grande meraviglia fu la luce elettrica e i suoi giochi, sin dallEsposizione di Philadelphia… Daltronde il Crystal Palace volutamente presentava la macchina industriale che tutti potevano comprare, non lultima inventata. La sola eccezione fu il più grande cannone che la Krupp dovette portare due volte, perché il primo giace sui fondali della Manica. O le tante Galeries des machines stupirono prima con la fotografia, poi con i diorama, infine con i primi filmati: con la memoria trasformata in ricordo che si poteva recare con sé, cambiando il rapporto tra il tempo della visita e il tempo e i modi della successiva narrazione.
Ci si potrebbe oggi porre tanti interrogativi, a iniziare dalla possibilità di creare meraviglia o di favorire la serendipity, lincontro casuale, o d’immaginare che i grandi congressi di bioingegneri o elettromeccanici di oggi si possano tenere durante l’Expo: e se questo avrebbe lo stesso significato in una società in overdose d’informazione. Le Esposizioni universali sono state e sono in primo luogo ed essenzialmente avvenimenti sociali; sono una produzione, più o meno riuscita, di una scena, con attori, trame, scenografie predefiniti.
Daltronde lo stesso principio del padiglione (e forse non solo) chiamato oggi a rappresentare unidea di nazione che non esiste più, se non per il permanere di una forma organizzativa che nasce proprio con laffermarsi del nazionalismo, appare un residuo di un passato che è sempre stato più presente del futuro nelle Esposizioni universali. E sarebbe strano non fosse così anche nellepoca dellheritage e dei luoghi della memoria ormai dilaganti; e sarebbe strano che tutto ciò non accadesse a Milano.
Come – e lo dico purtroppo ci sarebbe da stupirsi se chi parla, prima di avventurarsi in retoriche che si vogliono persuasive si documentasse, per sapere almeno se queste non sono state usate magari più di un secolo fa. O se, per parlare nello specifico dellExpo, prima la si visitasse e non ci vuole certo uno sguardo distratto – e poi si esprimessero consensi o critiche. Ma la cultura sincronica e del tweet o dell’sms richiede che si anticipi il giudizio e si condivida lemozione, non che si offra una meditazione critica. Questo invece cercheremo di fare offendo meditazioni dopo aver rivolto più di uno sguardo alle architetture, ai contenuti e alle ambizioni che sempre unEsposizione universale reca con sé. Con modestia e ironia. Uno dei documenti più belli che unEsposizione ci abbia lasciato è il diario, falsamente anonimo, di un visitatore giornaliero allEsposizione di Parigi del 1900: schizzi e commenti ironici, non sarcastici, perché sin dalla più straordinaria Esposizione universale, quella parigina del 1867, il non prendersi troppo sul serio ha accompagnato chi godeva di ricostruzioni dei paesi esotici, che sapeva animati contemporaneamente da Jules Verne e dalla scuola archeologica di Atene o di Roma.
Con un senso del tempo storico e del ruolo dellimmaginazione ben distinti; percezione che oggi appartiene davvero a pochi.
Il caravanserraglio?