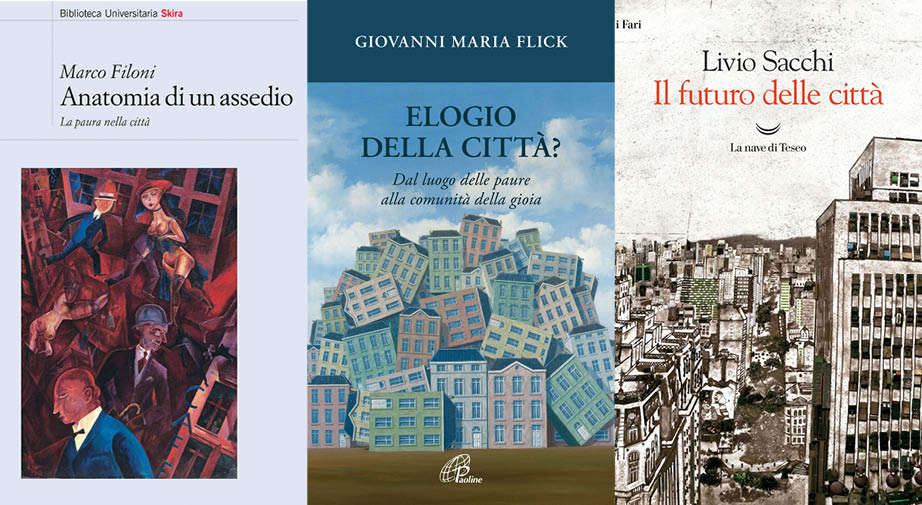Convergendo da prospettive disciplinari differenti, tre libri indagano la fenomenologia e il futuro delle città
Sui temi urbani c’è una retorica dominante che sfiora anche la pubblicistica. Le città contemporanee sono così sempre di più al centro di un dibattito in cui il contributo specifico della cultura architettonica sembra sfumare. In questo senso, tra slogan e mantra, è perfino arduo individuare un percorso bibliografico coerente. Nel 2019 però tre libri italiani – diversi per prospettive, obiettivi e provenienze dell’autore, ma simili per scelte editoriali: testi senza immagini, copertine grafiche – tratteggiano uno scenario complesso che restituisce i caratteri identitari, e anche paradossali, della città. Propongono parole-chiave alternative, e anche sorprendenti: per Livio Sacchi città significa soprattutto libertà, per Giovanni Maria Flick accoglienza, per Marco Filoni paura. Offrono non banali né scontati sconfinamenti nell’attualità sociale e politica. Trasmettono, soprattutto ad una lettura comparata, la sensazione di una complessità di questioni aperte che Marco Filoni, nell’introduzione al suo Anatomia di un assedio, descrive così: «La città è diventata una matassa indistinta e confusa di paure. Una sorta di fantasma che insegue l’uomo nella sua tana. E qui lo assedia, dentro e fuori».
La prospettiva più ortodossa, almeno da un punto di vista disciplinare, è quella di Livio Sacchi, architetto romano e docente a Pescara. Il suo libro è l’ultimo arrivato, pubblicato da La Nave di Teseo con un titolo impegnativo, Il futuro delle città. È un corposo volume diviso in venti capitoli e due parti molto riconoscibili. Nella seconda Sacchi accumula, divise per continenti e per stati, dettagliate descrizioni, anche personali, di città: una sorta di guida all’urbanità mondiale. Invece, nelle prime 200 pagine, tematicamente più pregnanti, vengono proposti i fenomeni (dalle migrazioni alla sostenibilità, dalla digitalizzazione ai rinnovati rapporti tra centri e periferie) che impattano sulla città contemporanea. Chiavi di lettura e riferimenti sono tra i più vari: dalla sociologia alla normativa, da Papa Francesco alla deontologia professionale. Lo sguardo è ottimistico: «Le città, insomma, non vanno più viste come un problema in sé, ma piuttosto come una possibile soluzione, forse la soluzione ai problemi dell’umanità». Una posizione che regge anche di fronte alla fase nuova «in cui il controllo è andato perduto – forse per sempre – lasciando il posto al dinamismo di trasformazioni sempre più veloci, sperimentali, destabilizzanti e mutevoli». Sicuramente ricco è il risultato della pubblicazione da cui, però, si legge poco la specificità disciplinare. La domanda che sorge spontanea è se serva un architetto per parlare e per scrivere di città. O, forse, addirittura, se serva un architetto per costruire la città di oggi. Dubbio ancora più forte leggendo le conclusioni, con tre presupposti alla base del futuro urbano: oltre al disegno, il senso civico e lo spirito etico.
Ovvero concetti simili a quelli proposti negli altri due libri – ugualmente molto recenti, pubblicati a cavallo dell’estate scorsa – che invece escono dagli ambienti universitari per affrontare la questione da un punto di vista prevalentemente socio-politico. Gli autori non sono architetti: Marco Filoni (libro Skira) è filosofo, giornalista, autore televisivo. Giovanni Maria Flick (che pubblica per Paoline) è ex ministro della Giustizia, ex presidente della Corte costituzionale, professore di diritto penale. Entrambi inseriscono nel titolo – oltre alla scontata parola città – anche la paura. Quasi a sottolinearne il ruolo di fattore decisivo: «Ma la città è ambigua. Non è soltanto il luogo dell’armonia e del riparo. È anche il luogo della paura. E per quanto si vogliano elaborare riflessioni in grado di consolarci, di esorcizzare questa paura e perciò scacciarla il più lontano possibile, ce la ritroviamo sempre a gravare su di noi», scrive Filoni nel capitolo introduttivo dei quattordici nei quali si articola una lettura colta ma al contempo agevole e piacevole.
Molto attuale, quasi cronachistico, è anche il punto di vista di Flick, che pone tre avvenimenti recenti come punto di partenza di un ragionamento ugualmente profondo ma adeguato a diversi tipi di lettura (che si dipana in diciannove capitoli): il crollo del ponte Morandi, l’incendio di Notre-Dame e la morte di un migrante clandestino in un campo profughi di Foggia. Le posizioni del libro sono continuamente tese tra la Carta costituzionale da una parte e la Bibbia dall’altra: temi storici e mitici sfociano nell’idea di città come “bene comune”. Una dimensione – sembra dire Flick, con chiari riferimenti all’attualità italiana – messa in discussione dall’abbinamento «Fra immigrazione e sicurezza, reso in modo plateale dalla saldatura fra i due termini, [che] esprime una concezione di paura, di rifiuto della diversità, di ricerca di sicurezza attraverso l’innalzamento delle mura e delle barriere della città. Una concezione che è antitetica alla Costituzione italiana». La seconda parte, una sorta di pars costruens, immagina al contrario «una città futura che rimanga vivibile non solo per chi già vive in essa ma anche per chi in essa arriva». L’obiettivo, viene suggerito, è «Una prospettiva di città ispirata alla crescita, all’apertura e non alla chiusura in se stessa – nelle sue mura e nel suo benessere – [in cui] il tema delle migrazioni, della diversità e della paura va ricondotto alle radici dell’Europa: un dialogo e un confronto fra la cultura laica e quella religiosa; tra le strade dei campanili e quelle delle abbazie, delle università e dei diritti; tra queste ultime e le strade dei mercati e delle fiere».
Pur con riferimenti diversi (ben ancorati nella cultura architettonica, anche attraverso la suggestione di alcuni archetipi: il muro, il locus sacer, la soglia) anche Filoni sembra tracciare un percorso analogo a quello suggerito da Flick rispetto alla condizione attuale della città: «La paura ha attraversato tutta la nostra storia: paura dell’altro, della malattia, della carestia, del nemico, dell’infedele, del vicino, del lontano. Paura di se stessi […] Il problema è che oggi questa paura, nonostante viviamo nell’epoca più sicura di tutte quelle che ci hanno preceduto nel corso della storia, ha colonizzato le nostre vite». La conclusione è meno ottimisticamente propositiva, o meglio sembra suggerire una sorta di accettazione della paura come fattore connaturato alla stessa dimensione urbana, anche – e soprattutto – nella realtà contemporanea che viviamo: «Perché la città, sia essa immaginaria, antica o moderna, o megalopoli, ha nella paura, nel conflitto, nella stasis e nei modi di affrontare – con l’oblio o la memoria – questi aspetti fondamentali e anche fondanti, un dispositivo del suo funzionamento e della sua realizzazione. La città è sempre un luogo di paura. E questa paura è sempre, inevitabilmente, tanto dentro quanto fuori. Anzi, oggi la città non è più il luogo dove si ha meno paura rispetto a fuori: la città non ha più mura e non ha più limiti, è fascino e terrore insieme, eppure è il luogo dell’uomo».
Un luogo, si può concludere, che pare oggi indeciso se farsi progettare oppure se, alla faccia degli architetti, preferisce costruirsi autonomamente. Facendosi raccontare con parole che si allontanano dalla disciplina stessa dell’architettura.
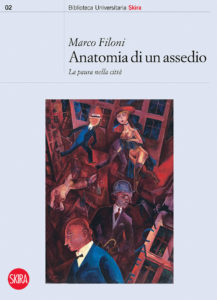 Anatomia di un assedio. La paura nella città, di Marco Filoni, Skira, 2019, pp. 104, euro 18
Anatomia di un assedio. La paura nella città, di Marco Filoni, Skira, 2019, pp. 104, euro 18
—
—
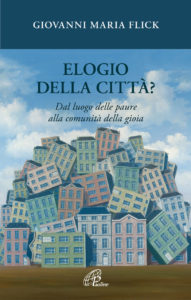 Elogio della città? Dal luogo delle paure alla comunità della gioia, di Giovanni Maria Flick, Paoline, 2019, pp. 128, euro 14
Elogio della città? Dal luogo delle paure alla comunità della gioia, di Giovanni Maria Flick, Paoline, 2019, pp. 128, euro 14
—
—
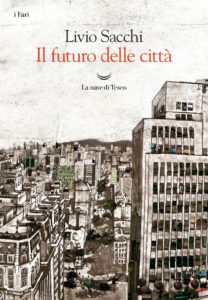 Il futuro delle città, di Livio Sacchi, La nave di Teseo, 2019, pp. 544, euro 30
Il futuro delle città, di Livio Sacchi, La nave di Teseo, 2019, pp. 544, euro 30
—