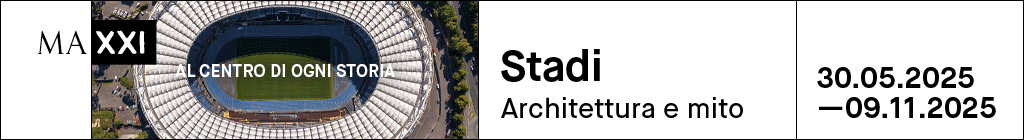Gli italiani sono ancora involontariamente dipendenti – nella cultura storico-artistica e del restauro – dallanglofobia e dallavversione per la cultura degli Stati Uniti dominanti ai tempi del Regime, e di conseguenza criminalizzano tuttora nel campo del restauro ogni riproduzione à lidentique, ignorando linfluenza internazionale della scuola filologica e iconologica europea salvatasi in America dalle persecuzioni razziali, nonché della scuola archeologica americana di Atene, responsabile del destino dei restauri dellAcropoli a iniziare dal ripristino della Stoà di Attalo nel 1953. Cesare Brandi aveva così condannato loperazione: «Questa idea non poteva venire che da un altro mondo, non dalla Grecia e, per quanti strazi archeologici ci si siano fatti noi italiani, neanche dallItalia. Il contrasto, fra quelledificio che starebbe al suo posto solo vicino al Campidoglio di Washington […] è tale da far desiderare che si ricoprano di terra quegli avanzi incomparabili, per sottrarli alloffesa di un sfacciata e aggressiva presenza» (in Viaggio in Grecia, 1954).
Una ricostruzione esplicitamente rivendicata dagli americani fino al terzo meeting internazionale per il restauro dei monumenti dellAcropoli (1989), che vide anche una vistosa contrapposizione tra Roberto Di Stefano, il quale dichiarava in francese che la ricostruzione dellAcropoli «era possibile
ma non necessaria» e il sottoscritto, che invece lodava i lavori della Stoà e quelli allora e ancor oggi in corso sullAcropoli.
La mentalità anglofoba e americanofoba influenzò anche la Carta del Restauro di Venezia del 1964, in quanto ligia allappena pubblicata Teoria del restauro di Brandi, la quale svelava la mentalità mercantile sulle copie e riproduzioni (denominate tout court falsificazioni) degli storici dellarte italiani, attribuzionisti e certificatori dellautenticità al servizio del mercato antiquario piuttosto che dediti alla filologia e alliconologia delle opere.
Oggi, in un mondo che assiste alla globalizzazione della cultura tecnologica e alla migrazione dinteri popoli, le architetture e i centri urbani vanno considerati icone permanenti, tangibili, utilizzate e utilizzabili, delle culture locali: la loro funzione didattica è massima e il loro restauro, inteso nel modo più completo del termine – ovvero la loro più efficace duplicazione in caso di necessità, eseguita beninteso nel modo più colto e raffinato – è divenuto un obbligo di civiltà.
Nelle città europee colpite dalla seconda Guerra mondiale quali Budapest, Dresda, Innsbruck, Salisburgo, Varsavia, Vienna, Vilnius, si è potuto e anzi si è dovuto dopo il 1949 ripristinare gli edifici più prestigiosi e più cari agli abitanti, con opere grandiose e ben documentate, ignorate tuttavia dai «conservazionisti» nostrani. Tali ripristini hanno avuto il significato simbolico di «riparazione allaggressione sadica subita» (Mélanie Klein); in quanto tali, essi hanno un significato assai simile a quello dei ripristini nelle zone terremotate. Infatti i terremoti sono affini alla guerra nellimmaginario collettivo, e richiedono anchessi un cerimoniale di rimozione che esprima la volontà di restituire allarchitettura una realtà corporea senza la quale resterebbe un fantasma cartaceo consegnato alle fotografie o ai disegni. I ripristini dunque non meritano laccusa di falsificazione, ma attenzione: le strutture materiali degli edifici crollati potrebbero essere state mal eseguite, tanto da non resistere a ulteriori sismi, se rifatte «comerano, doverano».
Nel caso dellAquila occorrerà dunque esaminare bene la pristina consistenza materiale degli edifici prima di replicarli «comerano, doverano», visto che essi crollarono specie se furono ricostruiti con mezzi poveri dopo il terremoto del 1703, e tali mezzi consistevano spesso – per le costruzioni borghesi – in pietre piccole o ciottoli tufacei di fiume, legati con fango vegetale anziché argilloso, piuttosto che con la calce mescolata alla pozzolana. Una legatura col fango che regge solo laddove sia presente pietra calcarea ma anche un fango di fiume argilloso come a Roma, solo così consentendo che si costruissero fino alla metà del Settecento edifici di grande rappresentatività come la facciata di San Giovani dei Fiorentini o la chiesa della Trinità degli spagnoli in via Condotti.
Non solo: occorrerà tornare ad altezze non superiori a due o tre piani fuori terra, nel caso delle case borghesi, consentendo solo alle case patrizie unaltezza di poco superiore (massimo cinque/sei piani), e si vedano i tipi di case e palazzi italiani tradizionali. E ciò per lovvio motivo che la maggiore altezza provoca maggiori oscillazioni e dunque maggiori danni alle murature. Occorrerà tornare a impiegare buona pietra cementata con calce e pozzolana, e buon legname per solai e tetti, oppure consolidare, rinforzandole, le chiese o i palazzi patrizi che non fossero ancora crollati, ricorrendo a pietra ben tagliata commessa con malta di calce e pozzolana e a strutture orizzontali in legno ben selezionato e congiunto.
Va detto infatti che la cupola della chiesa delle Anime sante a LAquila è crollata proprio a causa di alcune ricuciture effettuate nel 2006, le quali hanno iniettato cemento liquido nei muri e hanno «rinforzato» la cupola del Valadier con una cappa di acciaio e cemento la quale non solo non ha impedito il crollo, ma probabilmente lo ha causato. E dunque sarebbe bastato, nel corso dei recenti restauri, sostituire le tre cerchiature di legno che contenevano la cupola del 1805, le quali si sono slegate a causa della povertà con la quale furono realizzate, come si vede benissimo dalle foto post sisma. E anche a causa del fatto che i progettisti e direttori degli ultimi lavori le avevano bellamente ignorate, sicuri comerano delle proprie abitudini tecniche, imperniare sulluso esclusivo delle ricuciture e delle cappe in cemento armato. Anche in tal caso, dunque, dietro al terremoto dellAquila vi è da sospettare della competenza e dellonestà delle imprese costruttrici ottocentesche che non legarono tra loro efficientemente le cerchiature progettate dal Valadier, nonché delle tecnologie di «ultima generazione», predilette dagli architetti sedicenti «moderni», e cioè privi di preparazione nel campo delle tecniche tradizionali.
Ecco dunque che cosa dovrebbero sapere gli addetti alla ricostruzione dellAquila: leggere e interpretare correttamente i linguaggi dellarchitettura dei secoli passati. Sarebbe necessario dunque esercitarsi bene nella filologia: quella scienza umana «relativa alla ricostruzione e alla corretta interpretazione dei documenti di un ambiente culturale definito», i cui progressi, dal Settecento in poi, hanno fornito ad archeologi e architetti i metodi dinterpretazione e ricostruzione delle rovine antiche, come ad Atene. Senza di ciò, essi non sarebbero in grado di progettare il recupero della bellezza di una città come LAquila, in quanto non saprebbero leggere, interpretare ed eventualmente ricostruire per parti la sua architettura. Come non saprebbe leggere e tanto meno correggere e implementare (emendare) un testo lacero scritto in latino antico o medievale chi conoscesse solo la «scrittura creativa» dellitaliano odierno.
Articoli recenti
- Tragico crollo nella Torre dei Conti: no a scelte frettolose 8 Novembre 2025
- Jean Prouvé double face: tra valorizzazione e conservazione 5 Novembre 2025
- Un grande, raffinato, magazzino per rivoluzionare l’agricoltura 5 Novembre 2025
- La migliore architettura: politicamente corretta, poche sorprese e archistar 5 Novembre 2025
- Vitra Campus, Balkrishna Doshi celebra il silenzio 5 Novembre 2025
- Il porto di Marsiglia ha il suo nuovo, vecchio, faro 4 Novembre 2025
- Impermeabilizzazione del terrazzo: Icobit Italia il tuo alleato 4 Novembre 2025
- Il Museo più grande, simboli e nazionalismo: l’Egitto si celebra 3 Novembre 2025
- Forma e relazioni in mostra alla Sapienza 3 Novembre 2025
- Ritratti di città. Hanoi, topografie del cambiamento 29 Ottobre 2025
- Smart vs Green: una sola intelligenza non basta 29 Ottobre 2025
- Dolci attese: forme che misurano il tempo 28 Ottobre 2025
- Agenda Urbana: a Brescia un laboratorio condiviso per la sostenibilità 28 Ottobre 2025
- Alice Rawsthorn: il mio design, un’attitudine più che una professione 28 Ottobre 2025
Tag
Edizione mensile cartacea: 2002-2014. Edizione digitale: dal 2015.
Iscrizione al Tribunale di Torino n. 10213 del 24/09/2020 - ISSN 2284-1369
Fondatore: Carlo Olmo. Direttore: Michele Roda. Redazione: Cristiana Chiorino, Luigi Bartolomei, Ilaria La Corte, Milena Farina, Laura Milan, Arianna Panarella, Maria Paola Repellino, Veronica Rodenigo, Cecilia Rosa, Ubaldo Spina. Editore Delegato per The Architectural Post: Luca Gibello.
«Il Giornale dell’Architettura» è un marchio registrato e concesso in licenza da Società Editrice Allemandi a r.l. all’associazione culturale The Architectural Post; ilgiornaledellarchitettura.com è un Domain Name registrato e concesso in licenza da Società Editrice Allemandi a r.l. a The Architectural Post, editore della testata digitale, derivata e di proprietà di «Il Giornale dell’Architettura» fondato nell’anno 2002 dalla casa editrice Umberto Allemandi & C. S.p.A., oggi Società Editrice Allemandi a r.l.
L’archivio storico
CLICCA QUI ed effettua l’accesso per sfogliare tutti i nostri vecchi numeri in PDF.
© 2025 TheArchitecturalPost - Privacy - Informativa Cookies - Developed by Studioata