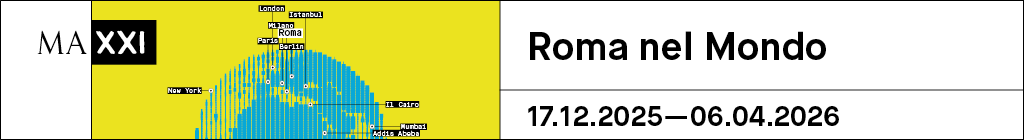La tregua non garantisce un futuro per la Palestina. La riflessione di Sandi Hilal e Alessandro Petti (Daar) sui cicli di costruzione, distruzione e ricostruzione
Il genocidio in corso nella Striscia di Gaza viene spesso trattato come un evento isolato, privo del contesto coloniale, di occupazione e di apartheid israeliana che lo sostiene e che, se non smantellato, continuerà a sopravvivere a qualsiasi temporaneo cessate il fuoco. Ciò che rimane sistematicamente invisibile è il quadro politico e territoriale che rende possibile questa violenza e la dimensione architettonico-politica attraverso cui essa si materializza. Senza questa lettura, il ciclo di costruzione, distruzione e ricostruzione continuerà all’infinito.
Un muro che isola
Capire il contesto significa per esempio ricordare che il 70% degli abitanti della Striscia di Gaza proviene da villaggi situati a pochi chilometri oltre il muro che Israele ha costruito intorno ad essa. Questo muro fortificato, che non ha fornito alcuna sicurezza agli israeliani, non è un confine, ma una barriera per contenere e controllare una popolazione tenuta in cattività. Lo Stato di Israele mantiene il controllo su ogni aspetto della vita a Gaza: dalle forniture idriche ai registri delle nascite e dei decessi. Il muro isola un territorio che per secoli è stato parte di un continuum urbano e sociale che va dal Cairo, passando per Haifa a Beirut.
La stessa formula della Striscia di Gaza è una costruzione coloniale recente, il nome assegnato allo spazio in cui Israele ha confinato i palestinesi espulsi dalle loro case nel 1948. Parlare di Gaza senza riconoscere questa genealogia significa ignorare la continuità storica della violenza coloniale e quindi precludere qualunque possibilità di una pace duratura. Dal 1948 la Palestina vive in un ciclo continuo di distruzione e ricostruzione. In molti casi, gli effetti della ricostruzione sono stati più devastanti della distruzione stessa. Basti pensare agli insediamenti israeliani costruiti sulle rovine dei villaggi palestinesi spopolati: una vera e propria distruzione della distruzione. Allo stesso tempo, la distruzione ha spesso generato nuove forme di solidarietà e modi differenti di costruire collettività. Ogni progetto di ricostruzione ridefinisce i rapporti di potere e impone nuovi assetti spaziali, sociali e mentali.
Cicli di violenza senza fine
È in questa intersezione tra distruzione e ricostruzione, sfollamento e ritorno, collaborazione e resistenza, informalità e istituzione, che nel 2016 abbiamo lavorato, insieme allo Studioazue, al piano di ricostruzione del quartiere Al Nada, su incarico dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e in collaborazione con il Ministero dei Lavori Pubblici a Gaza. Il progetto mirava a riabilitare centinaia di unità abitative danneggiate, costruirne di nuove e rigenerare gli spazi e le infrastrutture comuni, attraverso un processo guidato dalle comunità di Al Nada e Al Isba, dalle famiglie e dalle istituzioni locali.
Inaugurato nell’agosto 2019 è stato completamente demolito dall’invasione israeliana nel novembre 2023. I suoi abitanti sono scappati in altre aree della Striscia e molti di loro sono stati uccisi durante l’invasione. Durante il processo di progettazione, gli abitanti hanno chiesto se fosse possibile garantire che le nuove case non sarebbero state nuovamente demolite. Una garanzia impossibile se non esiste un vero cambiamento politico.
Cosa significa dunque ricostruire in un territorio sottoposto a blocco e costantemente minacciato da una nuova guerra? È in questo contesto, che i progetti di ricostruzione oggi immaginati rischiano di essere, paradossalmente, ancora più distruttivi della distruzione stessa. A Gaza la ricostruzione non interrompe il ciclo della violenza, ma ne costituisce una fase interna. Ogni ricostruzione normalizza l’ultimo atto di demolizione e tenta di cementificare una realtà di espropriazione e ingiustizia imposta su una intera popolazione. Le guerre diventano così parte di una economia politica che dipende dalla continua produzione di rovine.
Se oggi vogliamo riflettere seriamente su ciò che significa ricostruire Gaza, il primo passo è riconoscere il valore delle rovine. Non soltanto come testimonianza, ma come luogo di presenza dei corpi e delle memorie palestinesi. Le rovine non sono rifiuti, ma materiali politici che resistono alla cancellazione e che esigono giustizia. Il loro valore è incompatibile con i modelli di ricostruzione rapida e astratta che presuppongono neutralità, accelerazione e tabula rasa.
Serve un orizzonte politico decoloniale
Ricostruire Gaza significa quindi affidare alle comunità palestinesi il compito di dare forma al proprio ambiente. Per decenni, in assenza di piani ufficiali, esse hanno ricostruito nonostante la distruzione, sviluppando forme di auto-organizzazione attente alla stratificazione delle rovine e al loro significato affettivo, sociale e politico. Questo sapere, prodotto dal basso, è l’unica base credibile per un processo di ricostruzione che non riproduca la logica che intende superare.
Tuttavia, nessun progetto architettonico può eludere la dimensione politica. Una ricostruzione a lungo termine è possibile solo all’interno di una soluzione che riconosca ai palestinesi il diritto al ritorno nei propri villaggi e il diritto all’autodeterminazione, come sancito da numerose risoluzioni delle Nazioni Unite. Se questi diritti vengono negati, allora viene meno la stessa legittimità degli stati nazionali moderni, che fondano la propria esistenza sul principio del ritorno, dell’autodeterminazione e della continuità territoriale. Senza il ritorno dei palestinesi espulsi nel 1948 dai villaggi che Israele ha distrutto e sostituito con insediamenti israeliani e campi agricoli, la Palestina rimane una eccezione programmata e permanente.
Pensare davvero alla ricostruzione significa dunque assumere un compito duplice: ricostruire la Striscia di Gaza a partire dal valore delle sue rovine, affinché chi ha commesso questi crimini risponda delle proprie azioni; e aprire allo stesso tempo un orizzonte politico decoloniale con la fine del regime di occupazione, colonizzazione e apartheid e in cui la ricostruzione diventi parte di una trasformazione più ampia che includa il diritto al ritorno dei profughi palestinesi, non solo quelli della Striscia, nei loro villaggi di origine.
Senza questo orizzonte, capace di contenere una visione coerente di giustizia, che comprenda i diritti di tutti i suoi abitanti, ogni progetto di ricostruzione rimane incompiuto e vulnerabile alla prossima ondata di violenza. In questo contesto l’architettura non è una soluzione tecnocratica, ma la possibilità di immaginare un’organizzazione socio-spaziale in cui le persone non siano più imprigionate in stati-nazione e in regimi di separazione che perpetuano la violenza.
Immagine copertina: Daar, Al Nada Social Housing (2014-2020)