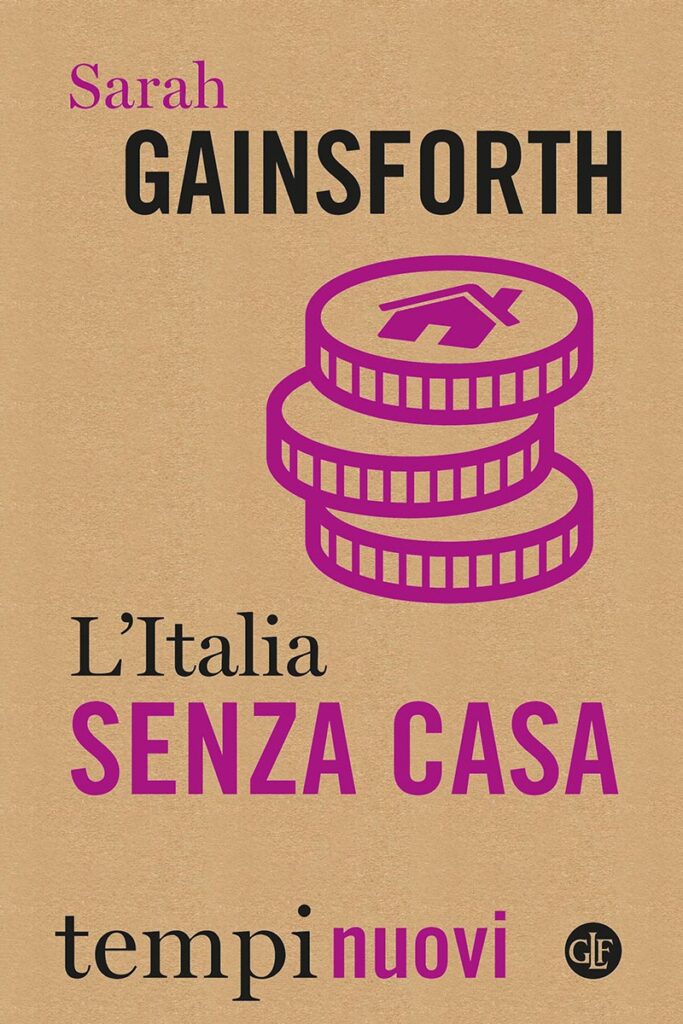Un libro di Sarah Gainsforth offre una riflessione urgente e necessaria sulla carenza di alloggi a prezzi accessibili. Un’emergenza sociale che approfondisce le disuguaglianze. Ne pubblichiamo un estratto
La casa è un’emergenza. In Italia, come in buona parte dell’Occidente, lo sviluppo urbano e le spinte speculative degli ultimi decenni hanno prodotto una condizione per cui in molte zone centrali delle città soluzioni abitative a prezzi sostenibili sono diventate una chimera. Gli effetti sono gravi, sia dal punto di vista fisico-spaziale che da quello sociale, mettendo a rischio la coesione e aggravando le disuguaglianze. Il Giornale dell’Architettura ha affrontato il tema con un’inchiesta nei mesi scorsi. Ma è opportuno e necessario tornarci. Da una parte perché la questione condiziona e caratterizza le riflessioni sia progettuali che teoriche (tra queste merita una nota la partecipazione nazionale della Repubblica Ceca alla Triennale di Milano attualmente in corso che allestisce uno spazio (immagine in copertina) con un titolo emblematico: “The momentum of a decision”). Dall’altra perché, pur tra mille retoriche, la politica, ai massimi livelli, sembra essersi accorta dell’emergenza e la affronta con proposte di iniziative. Così cogliamo l’occasione della stampa di un libro di Sara Gainsforth (“L’Italia senza casa” pubblicato da Laterza nella collana Tempi Nuovi, 2025, 240 pagine, 19 €). Diviso in 14 capitolo offre un taglio non disciplinare e che, proprio per questo, riesce ad allacciare i fili di un tema che rappresenta una delle sfide principali del futuro delle nostre città. E delle comunità che le abitano. Ringraziamo l’autrice e l’editore che ci hanno concesso di pubblicare un estratto dal testo di apertura della pubblicazione.
La fine di un ciclo. “La casa e il lavoro, la sanità, la scuola, la giustizia, i diritti: questo paese sta distruggendo tutto ciò che serve alle persone normali per vivere”. Elena ha 59 anni e lavora all’ospedale di Bergamo. “Mi sono diplomata a vent’anni come infermiera, era il 25 giugno. Pochi giorni dopo, il 15 luglio, ho iniziato a lavorare. Sono stata tra gli ultimi ad accedere a un concorso per un posto a tempo indeterminato”. Il primo stipendio di Elena è stato di un milione e duecentocinquantamila lire. “Mio marito faceva l’operaio in una piccola azienda metalmeccanica e guadagnava poco meno di me. Quando ho iniziato a lavorare eravamo fidanzati e abbiamo deciso di sposarci. Avevamo i soldi per cominciare una vita insieme, per mettere su una famiglia”.
Elena è nata nel centro storico, a Bergamo Alta, dove abitavano famiglie nobili che possedevano le terre, grandi industriali nel settore dei filati, e la gente comune come la sua famiglia. “La via principale era piena di negozietti. Papà faceva il tappezziere, ce n’era un altro poco distante, c’erano il macellaio e altri negozi per gli abitanti”. Quando Elena ha deciso di sposarsi, il padre ha iniziato a spargere la voce, chiedendo se qualcuno avesse un appartamentino in affitto. “Dei signori vicino a noi lo avevano, l’affitto era basso, era un quinto del mio stipendio mensile, e ci siamo trasferiti”. Era il 1985. Poco dopo è nata Chiara. Oggi Chiara è rientrata da poco dall’estero ed è alla ricerca di una casa in affitto a Bergamo. Ma di case in affitto a prezzi accessibili non se ne trovano più, né lì né in moltissime altre città in Italia.
Oggi Elena abita in un quartiere che descrive come “vicino alle case Fanfani”, ovvero le case popolari costruite in tutta Italia tra il 1949 e il 1963 con il Piano Ina-Casa ideato dal ministro del Lavoro Amintore Fanfani, esponente della Democrazia cristiana. “Erano abitazioni costruite per le persone meno abbienti, per la gente che lavorava e che non poteva permettersi di comprare o affittare una casa prestigiosa”, racconta Elena. “Un tempo questo paese pensava alle persone che non avevano un’abitazione. Essere poveri non era una colpa”. La voce gentile di Elena ha assunto un tono indignato. “Oggi ti devi sentire in colpa se non puoi spendere duemila euro per studiare a Milano o mille euro al mese per lavorare a Bergamo. Ti fanno sentire in colpa”. Il tono di Elena è passato dall’indignazione alla rabbia.
Nel corso degli ultimi quarant’anni, ha assistito al deterioramento delle condizioni abitative e lavorative delle nuove generazioni, allo smantellamento delle politiche che avevano garantito a lei e alla sua generazione condizioni di vita dignitose. Molti dei suoi colleghi più giovani, i medici e gli infermieri che per primi sono stati travolti dalla diffusione della pandemia da Covid-19 a febbraio 2020, sono costretti a dormire in ospedale. “Le case, quando si trovano, sono troppo distanti dall’ospedale e siccome se si è di guardia bisogna essere lì entro venti minuti, restano a dormire su dei lettini adiacenti alla sala operatoria”, spiega Elena. Quando lei iniziò a lavorare, i medici abitavano nelle case costruite per loro accanto al vecchio ospedale. “Molti dei vecchi medici sono ancora lì”. Dentro l’ospedale c’erano gli alloggi per il personale che doveva essere reperibile. “Si pagava qualcosa, ma era una cifra ridicola. C’erano anche posti per chi non poteva rientrare a casa perché finiva tardi il turno, magari alle quattro del mattino dopo diciotto ore di sala operatoria. Anche la scuola per infermieri aveva i suoi alloggi per le infermiere reperibili. Potevano farsi una doccia e dormire in un letto decente. Questa era Bergamo”.
I grandi palazzi nobiliari del centro non erano ancora stati restaurati e vi abitavano famiglie di ceto medio-basso. “Nel palazzo dove sono nata io c’erano dei signori con ancora il bagno sul balcone, all’esterno della casa, come una volta. Era un quartiere popolare, vissuto”, racconta Elena. Ai piedi della città antica, a Bergamo Bassa, c’erano i bagni pubblici che servivano anche i negozi, costruiti nel secondo dopoguerra, chiamati ‘il Diurno’. “Ci andavo con mia madre quando andavamo a fare compere, passavamo sempre di lì, si pagavano 20 lire. C’erano anche le docce, perché molte persone non avevano la doccia in casa”.
C’era ancora, in quegli anni, un’attenzione per le esigenze di tutta la popolazione, anche quella più povera, un’attenzione per l’igiene pubblica. Elena, un’infermiera, conosce bene l’importanza dell’igiene pubblica e non ha nulla a che fare con il concetto di ‘decoro urbano’, un concetto meramente estetico. Oggi la povertà è tornata a essere oggetto di provvedimenti securitari mirati ad allontanare i poveri dallo spazio urbano, quello pubblico, che non svolge più alcuna funzione sociale ma serve al consumo.
La dimensione privatistica dell’abitare ha preso il sopravvento, come se la città fosse solo un aggregato di case e di edifici. “Nel giro di trent’anni Bergamo Alta è diventata come Venezia, una specie di ghetto turistico in mano agli Airbnb. Non c’è più quel tessuto sociale fatto dalle persone che conoscevo. Sono andate via tutte”, racconta Elena.