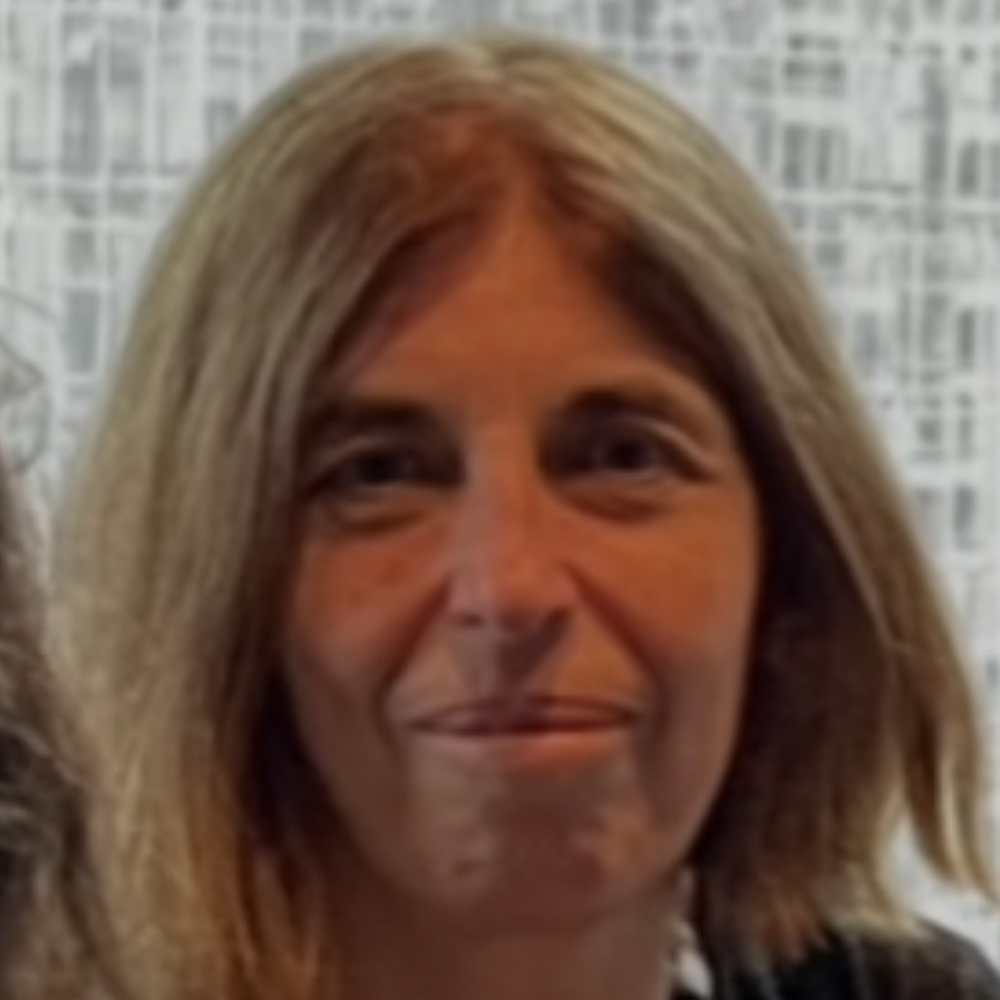Una sessione specifica dell’appuntamento romano viene dedicata ai temi decisivi della vicinanza e della relazione tra persone e luoghi
Si è svolta a metà settembre, all’ex Mattatoio di Roma, l’VIII edizione della Biennale dello Spazio Pubblico. Evento ricco e partecipato che permette di riflettere su progetto e caratteri dei luoghi collettivi nelle città contemporanee, sotto il titolo “insieme/together/juntos”. Il Giornale dell’Architettura, media partner, ha già dedicato alcuni articoli di avvicinamento all’iniziativa. Offriamo qui commenti e punti di vista da parte di docenti e critici che hanno coordinato alcune sessioni: vogliono essere un bilancio dei temi discussi e soprattutto un’apertura alle questioni più significative che lo spazio pubblico contemporaneo genera.
La sessione Insieme per la prossimità – coordinata da Anna Laura Palazzo dell’Università di Roma Tre e Marichela Sepe della Sapienza Università di Roma, con discussant Elena Andreoni dell’Associazione Biennale Spazio Pubblico – ha presentato numerosi contributi teorici e casi studio.
Negli spazi di soglia
Le esperienze illustrate – da Milano a Volos (Grecia), dalla Sardegna a Trieste, da Torino a Terracina – mostrano che la prossimità è sia infrastruttura fisica che scelta politica e pratica quotidiana. È un dispositivo che attiva e rende visibili energie spesso silenti, e quando diventa criterio progettuale, trasforma spazi marginali in luoghi-ponte tra comunità, servizi, natura e istituzioni.
A Ponte Lambro, quartiere di Milano circondato da infrastrutture e campi, la prossimità emerge nei vuoti e nelle soglie. Le Jane’s Walk, i percorsi di ascolto con il Laboratorio di Quartiere e le ricerche sugli spazi aperti evidenziano temi di accessibilità, sicurezza e uso condiviso. Qui la prossimità non è solo dotazione: sebbene presenti istituzioni rilevanti e spazi riqualificati, la qualità dell’abitare dipende dalla densità di relazioni che i luoghi riescono a generare e dalla loro capacità di connettersi alla scala territoriale. È un lavoro lento di co-programmazione, che richiede alle amministrazioni di consolidare legami e alle comunità di riconoscersi come co-autrici.
Gli spazi di soglia accomunano anche due casi sardi: l’esterno del Museo Aligi Sassu a Thiesi, che da margine diventa piazza permeabile con accesso inclusivo, e il social housing di Olbia, dove porticati, passaggi e giardini diventano luoghi di cura e micro-comunità intergenerazionali. In entrambe le situazioni, prossimità significa qualità microclimatica, materiali sostenibili e governance condivisa, realizzando l’Obiettivo 11.7 dell’Agenda 2030 e trasformando l’esterno in infrastruttura sociale.
Educazione e sguardi plurali
Quando la scuola è pensata come bene comune, la prossimità si allena nei “non-formal spaces of education”. Il programma Erasmus+ a Volos (Grecia) ha esplorato cortili, tetti, strade e parchi come rete didattica diffusa, mescolando apprendimento e città. Qui il dispositivo non è l’aula, ma il percorso: uno spazio aperto dove accessibilità, gioco, inclusione e partecipazione diventano parte del curriculum quotidiano. Anche l’esperienza italiana Post-: ridisegnare gli esterni delle scuole – migliorando flussi veicolari, aumentando permeabilità del suolo, attrezzando verde e ombra – libera spazi dedicati alla salute e alla relazione, promuovendo la didattica all’aperto e migliorando la vivibilità delle periferie senza consumo di suolo.
La prossimità è anche ibrida: si costruisce tra mappe digitali e pratiche fisiche. La piattaforma open source FirstLife, applicata all’urbanistica di genere e alla mappatura partecipata “Verso un crowdmapping femminile”, mostra come le tecnologie civiche possano fare emergere bisogni e desideri, trasformandoli in basi informative per decisioni pubbliche. La partecipazione non è consultazione, ma attiva competenze diffuse e costruisce legami tra persone, luoghi e istituzioni. La prossimità ibrida è quindi metodo e garanzia di eguaglianza sostanziale.
A Milano, Tunnel Boulevard rivela una nuova grammatica: rigenerare passaggi infrastrutturali come gallerie d’arte pubblica e spazi per lo skate, valorizzando i writer e le loro opere come pre-esistenze culturali. Il patto di collaborazione crea un tessuto civico, unendo parrocchie, associazioni e gruppi informali. La prossimità qui è diritto all’espressione e alla co-gestione di spazi stigmatizzati, legittimando culture giovanili come antidoto al degrado.
La domanda “cosa rende attrattivo uno spazio pubblico?” si concentra sulla pluralità dei corpi e degli sguardi. Comfort, pulizia e verde non bastano se non c’è sicurezza; la sicurezza, inoltre, è vissuta diversamente da una donna, un bambino, un anziano o una persona con disabilità. La prossimità, dunque, non è universale ma situata: conciliare diritto alla sosta e contrasto al bivacco, socialità e diritto alla solitudine, richiede dispositivi flessibili e processi inclusivi di co-progettazione.
Temporaneità e affordability
La temporaneità, da Otranto e Bari a Matera, funge da laboratorio di prossimità: dispositivi effimeri attivano ascolto, testano usi e anticipano trasformazioni. Analogamente, “ParticipatiOn Wheels” – struttura mobile che può essere riconfigurata come carrello, banco o stand – crea uno spazio intermedio per workshop, mappature e co-design in piazze e scuole. Qui, il tempo breve non è un ripiego ma un acceleratore: permette di sperimentare, lavorare su trials and errors in piccolo e consolidare alleanze prima di cristallizzarle in opere definitive.
La prospettiva “percorrenza e sosta” offre una matrice analitica potente: dall’utenza e dalle sue motivazioni, all’orditura urbana (servizi, commercio di prossimità, fermate TPL, sicurezza, ombra, acqua, sedute, bagni), fino alla percezione e agli scambi sociali. Reti pedonali continue e leggibili, micro-attrezzature e comfort climatico sono imprescindibili per una connessione funzionale e relazionale. Anche l’abitare affrontabile sollecita una lettura complessa della prossimità. A Trieste, l’integrazione tra case in affitto e servizi di supporto all’autonomia in una “periferia interna” ricca di risorse sociali, come l’ITIS, dimostra come l’affordability non sia solo 30% del reddito ma un ecosistema di prossimità socio-sanitaria e spaziale.
A Roma, il progetto “IV MigliOra” propone un parco lineare lungo l’antico tracciato dell’Almone, che connette quartieri, siti archeologici e mobilità lenta, usando il Contratto di Fiume come strumento di governance. I Contratti di Fiume ricordano che la prossimità è anche istituzionale: amministrazione condivisa, sussidiarietà orizzontale e tavoli nazionali per lo scambio di metodologie.
Il Giardino Pellegrino a Torino è un esempio di prossimità come pratica politica quotidiana: dall’auto-attivazione degli abitanti alla messa in sicurezza tramite crowdfunding, fino al Patto di Collaborazione che legittima una governance comunitaria oggi sostenuta da volontari e reti culturali. Infine, Terracina applica il Manifesto della città del buon abitare e usa il PNRR per uno schema di spazi pubblici a Borgo Pio, mostrando come la prossimità possa diventare struttura di piano. Una città policentrica di maglie e nodi, in cui mobilità lenta, memoria materiale e usi contemporanei convergono in interventi replicabili, coerenti con l’SDG 11.
Cinque lezioni
Cinque lezioni trasversali emergono da questi racconti:
- la prossimità è una politica di infrastrutture leggere (ombre, sedute, rampe, verde) che abilitano relazioni;
- è una questione di governance: patti, laboratori, piattaforme digitali, contratti di fiume spostano il baricentro dalla decisione sull’opera al processo condiviso;
- è tempo e cura, non evento; si misura nella manutenzione sociale e nelle eque occasioni d’uso;
- è differenza, non standard; progetta per corpi plurali, età e fragilità, e assume sicurezza e accessibilità come diritti;
- è ibridazione di scala e media, dal cartello temporaneo alla piazza rifatta, dal crowdmapping al laboratorio mobile.
La prossimità, in definitiva, significa rendere il vicino più ricco di mondo: moltiplicare connessioni, ridurre diseguaglianze spaziali, affidare alla città pubblica il compito di educare, includere e curare. È così che lo spazio smette di essere solo contenitore e diventa generatore di possibilità.
Immagine di copertina: Worcester Street Community Garden, Boston, USA