La trasformazione dei terreni è un fattore spesso ignorato da piani e progetti. Un approfondimento che tocca le nuove normative europee
Per amor di franchezza, imbastiamo questo articolo partendo da un’affermazione forte: il suolo non è considerato nei progetti architettonici e urbanistici.
L’urgenza delle urgenze
Perché? Un po’ perché non si sa cos’è, un po’ perché ci siamo abituati a declinare la sostenibilità nel campo del visibile. Visibili sono gli alberi, i fiori, le foreste urbane. Invisibile invece è il suolo che, così, finisce per non aver voce in capitolo.
L’abitudine non solo ci ha solo indotto a dimenticarci del suolo, ma addirittura a considerarlo qualcosa di sempre disponibile e capace di sopportare inquinamenti e degradi. Invece è vero il contrario: il suolo è fragile e non è per nulla rinnovabile: 10 centimetri si formano in 2000 anni. Diviene quindi urgente aggiornare il nostro sguardo su cosa davvero è il suolo e traghettarlo nel modo di fare architettura e urbanistica.
Iniziamo con la definizione più corretta circolante: il suolo è, secondo la definizione del 2024 dell’Unione Europea, il “complesso dinamico di comunità di piante, animali, funghi e microrganismi e del loro ambiente non vivente che interagiscono formando un’unità funzionale; comprende tipi di habitat, habitat di specie e popolazioni di specie”.
Un modo completo per dire che il suolo è un ecosistema, e non altro. Invece noi, nelle leggi e nei piani, parliamo di uso o di destinazione d’uso del suolo. Si è trattato di un perverso processo di normalizzazione al ribasso attraverso il quale il suolo è stato definito in base a ciò che ne vorremo fare e non in base a ciò che è. Da questa inversione dobbiamo uscire. L’urgenza delle urgenze, allora, è rimettere ordine ai significati e far sì che siano i piani e i progetti a curvarsi sulla complessità ecologica del suolo e non viceversa. Questo significa formazione ecologica per le cariche politiche e i tecnici locali.
Fragile e indispensabile alla vita
Primo: il suolo è un ecosistema fragile.
Secondo: non è una superficie, ma uno spessore vivo e sottilissimo di cui i primi 30 centimetri circa sono i più delicati e cruciali (una polvere vitale di appena lo 0,0015% della biosfera).
Terzo: il suolo non è una fabbrica di cose utili agli umani, né un mero fornitore di pezzi di ricambio al bosco, al prato, ai terreni agricoli.
Quarto: il suolo è il custode vivo e insostituibile delle relazioni tra le infinite parti della natura. Più o meno tutte le componenti della natura hanno radici e relazioni con il suolo.
Quinto: semplicemente il suolo è sede di svariate funzioni ecosistemiche. Sequestra carbonio (assieme alle piante) agendo da potentissimo regolatore climatico. Assorbe le acque piovane (cosa che quasi si azzera con l’urbanizzazione) trattenendo fino a 4 milioni di litri per ettaro nei suoli più sani e coperti da vegetazione permanente come prati. È un motore ineguagliabile per i cicli biochimici di molti nutrienti vitali come azoto fosforo potassio. Produce oltre il 95% del cibo e il 99% delle calorie che assumiamo. Nei primi 30 centimetri troviamo il 30% della biodiversità del pianeta (oceani esclusi).
Ma tutto questo è stupidamente a rischio perché si continua a consumare suolo senza limiti: gli indicatori nazionali parlano chiaro: circa 2,3 metri quadrati al secondo di suolo, pari a 20 ettari al giorno, tra il 2022 e il 2023 sono consumati, ovvero altri 7.254 ettari persi in un solo anno. In un’immagine una pianificazione urbanistica insostenibile, vorace e non adeguata al tempo presente e futuro.
Un regolamento europeo che dà speranza
Una flebile luce brilla nel buio del consumo di suolo. Riguarda l’attuazione del regolamento europeo sul ripristino della natura (n. 2024/1991), entrato in vigore nel luglio del 2024. È la cosiddetta Nature Restoration Law (NRL), attualmente il dispositivo normativo più potente e già operante e al quale affidare sia la tutela del paesaggio e dell’ambiente sia il vero e proprio ripristino di estese parti degradate del territorio. Ma, della NRL non si parla. Nella NRL il suolo è finalmente “parte integrante degli ecosistemi terrestri” (punto 23 delle Premesse) e quindi ecosistema esso stesso, come è corretto che sia.
Non essendoci una direttiva europea a tutela del suolo, l’occasione del regolamento sul ripristino della natura deve considerarsi imperdibile e avviare un nuovo indirizzo pianificatorio e progettuale. Da fare in fretta, visto che entro il 2030 almeno il 30% della superficie totale di tutti i tipi di habitat elencati dalla stessa NRL deve essere riportata in buono stato. Il 60% entro il 2040. Il 90% entro il 2050 (articolo 4). Un vero e proprio sconvolgimento culturale per urbanisti e politici che, però, è anche la più grande occasione ecologica che abbiamo sul tavolo. Tocca a noi.
![]()
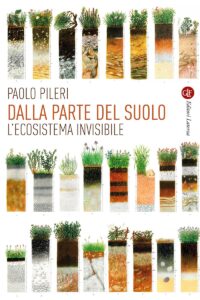 Paolo Pileri, “Dalla parte del suolo. L’ecosistema invisibile”, Laterza, 2024
Paolo Pileri, “Dalla parte del suolo. L’ecosistema invisibile”, Laterza, 2024






















