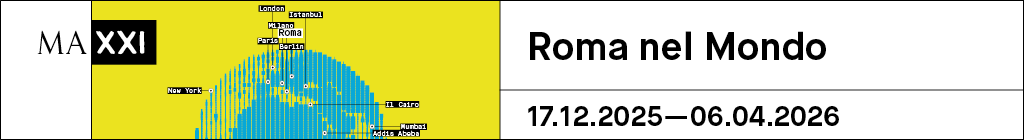Ospiti di Triennale Milano, un incontro con Massimo Alvisi, fondatore con Junko Kirimoto dello studio romano che festeggia i 20 anni di attività
MILANO. Accolti da Nina Bassoli, curatrice di Triennale per Architettura, rigenerazione urbana, città, a fine febbraio Massimo Alvisi e Junko Kirimoto hanno dialogato ripercorrendo vent’anni di carriera, attraverso numerosi progetti realizzati dallo studio internazionale: dal Teatro dell’Accademia di Belle Arti a Napoli, a Piazza Faber a Tempio di Pausania (Olbia), passando per alcuni allestimenti progettati per le opere di Emilio Vedova, la Cantina Podernuovo realizzata in Val d’Orcia per Bulgari, l’Accademia della Musica di Camerino o edifici residenziali e di social housing come quello in Viale Giulini a Barletta. Attraverso il loro racconto, ad emergere non è stato uno stile sempre coerente con se stesso, quanto un approccio, una metodologia fondata da un lato su un rapporto attento e fortemente consapevole con il contesto, sia esso urbano, rurale o naturalistico, e dall’altro sullo studio minuzioso di dettagli tecnici e soluzioni realizzative sperimentali. Nell’occasione abbiamo incontrato Massimo Alvisi.
Architetto Alvisi, avete messo cura e attenzione nel raccontarvi attraverso i progetti che abbiamo visto questa sera e che ritornano nel volume pubblicato nella ricorrenza del ventennale di fondazione del vostro studio (Alvisi Kirimoto, edizioni The Plan, 2023, pp. 256, euro 29).
Non è mai facile raccontarsi, anche perché abbiamo deciso d’includere tanti progetti, e la verità è che non ne abbiamo molti di più. Saranno in tutto una ventina quelli realizzati: in vent’anni non è una media cattiva per uno studio italiano. E poi – questa è la cosa importante – non ci sono progetti di cui ci vergogniamo, quelli che a volte si tralasciano. Ci sono progetti di cui non siamo del tutto soddisfatti, ma anche di quelli ci resta il valore della sperimentazione.
Partendo da questo racconto, traspare molto della vostra metodologia. Si nota una dimensione di ricerca che è sempre strettamente in contatto con l’esistente, nell’incontro con un luogo e con chi lo abita. Non c’è uno schema predefinito, piuttosto è interessante osservare la sistematizzazione operata attraverso le pagine del libro, l’instaurazione di un dialogo con il paesaggio e con le tracce che vi emergono. Qui siete voi, tramite il progetto, a definire che cosa resta e che cosa cambia. Quello che avete raccontato è l’esito di questa rilettura, che prevede una posizione critica, che preserva, opera in prossimità o per contrasto. Come nasce questo dialogo per voi?
Questo è un tema importante. Noi partiamo, anche in un progetto come la cantina per Bulgari, in cui siamo andati alla ricerca del luogo, da alcune tracce che per noi sono importanti e che, in quel caso, ci eravamo immaginati e mentalmente ricostruiti prima ancora di trovarle nel paesaggio. Abbiamo così cercato un luogo a cui poterle ricondurre e dove stabilire il progetto. Questo perché, anche quando apparentemente non ve ne sono, l’importante è avere dei limiti. Il limite è il modo migliore per poter pensare: un limite fisico, un limite mentale, un limite di qualsiasi natura ti permette di evolvere, anche di essere più libero, magari anche in contrasto con il luogo. Trovare e integrare dei punti a cui il progetto di salda, su cui ci sentiamo di combattere, ci offre una libertà. Questa libertà, se non c’è, proviamo a darcela.
Quasi a darvi una misura…
Una misura, sì. Infatti, uno dei punti fermi del nostro modo di progettare è proprio la misura. Avendo lavorato, e lavorando tuttora, con il gruppo G124, ci si trova a chiedersi perché la periferia sia brutta… Premesso che per me non lo è, la risposta è che lo appare perché è difficile misurarla. Non si riesce a trovare un’unità di misura che permetta di rapportarsi con il luogo in cui si vive. Quando lavoriamo a un progetto, noi cerchiamo sempre di trovare ciò che rende in grado di misurare non tanto lo spazio, ma la qualità di un luogo, rispetto alla propria dimensione. E poi c’è un altro punto: io vengo dalla periferia, sono di Barletta, ma non vengo dal suo centro storico. Io sono nato nella città degli anni settanta, brutta, incoerente, priva di qualità. Quindi mi sono trovato alla ricerca di misura, di riferimenti. La stessa cosa vale per Junko (Kirimoto, ndr). Lei è nata nella periferia di Tokyo. Anche per lei la dimensione di ricerca si è applicata presto a quella di un riferimento. Il riferimento è importante anche rispetto alla necessità che, da progettista, si ha di mettere, collocare qualcosa nel luogo che ti trovi a plasmare e scoprire.
Queste parole si legano bene ad un’altra questione, che mette in contatto la portata del progetto con le comunità con cui s’interfaccia, intese in senso esteso, umano e non. In questa logica di coesistenza tra contesto, clienti, comunità di persone e altre comunità viventi, sono emersi contatti importanti, che magari non erano attesi? Come si configura per voi questo rapporto attivo con gli ecosistemi, umani e non, urbani e non?
In effetti, le comunità sono tante. Se parliamo di comunità come dell’insieme di persone che vivono un luogo, per esempio una piazza, o anche semplicemente un condominio come nel caso di Barletta, la comunità (che si occupa anche degli spazi verdi che abbiamo progettato) ci ha dato l’idea che dovessimo progettare qualcosa di semplice, ma riconoscibile. Questo perché, e sicuramente vale anche altrove, soprattutto in periferia in Puglia si tende sempre a dare un nomignolo, magari in dialetto, ai luoghi che ricordiamo. Quindi quel palazzo di Barletta è il “palazzo storto” – non lo dico in pugliese – e ciò significa che la comunità lo riconosce per il suo angolo, con quel taglio, conferendo al luogo un’importanza che è alla base di ciò su cui l’architetto lavora.
Poi ci sono le altre comunità, come quella vegetale. Il progetto di Cantina Podernuovo nasce già con il desiderio di proiettare le ombre della vegetazione circostante sull’edificio, in maniera che il disegno dell’edificio sia una proiezione della comunità degli alberi, che il disegno stesso sia natura. Anche nel caso di Camerino, un progetto che s’incastra nel paesaggio con un segno così forte, era fondamentale che riuscisse il suo inserimento rispetto alla semplicità dei pendii circostanti.
Lì si ritrova senz’altro un che d’inaspettato, ad esempio nel rapporto con i pochi edifici circostanti appartenenti alla storia locale. In quello scatto, dove si vede la piccola chiesa in sasso stagliarsi contro il volume della scuola di musica, si coglie qualcosa di quel sistema di tracce, risonanze e intenzioni che ci ha raccontato.
Sì, e di inaspettato.
Immagine di copertina: © Ilaria Magliocchetti Lombi