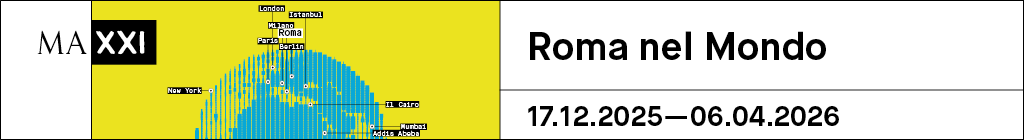Praticare il genio di andare a zonzo porta agli occhi la complessità urbana e la capacità dell’architettura di riappropriarsi di valori, tempo, spazio e usi
È difficile già camminare in città, figuriamoci poi praticare il genio di andare a zonzo che la lettura di David Thoreau così bene ci restituisce. Eppure senza quel genio, proprio la complessità della metropoli che tanto affascina la società contemporanea da Georg Simmel in poi, si riduce a immagini che ci guardano e che noi non sappiamo più indagare: passeggiamo per riconoscere, non per farci interrogare.
Torino è una città che può essere percorsa per semplificazioni: la città barocca e il suo “centro di comando”, la ville industrielle e i suoi vuoti da colmare, la città di un’innovazione felice e rassicurante. Ma basta saper andare a zonzo per scoprire che quelle icone nascondono più che svelare, rassicurano più che chiederci quali siano i fili e le tracce che le architetture intrecciano.
Dal PAV al Mauto
Intraprendere un percorso ha sempre un suo inizio e una sua ragione d’essere. L’inizio per quello che vi propongo è il PAV (Parco arte vivente, 2008), che Piero Gilardi – artista tra i più noti – con la cura di Luca Cosmacini ha promosso in un “resto” urbano: 23.000 mq una volta industriali tra ferrovia e cavalcavia, con vista sul Lingotto. L’arte contemporanea e Torino hanno luoghi più celebri: dalla GAM alla Fondazione Re Rebaudengo, dalla Fondazione Merz alla recente sede della Lavazza. Ma nessun luogo come questo intreccia l’arte contemporanea – non come installazione, ormai consumata dalla sua stessa fortuna – e un sito in cui si possa riscoprire una condizione oggi quasi perduta: la relazione tra scienza, ricerca, contemplazione, educazione, natura antropizzata. Per tornare a Ernst Gombrich, ovvero all’arte come educazione. Il PAV è un luogo che quasi inquieta, e che non scioglie gli interrogativi su quale sia la società torinese che oggi si sta lacerando.
Analogamente avviene, una volta che si è percorso un cavalcavia e si è fiancheggiato l’ospedale delle Molinette – che solo l’odierna mancanza d’ironia può chiamare “città della salute” -, per il rinnovato Museo dell’Automobile (2011). Cino Zucchi offre qui, in uno dei siti più scenografici di Torino, un esempio intrigante di un rammendo architettonico. Ad essere diversamente intrecciati sono insieme funzione del museo – da collezione di feticci a luogo in cui ci s’interroga su come il Novecento ha interpretato la velocità – e i suoi spazi: dove una corte ricuce l’avancorpo che diventa sede di formazione e lo spazio di un museo (forse incompiuto, ma che sarebbe stato straordinario) sulla mobilità.
Storia, cemento e industria
Andare a zonzo è tutt’altro che un esercizio che si può compiere distrattamente e, quando i segni si condensano, lo diventa ancor meno. Poche centinaia di metri oltre, procedendo verso il centro, s’intrecciano tre segni e tre tempi.
Nascosto in una strada che sbocca su una delle ferite non rimarginate della storia recente di Torino, la demolizione della prima fabbrica FIAT di Torino, quella di corso Dante (e la sua assai discussa e contrastata sostituzione), ha sede l’Archivio Storico della FIAT, reinterpretato da Roberto Gabetti e Aimaro Isola (1999). Scrigno non solo di perle ma anche di dolori, popolato di personaggi che la città ha dimenticato come l’ingegner Dante Giacosa, progettista della Topolino e della Seicento, o dei tanti operai e impiegati che qui raccontano la loro vita nelle schede che l’Ufficio personale pazientemente e non sempre pacificamente ha compilato nel tempo.
Poco più in là, tornando su corso Massimo d’Azeglio, quasi si toccano due generazioni di… cemento armato. Quella straordinaria del ferrocemento del padiglione B di Torino Esposizioni di Pier Luigi Nervi (1948) e quella brutalista e sofisticata del residence Du Parc di Corrado Levi e Laura Petrazzini (1971). I tempi della città non sono quelli delle sue tecniche, ma neanche delle sue funzioni. Non solo il padiglione è ancora oggi senza sicura destinazione, ma anche il residence vive una vita quasi da opera d’arte, legata con un filo rosso strano al destino del suo progettista.
Ma quest’intreccio tra architetture che sopravvivono, salvaguardia e riuso accompagna tutto il nostro procedere a zonzo. Proseguendo lungo corso Massimo d’Azeglio s’intravede, sull’asse di corso Marconi, l’ottavo piano del numero 10: forse il piano, il palazzo e il luogo più visitato in processione nell’Italia tra 1950 e 1990, quando l’avvocato Agnelli appariva una sibilla cumana. Oggi l’architettura di un altro dei protagonisti segreti della Torino industriale, Vittorio Bonadé Bottino, è tristemente riusata come uffici e appartamenti, un po’ tetri della loro reminiscenza. Non sempre riuso e rigenerazione convivono felicemente…
A cavallo del Po, palazzo Gualino e casa dell’Obelisco
Appena si svolta in corso Vittorio Emanuele ci si para dinnanzi l’esempio forse più intrigante di questo slittamento di significati che le architetture possono portarsi dietro: palazzo Gualino. Oggi rinominato Palazzo del Novecento, la testimonianza di una stagione architettonica, quella di Giuseppe Pagano e Gino Levi Montalcini (1930), ma anche di una figura essenziale d’industriale mecenate come Riccardo Gualino, promotore di un’innovazione sociale non solo tecnologica, l’edificio è oggi salvaguardato come simulacro e reinterpretato come residenza da uno degli studi più colti di Torino, Baietto Battiato Bianco. Ma che cosa significa enfatizzare la testimonianza come valore artistico e fare di un’architettura un’evocazione? Tutta la storia degli ultimi vent’anni di Torino ci parla di un patrimonio come produzione sociale, il cui senso può variare al mutare della società e dei suoi valori.
Ma basta superare il ponte sul Po per trovarsi davanti un altro indizio non univoco. L’ironica, beffarda e spaesante casa dell’Obelisco di Sergio Jaretti ed Elio Luzi (1959). Non a caso set di film di Dario Argento, la casa ci racconta di come le élite architettoniche torinesi, emarginate dalla costruzione intensiva della città, abbiano restituito alla borghesia che quella crescita promuoveva una figura architettonica che richiama lo sberleffo.
Verso il centro
Di quell’élite e del suo atteggiamento ironico, critico e sofisticato, l’esempio più famoso rimane la Bottega d’Erasmo (Gabetti e Isola, 1956), che tuttavia suggerisce una riflessione spaesante anche rispetto al luogo quasi intimorente in cui è collocata. Soprattutto, l’edificio racconta non solo la sua raffinata costruzione, quanto la ricezione che nel secondo Novecento riveste di un significato diverso le architetture e le fa diventare icone – in questo caso di una fuoriuscita dalla tradizione dell’International Style – forse al di là delle intenzioni dei suoi progettisti.
Poco distante dalla Bottega incontriamo reliquie viventi di quella società industriale e borghese, con le forme della sua socialità: la prima sede dell’EIAR, ancor oggi in funzione, ma già museo della Radio, poi il teatro di Torino, ancora promosso da Gualino, oggi in restauro, il teatro Gobetti e l’auditorium RAI, il cui interno rimane una delle opere più intriganti di Carlo Mollino, con Aldo Morbelli (1952).
Procedendo verso piazza Castello, s’incontra quel teatro Regio la cui storia, dopo l’incendio del 1936, è quasi una sintassi della società torinese e del suo difficile rapporto con gli architetti che dovevano costruirne i luoghi della socialità, e di cui Mollino è assieme il lieber meister e il paradosso (1972). In realtà, meglio di tante altre istituzioni, per entrare nelle architetture della città e dei suoi più colti protagonisti la musica prima dell’arte contemporanea è una chiave essenziale (in piazza Castello ha sede anche quell’Unione musicale che dagli anni quaranta racconta le storie di quella borghesia colta), ma lo è anche l’ironia.
Procedendo, dopo avere attraversato un sottoportico in cui aveva sede il primo museo del Cinema e in cui ancora s’incontra l’ombra di Maria Adriana Priolo, si accede al luogo forse più ricco di contraddizioni: piazza del Duomo.
Il Duomo e il Palazzaccio
Il Duomo di Torino è forse una delle più belle storie di un’architettura che nasconde: nasconde sotto il piano di calpestio un museo Diocesano, che a sua volta nasconde le tracce delle basiliche dell’alto medioevo, delle case e del cimitero di Augusta Taurinorum. Ma il Duomo è anche sormontato dalla cappella guariniana della Sindone, i cui giganteschi pilastri si possono ammirare sotto il museo diocesano. Il più che ventennale cantiere dopo l’incendio del 1997 racconta come anche un restauro autoriale sia un gioco di conflitti tra valori, attori, immaginari.
Davanti al Duomo, a chiudere una piazza in precedenza barocca, l’opera di uno tra i più colti architetti torinesi, Mario Passanti, che ospita oggi l’Assessorato ai Lavori pubblici: nella vulgata “il palazzaccio” (1961). In quella parte di città così aulica, un’architettura austera, povera, simbolo di un’altra Torino, quella della ricostruzione del secondo dopoguerra, dei suoi sfollati, poveri, emigranti, di un popolo che per Passanti doveva trovare alloggio e visibilità lì in centro.
Oltre la Dora
A poche centinaia di metri, oltre il fiume Dora, si apre una storia molto più recente. Nomi che hanno costruito luoghi e immaginari della prima e seconda industrializzazione (Incet, Ceat, GFT, Lanificio di Torino, Lanificio Collegno, Grandi Motori, Ferriere) sono sostituiti da altri: Casa Aurora, Cineporto, Nuvola Lavazza, Basicnet. Tutte architetture che interrogano su cambiamenti che vedono sostituire i materiali della prima industrializzazione (cotone e lana) e della seconda (ferro e plastica), e i progettisti di quella stagione come Pietro Fenoglio o Giacomo Matté Trucco, con architetture smart e sostenibili (almeno queste sono le retoriche che le accompagnano), con parchi quasi di archeologia industriale e con Aldo Rossi, Cino Zucchi, Baietto Battiato Bianco.
Luoghi che nell’immaginario della Torino operaia assumevano valori mitici – come la cattedrale della Fiat Grandi Motori – vedono apparire la produzione cinematografica, il design e l’arte contemporanea, ma vedono anche apparire nuovi luoghi nascosti: dal teatrino di casa Aurora (1987) a via Pisa, non solo pedonalizzata ma interamente e in maniera un po’ inquietante connessa; dai laboratori più raffinati della prototipazione alle tracce forse più antiche della presenza cristiana a Torino, sotto la nuova sede della Lavazza (2017).
Più che un cambiamento, una sostituzione, una serie d’indizi sulla difficilissima “transumanza” dalla città industriale e dai suoi vuoti alla società dell’informazione (e forse della conoscenza), dalla città dei mestieri che trasformano la materia alla città delle professioni che lavorano su prototipi, virtualità, comunicazione.
Tra devozione, solidarietà e beni comuni
Andare a zonzo per Torino mette allora in evidenza due delicati passaggi. Da un lato, un’architettura che davvero rischia di rifletterci immagini che ci guardano e che, se non sappiamo interrogare, saranno nel migliore dei casi scenografie della vita quotidiana. Dall’altro, l’attuale assenza di narrazioni e immaginari, la cui mancata produzione è un indizio preoccupante della crisi delle élite che guidano la nuova città.
L’andare a zonzo però non può non finire scontrandosi con le sfaccettate immagini di una narrazione tra le più ricorrenti e oggi incrinate di Torino: la città dei santi sociali e della solidarietà. Lo si può fare in tre luoghi apparentemente distanti: la Consolata, chiesa santuario di Torino, la cascina Roccafranca nel quartiere Mirafiori, il Buena Vista Social Club, in un’ex palazzina del Villaggio olimpico.
Lo straordinario meticcio architettonico della Consolata sta per aprire un ennesimo capitolo, grazie a un cantiere di restauro che ne rivela, in ipogeo, le radici medievali. Non bastano a segnarne l’importanza nei secoli le cure di Guarino Guarini, Filippo Juvarra, Carlo Ceppi e Roberto Gabetti. La storia non sempre procede, ma alle volte scopre i suoi tesori andando a ritroso. Nella Consolata, archeologia, devozione e rappresentazione della solidarietà si legano scavando: rimescolano spazio sacro, ordini architettonici e affreschi con i modi, e non solo i tempi, in cui quell’intreccio si esprimeva.
La cascina Roccafranca, tradizionale insediamento di un territorio periurbano d’ancien régime, è diventata, grazie al lavoro di comitati, abitanti e un gruppo di architetti coordinati da Antonio De Rossi (2007), quasi un simbolo di una storia, non così antica ma essenziale, di Torino: la continuità nelle forme dell’integrazione sociale, che solo un’autogestione costruita assieme a un progetto di una multifunzionalità non nominale può consentire.
Il Buena Vista racconta la storia di un’occupazione di un “resto” recente (l’esperienza dei Giochi olimpici invernali del 2006), che diventa un processo sociale e un progetto architettonico con un gruppo di architetti coordinato da Matteo Robiglio (2012), dove la definizione di ciò che è bene comune nasce dal dialogo, a volte duro, tra abitanti che via via si aggiungono, e che sono chiamati a scelte di gestione, accettando un numero di regole semplici ma ostative.
Si tratta di tre frammenti di riappropriazione. Perché le architetture (non solo di Torino) raccontano la storia di una materia che vive continuamente riappropriandosi (in forma fisica o simbolica) di valori, altrimenti rimane semplicemente un’immagine che ci guarda. L’architettura può riappropriarsi del tempo e degli spazi, dei valori e degli usi, facendoli vivere diversamente.
 Ma per esplorare questa Torino sarebbe necessario un altro percorso. Quello di un andare a zonzo nel tempo e nei significati che sappiamo attribuire ai luoghi e che i luoghi stratificano, ripartendo magari proprio da Mirafiori. Allora persino una fabbrica come la FIAT Mirafiori – il luogo quasi dimenticato dell’integrazione a Torino di migliaia di “stranieri” – può svelarci chilometri di sotterranei in cui si sono vissute, dalla Resistenza, storie straordinarie di solidarietà. O un edificio all’apparenza insignificante, in via Baiardi (2017), dove è stato organizzato una sorta di piccolo ospedale per migranti senza permesso, ci parla di una capacità di reinventarsi un modo di andare incontro agli ultimi e di rilanciarne la cura, al di fuori d’immaginifiche città della salute. La città dell’integrazione e della cura degli ultimi scompare e rinasce poche centinaia di metri più in là, continuando a riappropriarsi di spazi e architetture, auliche e non, parlandoci ancora una volta di cosa sia davvero città, anche oggi che essa appare praticamente priva di convincenti narrazioni.
Ma per esplorare questa Torino sarebbe necessario un altro percorso. Quello di un andare a zonzo nel tempo e nei significati che sappiamo attribuire ai luoghi e che i luoghi stratificano, ripartendo magari proprio da Mirafiori. Allora persino una fabbrica come la FIAT Mirafiori – il luogo quasi dimenticato dell’integrazione a Torino di migliaia di “stranieri” – può svelarci chilometri di sotterranei in cui si sono vissute, dalla Resistenza, storie straordinarie di solidarietà. O un edificio all’apparenza insignificante, in via Baiardi (2017), dove è stato organizzato una sorta di piccolo ospedale per migranti senza permesso, ci parla di una capacità di reinventarsi un modo di andare incontro agli ultimi e di rilanciarne la cura, al di fuori d’immaginifiche città della salute. La città dell’integrazione e della cura degli ultimi scompare e rinasce poche centinaia di metri più in là, continuando a riappropriarsi di spazi e architetture, auliche e non, parlandoci ancora una volta di cosa sia davvero città, anche oggi che essa appare praticamente priva di convincenti narrazioni.
Caro Jerome Bruner, come ci manchi!
Immagine di copertina: il salone B di Torino Esposizioni (foto di Fabio Oggero)