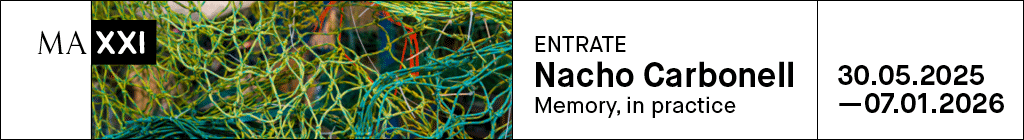Amico, collaboratore e collega, il fondatore del Giornale traccia un ritratto intimo di Roberto Gabetti a vent’anni dalla scomparsa
Ci siamo salutati ancora una volta nel cortile del Castello. Erano le sette e mezza di sera e, come quasi tutti i giorni, avevamo finito quel pomeriggio camminando tra le ali del Valentino. Erano forse più chiacchiere che riflessioni, era affetto che concludeva quella giornata come ormai succedeva da trent’anni. Lo vidi infilarsi in corso Massimo, un po’ esitante e lo seguii, sin dove le nostre strade si separavano. Roberto lo avrei rivisto in un letto della clinica Koelliker e accompagnato nell’ultimo suo viaggio. Era un giorno piovoso di dicembre di venti anni fa.
Sono tanti i giorni che riemergono da un passato che sai, almeno per te, è appena sotto la soglia della coscienza quotidiana. Sulle strade di Dogliani (Cuneo), una mattina, il cielo non aiuta a ricordare la stagione, a zonzo per le architetture di Giovanni Battista Schellino, su sino al cimitero e poi, chiamandolo per nome, come con pochi faceva, da Giulio [Einaudi; n.d.r.]. Al tavolo molto affollato della prima riunione, in assessorato da Giorgio Balmas, a impostare una mostra, Torino tra le due guerre, che doveva fare i conti con un passato, che la città, forse la stessa nostra nazione, aveva (e ha ancora) rimosso. Vicino c’era un altro dei torinesi singolari, Gian Renzo Morteo. Il dialogo era costruito per paradossi e allusioni a una Torino che io appena intuivo, dietro la volontaria nebbia che avvolgeva non solo le loro parole.
Roberto Gabetti (1925-2000) nascondeva quasi sempre quel che realmente pensava, non solo del suo interlocutore, per lasciar emergere giudizi più che taglienti. Capitò in maniera quasi surreale a Milano, quando fu inviato dal ministero in ispezione alla Facoltà di Architettura, non solo occupata. L’incontro con Paolo Portoghesi, suo amico, non solo sodale e non solo nell’avventura del neoliberty, fu, per Roberto, la recita dell’ultimo verso del pagliaccio punito di Stéphane Mallarmé, poeta che lui amava e citava, un simbolista in una wunderkammer privata, popolata di enciclopedisti e ingegneri. Capitò quando ci trovammo a Londra, in una delle poche lezioni che Roberto fece all’estero, all’Architectural Association. Gabetti francofono riuscì a farsi credere da un pubblico poco propenso anche solo ad ascoltare un’altra lingua.
Gabetti è stato testimone di una Torino, di cui fu anche protagonista. E questo doppio ruolo esasperava quasi sempre il suo sarcasmo. Solo una volta l’ho visto emozionato. Al Lingotto, ancora letto abbandonato da due amanti, mentre montavo una mostra su Torino: la prima che si svolse nella palazzina e non nelle officine. Era il 1990. Avevo voluto che a commentare quanto stavo costruendo fossero lui e Giovanni Astengo: mai complici e spesso lontani ma che, dentro un racconto di cui rappresentavano due anime entrambe perdenti e minoritarie, si coinvolsero sin quasi all’emozione.
Ho visto poche volte Roberto senza difese. La prima, nell’estate 1974, nel parco del castello di Sommariva Perno (Cuneo), mentre spiegava il significato di quel giardino. Il giardino era uno dei legami più forti che lo univa ad Aimaro Isola. Loro due, progettisti di opere durissime, come Talponia a Ivrea, esaltata poi dalla critica come primo esempio italiano di Land Architecture.
L’enigma è forse la chiave più autentica per entrare nei progetti di Gabetti & Isola. Non solo perché loro stessi avvolgono le loro opere di narrazioni, diversamente favolistiche. Ma perché intrecciano sino a rendere faticose da riannodare tracce, riferimenti, persino il percorso che porta alla definizione del progetto. La prima volta che entrai nel loro studio, nel giugno 1969, credetti di essere in una macchina del tempo, che solo anni dopo capii che era voluta. Una segretaria, che bisognerebbe saper raccontare, e loro due su due tecnigrafi intenti a “scarabocchiare”. Bel modo di pensare e tradurre il progetto in pensiero e non viceversa. Uno di quegli scarabocchi me lo regalarono quando divenni preside di una Facoltà appena costituita. La nebbia che rendeva quasi iniziatici i loro progetti, in quelle stanze si respirava, proiettando entrambi in una dimensione scherzosamente ottocentesca.
E Gabetti ha lasciato la sua ultima eredità al dottorato di storia dell’architettura proponendo una serie di lezioni, preparate sin nei dettagli, di sezioni temporali. L’anacronismo che diventava storia e la storia come portatrice di vicinanze improbabili e soprattutto inattese. Un giorno del giugno 1986, uscendo dalla sua stanza, Gabetti si trovò faccia a faccia con Marcel Roncayolo, a Torino per un ciclo di lezioni al dottorato. Due tra i più straordinari eccentrici rispetto al cuore delle rispettive discipline, ma anche un architetto e un geografo che facevano innamorare di saperi già allora marginali in una società secolarizzata.
Roberto adorava uscire dagli steccati che non solo il razionalismo arrivato in Italia dagli Stati Uniti, o l’ossessione per il disegno che prefigura e genera l’opera, ponevano in Italia. “Solo Zdanov poteva pensarla così!” Erano le surrettizie divisioni tra discipline, che un autentico intellettuale politecnico non poteva sopportare, a suscitare la sua feroce ironia e che ci ha lasciato purtroppo solo come eredità.
About Author
Tag
anniversari , torino
Last modified: 11 Dicembre 2020