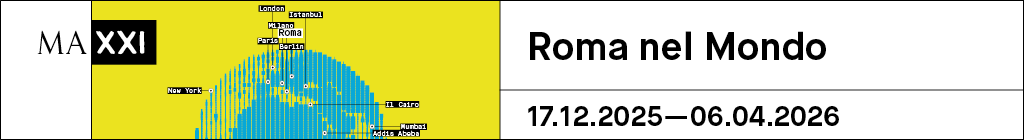In un Kosovo tutt’altro che politicamente stabile, la capitale più giovane d’Europa oscilla tra ambizioni comunitarie e strascichi dell’anarchia edilizia postbellica
A metà ottobre si sono conclusi i lavori del Kosovo Architecture Festival 2020. L’evento, che per ragioni legate all’emergenza pandemica si è svolto per la prima volta telematicamente, è in continua crescita e riporta l’attenzione sullo sviluppo urbano del neonato stato balcanico, in particolare della sua capitale.
L’attuale configurazione urbana di Pristina è in larga misura esito dei processi di ricostruzione “germinati” nella totale deregolamentazione del dopoguerra. La fine del conflitto (1999) è coincisa con l’inizio di una complessa fase di riassetto istituzionale, e la radicale discontinuità socio-politica tra Kosovo pre e post-bellico ha segnato in maniera determinante le sorti della città. La sospensione dei quadri legislativi, tipica dei contesti postbellici, ha assunto qui la dimensione di una completa soppressione dello status quo, incidendo in misura enorme sulle capacità gestionali delle neonate strutture pubbliche locali e sulla ricostruzione dell’ambiente fisico. La somma tra la mancanza di un’esplicita strategia politica di gestione della ricostruzione e l’assenza di un’adeguata ossatura giuridica su cui impostare piani e programmi ha prodotto una condizione particolarmente “invalidante”, se si considera anche il debole impianto finanziario e la scarsità di risorse in cui versava il Kosovo del dopoguerra.
L’affrancamento dai serbi e l’assassinio di una città
Fino agli anni ‘80 Pristina era stata al centro dell’azione pianificatoria con cui, a partire dal 1937, la Repubblica federale jugoslava aveva ciclicamente strutturato l’espansione della città. Attività interrotta nel 1988, in seguito all’adozione General Urban Plan – Prishtina 2000, a causa dell’acuirsi della crisi serbo-albanese, preludio del conflitto.
All’alba dell’evento bellico Pristina si presentava come una città sovraffollata, in cui gli interventi urbani di matrice socialista avevano sostituito quasi integralmente l’old town ottomana. Quella che si è risvegliata all’indomani del conflitto, nell’estate del 1999, era una città votata all’affrancamento dal dominio serbo, processo che implicava la cancellazione delle tracce fisiche della presenza della Repubblica socialista dislocate sul territorio della capitale. Ha così preso avvio la riscrittura del palinsesto urbano, definita da alcuni studiosi “the murder of the city”. Ed è in questo frangente che le preesistenze socialiste sono scomparse inesorabilmente dalla città, testimoniate ora solo da pochi frammenti nel distretto centrale Qendra – in particolare il Palazzo della gioventù e dello sport (Živorad Janković, 1977), il Media Building Rilindja (Georgi Konstantinovski, 1971) e la discussa Biblioteca nazionale del Kosovo “Bogdani” (Andrija Mutnjaković, 1982) – e da alcuni blocchi di edilizia popolare nel distretto Ulpianë.
Alla fine della guerra la città era tornata al centro di una massiccia immigrazione, sia dalle aree interne che dall’estero. La densità abitativa, tornata sui livelli pre conflitto, ha rivelato ben presto l’inadeguatezza della struttura cittadina alla nuova dimensione demografica. Sul suolo della capitale la soglia tra necessità emergenziali e opportunità di profitto è sfocata inesorabilmente, e in un paio d’anni l’esplosione dell’edificazione selvaggia ha portato alla distruzione di oltre 200.000 edifici e alla costruzione ex novo di una quantità di tessuto pari circa al 70% della superficie attuale della città. Nella frenesia di ricostruire la nazione sia fisicamente che in termini di status politico internazionale, la città è stata trattata alla stregua di una tabula rasa da plasmare nella più completa improvvisazione, senza che l’emergenza concedesse il tempo di pianificare. Demolizioni sommarie, insediamenti informali, superfetazioni, occupazioni abusive, scambi di proprietà illeciti e compravendite opache: pratiche sorte nella contingenza della vacatio legis postguerra, rapidamente diffusesi su larga scala e convertite in veri e propri business. La pseudo-pianificazione del dopoguerra si è risolta così in una prassi detta “consenso urbano”, con cui venivano concesse licenze indipendentemente dalla possibilità d’identificare i reali diritti di proprietà, o la rispondenza delle nuove costruzioni a qualsivoglia criterio.
Cenni di un’inversione di tendenza
Se è vero che nel primo decennio del dopoguerra era stato formalizzato il quadro normativo in cui sono inscritte le attività edilizie, è vero anche che questa formalizzazione consisteva in una labile cornice prescrittiva relativa ai requisiti base per l’ottenimento di licenze e permessi; requisiti peraltro vaghi sia in termini di parametri economico-finanziari che di criteri di valutazione delle proposte progettuali. La costruzione di Pristina ha dunque continuato a seguire uno sviluppo che difficilmente può essere detto pianificato. Gli attori coinvolti in questo processo hanno continuato – e continuano – ad agire in uno spazio grigio ibrido tra libero mercato e monopoli parastatali opachi. Le operazioni urbane di maggiore eco mediatica avallate dalla scorsa amministrazione comunale di Isa Mustafa (2007-13) – su tutte la controversa vicenda del Lakrishte District – sono emblematiche in questo senso. Discorso a parte riguarda l’installazione del Newborn Monument, in concomitanza con la dichiarazione d’indipendenza nel febbraio 2008: un intervento legato all’ambizione politica di auto-rappresentarsi come nuova entità statale europea, e che non rientrava nelle dinamiche ordinarie di costruzione della città.
Al di là di azioni simboliche e dichiarazioni d’intenti, le nuove condizioni quadro delineate nell’ultimo decennio più che agevolare hanno in molti casi ostruito lo sviluppo urbano, sia per incongruenze negli strumenti attuativi che per la mancanza di un reale allineamento intergovernativo su strategie e obiettivi. Alla fisiologica intensificazione legislativa non è dunque conseguito un adeguato livello di alfabetizzazione normativa.
È solo nel 2013, quando sulla scena locale si è imposta la figura di Shpend Ahmeti, che il panorama ha iniziato a mutare. A quasi 15 anni dal conflitto, il controllo dell’attività edilizia e la gestione della trasformazione urbana rimanevano le sfide più complesse che l’amministrazione della capitale si trovava a fronteggiare. Ed è su questi aspetti che il politico di Vetëvendosje! (Autodeterminazione) ha costruito il suo programma, con una campagna basata quasi integralmente sulla lotta alle pratiche corruttive e illecite che hanno causato la stagnazione dello sviluppo cittadino. E proprio il parziale concretizzarsi delle promesse da Ahmeti in campagna elettorale ha fatto emergere tutte le contraddizioni locali: la maggioranza dei cittadini aveva sposato una linea politica progressista, orientata a contrastare in modo perentorio gli abusi e la speculazione che stavano soffocando Pristina, ma proprio il prodotto di quegli stessi sistemi opachi garantiva l’indipendenza economica di una parte rilevante di popolazione. Emblematico in tal senso il diffuso malcontento seguito al plateale blocco di tutti i cantieri attivi nella capitale, attuato a poche settimane dall’insediamento della nuova giunta comunale (2013), finalizzato a consentire un controllo a tappeto delle licenze e del regolare svolgimento dell’attività edificatoria nei siti attivi, verso una campagna di sanatoria nazionale.
Possibili frontiere di sperimentazione
Indubbiamente il ritardo nella regolamentazione e nella pianificazione accumulato nel dopoguerra ha fatto da contraltare all’implemento nella capacità gestionale del soggetto pubblico: la parziale inversione di tendenza degli ultimi anni non ha posto fine ai molti problemi connessi all’infinita ricostruzione della capitale. Problematiche che hanno continuato a investire trasversalmente tutte le operazioni di trasformazione urbana. Sintomatico è l’esito dei due concorsi internazionali per il masterplan di Kodrina (concernente un insediamento ex novo a sud-est del territorio metroplitano, vinto dallo studio Libeskind nel 2015) e per la nuova Moschea centrale (concluso senza vincitore). Due progetti che componevano il volano per le aspirazioni politiche di collocare Pristina nel circuito dell’architettura contemporanea internazionale, entrambi arenatisi – sebbene per ragioni specifiche differenti – una volta entrati nelle maglie del complesso “ecosistema” locale.
Al netto della cristallizzazione di alcuni nodi problematici, rimangono comunque evidenti alcune discontinuità rilevanti emerse durante la gestione Ahmeti, per quanto non tutte interrelate alla sua amministrazione: l’intensificazione dell’attività di controllo dell’edilizia, l’incremento dei tavoli di pianificazione e degli scambi tra centri di ricerca locali e network sovra-locali, il consolidamento delle istituzioni accademiche, l’aumento nel numero di eventi e workshop internazionali, la crescita di centri di produzione culturale indipendente, la pressione sociale interna sull’adeguamento dello stato ai requisiti di trasparenza sugli iter procedurali di governance. Tutti questi fattori stanno contribuendo in maniera diversa ma determinante alla diffusione di consapevolezza sull’importanza della sostenibilità socioeconomica dello sviluppo urbano locale.
In particolare, negli ultimi anni la crescente risonanza del Kosovo Architecture Festival, e l’incidenza dei progetti finanziati dall’Unione Europea – su tutti il Culture for Change supportato dal Qendra Multimedia Center – iniziano a produrre ricadute visibili sulla città. Non è un caso se nell’ambito dei lavori per l’adozione della nuova Zoning Map, che dovrebbe estendere gli strumenti regolativi su tutto il territorio comunale entro fine 2020, il Dipartimento comunale dell’Urbanistica abbia deciso di sviluppare alcuni progetti pilota attraverso l’integrazione di proposte bottom-up nate proprio entro i suddetti circuiti di finanziamento comunitario. Il caso più felice è stato quello di The Yellow Pavilion (Architecture for Humans, 2019), installazione temporanea legata alla produzione del documentario “What killed the Architect?”, incentrato sul controverso omicidio dell’urbanista Rexhep Luci (2001), considerato il simbolo della lotta alla dilagante speculazione e agli illeciti edilizi che hanno caratterizzato la ricostruzione nell’immediato dopoguerra. Un’operazione che tradisce la volontà di sperimentare forme inedite di abitare lo spazio pubblico in una città che, ad eccezione del Boulevard Madre Teresa e del Prishtina City Park, soffre enormemente della carenza di luoghi di qualità deputati alla vita collettiva.
A più di vent’anni dal termine della guerra il Kosovo continua a soffrire di una forte instabilità politica, come dimostrano le turbolenze degli ultimi mesi culminate nella caduta del neonato governo Kurti (sostituito da Avdullah Hoti), e dalle dimissioni del capo di stato Hashim Thaçi, processato dalla Corte penale dell’Aja per crimini di guerra. Considerando lo stretto legame tra trasformazione territoriale e condizioni sociopolitiche, appare evidente che la congiuntura attuale non agevoli i tentativi di produrre uno scarto netto rispetto al recente passato. Eppure un’indagine situata consente di cogliere un fermento che sta producendo forme di resistenza in grado d’innestare nuove traiettorie di trasformazione dello spazio. Ancora in piena transizione, la capitale più giovane d’Europa rimane una frontiera d’indagine da osservare con interesse.