Carlo Olmo, fondatore del Giornale, conclude la riflessione storiografica illustrando alcune tracce della sua quadrilogia (+1) per Donzelli dal 2010 al 2020
 Progetto e racconto (2020) rappresenta in primo luogo la conclusione di un progetto storiografico e la scelta di una forma di restituzione del proprio lavoro di storico che tiene insieme, senza mischiarle, riflessioni sulla storiografia architettonica, su cosa sia il fatto (l’architettura) di cui ci si occupa, e di come tale storiografia abbia risposto e risponde alle “domande” che la straordinaria ricchezza di fonti dell’architettura le propone. Il libro offre così al lettore quattro piani su cui la riflessione condotta nella prima parte, ma in realtà in tutti i libri precedenti, può essere falsata. Un’esigenza che si rifà, per chi scrive, alle due conclusioni del testo di Pierre Hadot, Excercises spirituels (1974). La prima è il rapporto tra narrazione, storia e trasparenza che il filosofo (e, aggiungo io, lo storico) dovrebbe mantenere: tra l’apprendre à lire e la sua vita pubblica. La seconda è la citazione di Goethe che chiude il suo dialogo con Eckerman del 25 gennaio 1830, che qui riporto nella traduzione francese di Hadot: «Les gens ne savent pas ce que cela coute de temps et d’effort pour apprendre à lire. Il m’a fallu quatre-vingts ans pour cela et je ne suis pas capable de dire si j’ai réussi».
Progetto e racconto (2020) rappresenta in primo luogo la conclusione di un progetto storiografico e la scelta di una forma di restituzione del proprio lavoro di storico che tiene insieme, senza mischiarle, riflessioni sulla storiografia architettonica, su cosa sia il fatto (l’architettura) di cui ci si occupa, e di come tale storiografia abbia risposto e risponde alle “domande” che la straordinaria ricchezza di fonti dell’architettura le propone. Il libro offre così al lettore quattro piani su cui la riflessione condotta nella prima parte, ma in realtà in tutti i libri precedenti, può essere falsata. Un’esigenza che si rifà, per chi scrive, alle due conclusioni del testo di Pierre Hadot, Excercises spirituels (1974). La prima è il rapporto tra narrazione, storia e trasparenza che il filosofo (e, aggiungo io, lo storico) dovrebbe mantenere: tra l’apprendre à lire e la sua vita pubblica. La seconda è la citazione di Goethe che chiude il suo dialogo con Eckerman del 25 gennaio 1830, che qui riporto nella traduzione francese di Hadot: «Les gens ne savent pas ce que cela coute de temps et d’effort pour apprendre à lire. Il m’a fallu quatre-vingts ans pour cela et je ne suis pas capable de dire si j’ai réussi».
Due considerazioni sono alla base della struttura del libro e della sua impostazione storiografica. Se si vuole ragionare (non ancora fare la storia) sull’architettura, si deve in primo luogo misurarsi con un’autentica foresta di fonti, per interrogare le quali occorre un cassetto degli attrezzi molto fornito. Il progetto storiografico che sta dietro i quattro libri (più La villa Savoye, con Susanna Caccia Gherardini; Donzelli, 2016, pp. 226, euro 42) nasce per rispondere a quell’intreccio e a quella ricchezza di strumenti, senza scivolare nella semplificazione (comunque formalista) che è la via di uscita più semplice e praticata. La seconda considerazione è la deriva della storia dell’architettura, come quasi tutti i saperi umanistici, verso forme di restituzione brevi (articoli), scritte sempre più in una lingua che non è la propria, e rispetto alle quali la valutazione è affidata alla procedura. Difficile in questo contesto costruire un progetto storiografico (e di lunga durata) e, ancor più, rendere esplicite le domande da cui la ricerca muove.
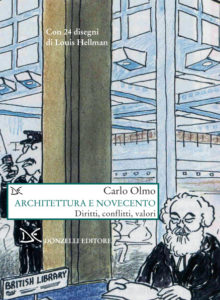 È l’introduzione al primo libro, Architettura e Novecento (2010), a renderle esplicite. La storia dell’architettura, fatta salva una sua rude semplificazione, non è entrata nelle grandi narrazioni del Novecento, nelle sue periodizzazioni. Eppure di Auschwitz, tra pochi anni, resteranno torretta, mura, baracche, forni crematori, l’impianto urbanistico; che non sono solo la “scena” dell’orrore che i nazisti hanno perpetrato. Senza l’architettura, i due temi fondamentali della vicenda della Shoah, la responsabilità individuale e la normalità patologica di chi ha accompagnato il progetto e la sua messa in opera, quasi non emergerebbero. Ma quell’architettura, come all’opposto i luoghi del loisir o delle infrastrutture della società industriale, non hanno spazio nella storia dell’architettura.
È l’introduzione al primo libro, Architettura e Novecento (2010), a renderle esplicite. La storia dell’architettura, fatta salva una sua rude semplificazione, non è entrata nelle grandi narrazioni del Novecento, nelle sue periodizzazioni. Eppure di Auschwitz, tra pochi anni, resteranno torretta, mura, baracche, forni crematori, l’impianto urbanistico; che non sono solo la “scena” dell’orrore che i nazisti hanno perpetrato. Senza l’architettura, i due temi fondamentali della vicenda della Shoah, la responsabilità individuale e la normalità patologica di chi ha accompagnato il progetto e la sua messa in opera, quasi non emergerebbero. Ma quell’architettura, come all’opposto i luoghi del loisir o delle infrastrutture della società industriale, non hanno spazio nella storia dell’architettura.
Definire cosa sia l’oggetto “architettura”, al di fuori della semplificazione dell’autorialità, è ciò che questo progetto storiografico si propone. E lo fa con una seconda scelta, che riguarda sempre l’oggetto architettura: dare egual attenzione alle parole e alle cose che narrano o materializzano un’architettura, senza usare le une per legittimare le altre. Così, Progetto e racconto riprende proprio le fila di quest’ultimo fondamentale duplice piano.
In una stagione in cui semplificazione e omologazione sembrano aiutare un mondo che si trova davanti a complessità che lo spaventano (il diffondersi della paura come stato quasi onnivoro in tanti strati sociali, non è dovuto solo a diseguaglianze ed esclusioni; forse bisognerebbe riprendere in mano un po’ tutti il Sigmund Freud di Psicopatologia della vita quotidiana), la logica dell’amico/nemico è la scorciatoia più facile. E nel caso dell’architettura i… nemici sono talmente facili da individuare (dalla rendita fondiaria e dai suoi molteplici interpreti alla mediatizzazione dell’architettura, sempre più oggetto decontestualizzato da celebrare, magari riconoscendone un dubbio valore universale, o installazione da consumare con uomini e… vestiti, mi si scusi il sarcasmo, che li popolano), che è persino difficile pensare che architettura sia altro.
 Senza voler fare il bignami di un lavoro durato dieci anni, voglio usare due esempi, per spiegare come è proceduto il lavoro. Nel 1991 ero stato a Lisbona, per indagare le forme giuridiche ed economiche che erano state messe a punto per attuare la perequazione comparativa, e le diversità che queste avevano con quanto stava avvenendo a Torino nel dirizzamento di via Dora grossa [attuale via Garibaldi; n.d.r.] nel secondo Settecento. Da una curiosità comparativa, su una fonte giuridica ed economica e sui suoi rapporti con la morfologia urbana, nacque la curiosità/esigenza di misurarsi con il ruolo che la morfologia ebbe nel creare il “mito” della Lisbona del marchese di Pombal, con le retoriche (ordinate e pubblicate) che la reggevano. Arrivare così alla parola “ricostruzione” e al suo nesso con “catastrofe” fu quasi ovvio. Ma su quella parola, non sullo specifico di Lisbona, non si aprì solo una disputa che vide coinvolti i gesuiti e soprattutto Rousseau e Voltaire e visioni contrapposte della società illuminista. La parola aveva una sua storia, che non era solo glottologica: era la storia del rapporto tra la parola e la cosa che voleva rappresentare. È questa storia che mi condusse al fondo De Rossi, alla biblioteca Palatina di Parma, a chiedere l’aiuto di studiosi dell’ebraismo e a confrontarmi con due percorsi d’indagine: la lettura di un testo come l’Esdra e Neemia e l’archeologia del secondo tempio di Gerusalemme. Architettura e storia (2013) ha, nel passaggio qui sintetizzato, uno degli snodi più ardui ma più decisivi per chi scrive e forse anche per chi legge. Il rapporto testo (sacro) e archeologia non è per lo storico dell’architettura così abituale.
Senza voler fare il bignami di un lavoro durato dieci anni, voglio usare due esempi, per spiegare come è proceduto il lavoro. Nel 1991 ero stato a Lisbona, per indagare le forme giuridiche ed economiche che erano state messe a punto per attuare la perequazione comparativa, e le diversità che queste avevano con quanto stava avvenendo a Torino nel dirizzamento di via Dora grossa [attuale via Garibaldi; n.d.r.] nel secondo Settecento. Da una curiosità comparativa, su una fonte giuridica ed economica e sui suoi rapporti con la morfologia urbana, nacque la curiosità/esigenza di misurarsi con il ruolo che la morfologia ebbe nel creare il “mito” della Lisbona del marchese di Pombal, con le retoriche (ordinate e pubblicate) che la reggevano. Arrivare così alla parola “ricostruzione” e al suo nesso con “catastrofe” fu quasi ovvio. Ma su quella parola, non sullo specifico di Lisbona, non si aprì solo una disputa che vide coinvolti i gesuiti e soprattutto Rousseau e Voltaire e visioni contrapposte della società illuminista. La parola aveva una sua storia, che non era solo glottologica: era la storia del rapporto tra la parola e la cosa che voleva rappresentare. È questa storia che mi condusse al fondo De Rossi, alla biblioteca Palatina di Parma, a chiedere l’aiuto di studiosi dell’ebraismo e a confrontarmi con due percorsi d’indagine: la lettura di un testo come l’Esdra e Neemia e l’archeologia del secondo tempio di Gerusalemme. Architettura e storia (2013) ha, nel passaggio qui sintetizzato, uno degli snodi più ardui ma più decisivi per chi scrive e forse anche per chi legge. Il rapporto testo (sacro) e archeologia non è per lo storico dell’architettura così abituale.
 Il secondo esempio riguarda l’uso retorico del termine “piazza”, per sostituire qualsiasi indagine non superficiale, di manifestazioni di dissenso nei confronti di un potere costituito. È quell’architettura, legata o contrapposta a un’idea semplificata del potere, che entra nelle narrazioni più interessanti del Novecento. Ed è un vero paradosso. In Città e democrazia (2018) la riduzione a piazza (e le sue riduzioni metaforiche, sino a piazza informatica) sono riprese dalla doppia storia che sta dietro l’idea di piazza. Quella pubblica, che si fa nascere a Priene e poi… santificare da Ippodamo (la piazza come sinonimo di democrazia), e il bazar/caravanserraglio, come luogo fondamentale di società mercantili, dove si esercitavano diverse forme di scambio. Due percorsi che hanno sin dall’inizio varianti sacre (Ostia antica è l’esempio forse più straordinario) e contaminazioni sin irriverenti (la piazza attorno al Duomo di Ferrara). Processi che trovano in pratiche di semplificazione del complesso rapporto tra architettura e potere, nella piazza, ben prima del Novecento (basti pensare al destino di Place Louis XV, dal completare un disegno urbano con la colonna Egizia e la statua del re sino all’attuale Place de la Concorde), il suo espediente più diffuso. Il nodo per lo storico è come il rapporto tra parola (narrazione) e cosa (la piazza) consenta alla stessa piazza di ospitare riunioni oceaniche di regimi autoritari e trionfanti manifestazioni di… Gerusalemme liberate e di come la piazza, senza una sua definizione fisica che ne riconosca carattere e limiti, possa diventare qualsiasi spianata: anche quella davanti alla chiesa di Fatima o quella costituita da un incrocio di arterie come piazza Tahir al Cairo, solo perché le arterie ruotano attorno a un’immensa fontana.
Il secondo esempio riguarda l’uso retorico del termine “piazza”, per sostituire qualsiasi indagine non superficiale, di manifestazioni di dissenso nei confronti di un potere costituito. È quell’architettura, legata o contrapposta a un’idea semplificata del potere, che entra nelle narrazioni più interessanti del Novecento. Ed è un vero paradosso. In Città e democrazia (2018) la riduzione a piazza (e le sue riduzioni metaforiche, sino a piazza informatica) sono riprese dalla doppia storia che sta dietro l’idea di piazza. Quella pubblica, che si fa nascere a Priene e poi… santificare da Ippodamo (la piazza come sinonimo di democrazia), e il bazar/caravanserraglio, come luogo fondamentale di società mercantili, dove si esercitavano diverse forme di scambio. Due percorsi che hanno sin dall’inizio varianti sacre (Ostia antica è l’esempio forse più straordinario) e contaminazioni sin irriverenti (la piazza attorno al Duomo di Ferrara). Processi che trovano in pratiche di semplificazione del complesso rapporto tra architettura e potere, nella piazza, ben prima del Novecento (basti pensare al destino di Place Louis XV, dal completare un disegno urbano con la colonna Egizia e la statua del re sino all’attuale Place de la Concorde), il suo espediente più diffuso. Il nodo per lo storico è come il rapporto tra parola (narrazione) e cosa (la piazza) consenta alla stessa piazza di ospitare riunioni oceaniche di regimi autoritari e trionfanti manifestazioni di… Gerusalemme liberate e di come la piazza, senza una sua definizione fisica che ne riconosca carattere e limiti, possa diventare qualsiasi spianata: anche quella davanti alla chiesa di Fatima o quella costituita da un incrocio di arterie come piazza Tahir al Cairo, solo perché le arterie ruotano attorno a un’immensa fontana.
Esiste anche la non architettura, e forse una delle più rilevanti confusioni che lo storico dell’architettura sarebbe chiamato a sciogliere è non solo di ragionare sulle parole, sugli immaginari e sulle cose con registri diversi, ma anche di riportare le cose alle parole e fare un minimo di chiarezza sullo scambio ormai sempre più frequente tra parole architettoniche (“piazza” come “villa”) e parole pubbliche o politiche (manifestazioni pubbliche del pensiero non necessitano d’identificarsi con luoghi simbolo).
I quattro libri rispondono a questo progetto. Sicuramente, lo fanno subendo il fascino della scoperta di una fonte, di un archivio, di un testo, che mutano l’orizzonte della ricerca, generando imperfezioni rispetto al progetto iniziale. Lo fanno subendo il fascino di un prodotto umano, l’architettura, che è certamente il più ricco di fonti, di usi, di significati, di temporalità, di contraddizioni, di appropriazioni. E, in qualche misura, proprio questo fascino la storia non deve tradire, seguendo semplificazioni, a volta banalizzazioni e soprattutto omologazioni a parole chiave che popolano l’universo scritto, mediatico e praticato su troppi organi d’informazione. In fondo, non ci vuole tanto: basta un’imperfezione, come due marcapiani sfalsati su una facciata sette od ottocentesca, per aprire un’indagine che affascinerebbe Maigret!
La quadrilogia di Carlo Olmo
Progetto e racconto. L’architettura e le sue storie (Donzelli, 2020, pp. 216, euro 26)
Città e democrazia. Per una critica delle parole e delle cose (Donzelli, 2018, pp. 176, euro 27)
Architettura e storia. Paradigmi della discontinuità (Donzelli, 2013, pp. 186, euro 29)
Architettura e Novecento. Diritti, conflitti, valori (Donzelli, 2010, pp. 140, euro 25)
About Author
Tag
libri , movimento moderno , Storiografia
Last modified: 24 Febbraio 2020
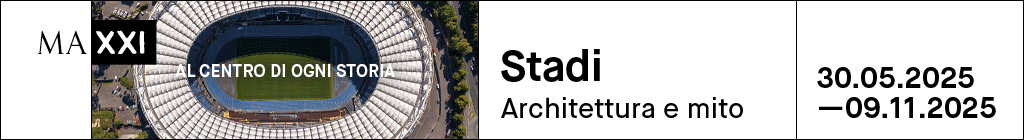

























[…] LEGGE LA SECONDA PARTE […]