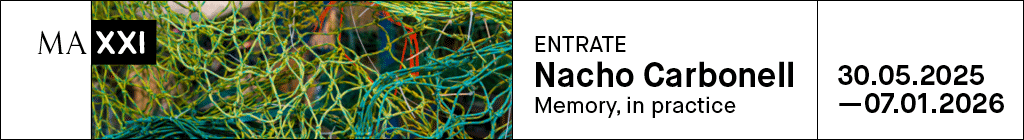Andrea Maffei rievoca l’approccio progettuale del Premio Pritzker 2019, dei cui lavori italiani è stato responsabile
Il fruscio della carta da spolvero gialla era il suono principale delle nostre riunioni. Noi preparavamo una serie di blue-print con i disegni tecnici e questi dovevano raccontare tutto il progetto. I disegni dovevano parlare da soli, senza dire una parola. Isozaki arrivava, con un blazer dell’amico Issey Miyake, li guardava e meditava, in silenzio. Sugasawa-san, una delle giovani segretarie, veniva a chiedere chi voleva il the (verde naturalmente) o il caffè. Lui appoggiava lo spolvero giallo sui disegni, lo strappava della lunghezza necessaria e lo teneva fermo con due piccoli pesi rivestiti di camoscio. Lo strappo dello spolvero tagliava in due l’aria, quasi come il suono di una spada da samurai e faceva iniziare il pensiero. Poi prendeva le matite colorate e iniziava a schizzare sullo spolvero. Oppure il pennello nero per scrivere i kanji e lo usava per disegnare i suoi schizzi.
I plastici erano un altro nostro strumento di progettazione. I miei colleghi giapponesi erano straordinari a realizzare in poche ore plastici in polistirene tagliato a caldo. In scale anche molto grandi venivano realizzati modelli di intere città con decine di piccoli volumi in polistirene semplicemente perfetti. La perfezione giapponese delle cose piccole.
In questo modo abbiamo sviluppato i nostri progetti in Italia. Isozaki è sempre stato grande studioso di Andrea Palladio e di Leon Battista Alberti. Gli piaceva l’idea di poter lasciare qualcosa di suo nel Bel Paese di questi grandi maestri.
L’idea di progetto non partiva mai da una forma, ma da un concetto che volevamo esprimere attraverso l’architettura. Il luogo, la funzione, la città, la storia erano i presupposti per iniziare a pensare. Cosa voleva dire fare quel tipo di edificio in quel contesto? In che modo volevamo interpretare quel modo di vivere quell’architettura in questo momento storico? Questo era sempre il nostro punto di partenza. Spesso si definivano tre o quattro soluzioni completamente diverse. Per ognuna si realizzava un plastico e si poneva sul modello generale per vedere che effetto avrebbe fatto in quel contesto. Alzavamo il modello generale, leggero di poliplat, lo giravamo e guardavamo che effetto avrebbe dato da varie strade e da vari punti di vista. Muovevamo pezzi di città con leggerezza e disinvoltura.
Volevamo elaborare progetti che potessero durare nel tempo. Per questo studiavamo molto la flessibilità d’uso dello spazio. Il modo di vivere gli edifici sta cambiando molto velocemente e non possiamo essere troppo vincolati a forme stilistiche. Il palahockey delle Olimpiadi di Torino (2002-2006) è stato progettato tutto in funzione dell’uso post-olimpico. Una grande scatola in acciaio inox è sostenuta solo da 8 colonne in acciaio. Un unico grande spazio centrale può trasformarsi in vario modo per ospitare concerti, fiere, grandi manifestazioni, senza vincoli formali, strutturali né impiantistici. Diventa una grande “macchina degli avvenimenti”. La stazione di Bologna, concorso vinto nel 2008, partiva dagli stessi principi. La Torre Allianz nel quartiere Citylife a Milano (2007-2015) voleva definire degli spazi a uffici molto flessibili in un unico rettangolo vuoto senza alcun vincolo. Voleva potersi adattare facilmente ai futuri modi di lavorare, che sono in continua evoluzione. Il classico core centrale della torre è stato diviso in due parti, portate alle due estremità, e lascia un rettangolo vuoto al centro. L’idea di endless tower può essere paragonata alle precedenti ambizioni di altri artisti, come Constantin Brancusi, che nel 1937-38 installò una sua endless column nel parco di Targu-Jiu per creare sistemi ripetibili all’infinito. Alla domanda sulle ragioni di tale idea, Brancusi rispondeva: «Serve per sostenere le volte del paradiso».
About Author
Tag
giappone , premi , premio pritzker
Last modified: 12 Marzo 2019