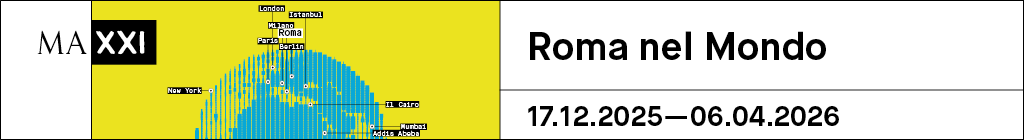Seconda parte del report dal capoluogo lombardo con un focus sull’ex Tempini e il progetto del MUSIL ancora al palo
Leggi la prima parte del report: “Brescia frattale”
—
«I materiali della dismissione costituiscono strati di città oggetto di una “conoscenza selettiva” fatta di invarianti e permanenze, figure e forme di identità: il progetto della “città esistente” mira al recupero del territorio storico e della sua memoria come valore strategico in quanto collettivo e condiviso».
(Michelangelo Russo, Aree dismesse. Forma e risorsa della città esistente, 1998)
BRESCIA. Un grande complesso industriale che, simile a un organismo vivente, si trasforma ogni anno e, accanto, i cipressi del cimitero, sempre uguali a se stessi, come natura pietrificata. La straordinaria ascesa della Metallurgica Bresciana Tempini – fabbrica di “materie e oggetti metallurgici, armi, munizioni da guerra e articoli affini” sorta alle porte della città nel 1884 e arrivata, all’inizio della prima guerra mondiale, a occupare seimila persone – è documentata da una corposa serie di fotografie. Una parte significativa delle quali è stata presa dalla lanterna della torre del faro del Vantiniano, punto di osservazione privilegiato a 60 metri di altezza nei pressi dello stabilimento.
La Tempini si era sviluppata a ridosso del cimitero monumentale, sul lato orientale, generando una commistione di funzioni (e di significati) alquanto curiosa. Tanto più spiazzante quanto importante era (ed è tuttora) il complesso cimiteriale: chiamato così in onore del progettista, l’ingegnere e architetto Rodolfo Vantini (1792-1856), il Vantiniano è stato il primo cimitero monumentale italiano, prototipo di tutti i cimiteri neoclassici del XIX secolo. Opera che, iniziata nel 1813 a seguito delle nuove disposizioni napoleoniche, lo ha impegnato tutta la vita. Quello che a inizio Ottocento era nato come luogo extraurbano per ospitare la quiete e l’aulica aura della città dei morti, per contrappasso, un secolo dopo, si sarebbe trasformato nell’embrione di uno dei più dinamici comparti industriali della città, senza nessun riguardo nei confronti della struttura urbana che l’impianto cimiteriale aveva cercato di suggerire. Una colonizzazione progressiva e non pianificata, favorita dalla presenza di condizioni utili al suo insediamento, ovvero le infrastrutture d’acqua (fiume Grande, un canale ricco d’acqua parallelo al Mella) e del ferro (linea Brescia-Iseo-Edolo) che farà acquisire alla zona a ovest del centro storico la sua definitiva connotazione produttiva e le cui modalità di strutturazione (realizzazione, a partire dal 1906, della via Industriale, sul lato occidentale del cimitero, non prevista dal Piano del 1897 e costruita su proposta e a spese degli industriali Togni) certificano la refrattarietà degli insediamenti produttivi bresciani alla pianificazione intesa come disegno urbano compiuto.
Nel volgere di poco più di mezzo secolo, con la stessa velocità con cui si era formata, questa grande struttura produttiva cresciuta intorno al Vantiniano (ex industrie metallurgiche Comparto Milano verso il centro storico; Caffaro, Oto Melara, Ideal Standard e Ideal Clima verso il fiume Mella) verrà smantellata, lasciando sul campo enormi superfici abbandonate (spesso fortemente contaminate). Una condizione che, viste anche le dimensioni, Brescia non è riuscita ad affrontare in modo organico e che solo recentemente ha iniziato a essere inquadrata in una visione di insieme e dentro una prospettiva culturale.
In quest’ottica, dopo decenni di abbandono, l’area dove sorgeva la Tempini è stata scelta, anche per la sua vicinanza al centro storico, come ambito privilegiato di un faticoso processo di rigenerazione urbana orientato anche dal valore della testimonianza storica, e possibile sede di un luogo della memoria che avrebbe dovuto riscattare, attraverso un’operazione non meramente immobiliare, il quartiere che per decenni aveva rappresentato il riferimento della gloriosa epopea della Brescia industriale, affrontandone il degrado ma conservandone le testimonianze materiali. Un’urgenza che nasce nel momento in cui, con l’avvento del nuovo millennio, nuove economie e logiche territoriali hanno preso il sopravvento, innescando un processo di progressiva trasformazione (e cancellazione) di ciò che per un secolo e mezzo aveva rappresentato l’identità del territorio. Un’operazione in risposta alla “damnatio memoriae” collettiva che ha coinvolto la storia manifatturiera della città, processo in parte inconsapevole e in parte auspicato, nell’illusoria prospettiva che la cancellazione dell’industria e dei suoi segni potesse riconciliare le forme disperse della città contemporanea con il suo passato preindustriale. Processo da sempre contrastato dalla Fondazione Micheletti che, in nome dell’idea di una memoria viva e condivisa, esplicitata nel suo atto costitutivo come necessità di «far conoscere e conservare quanto, pur vicino a noi e storicamente decisivo, rischia di rimanere memoria di pochi: le ideologie del lungo Novecento, le guerre, l’ambivalenza del progresso tecnico, l’industrializzazione, le voci e i volti del lavoro, l’avvento dei consumi, la crisi ambientale», ha promosso, a partire dagli anni ’80, il MUSIL – Museo dell’Industria e del Lavoro, un’idea di museo diffuso della civiltà industriale centrata su una ricchissima raccolta di tracce del tempo vicino e sul recupero di impianti produttivi e intere aree urbane. Un museo (il primo in Italia) dedicato all’industrializzazione come fenomeno che coinvolge l’intera società, sistema a scala regionale sul modello delle migliori realizzazioni europee, definito da un accordo di programma che ormai risale al 2005.
Parte da qui, dall’idea di capire cosa sono stati (e cosa hanno significato culturalmente) l’industria e i suoi spazi per la città e per l’identità collettiva, la riflessione di Kleihues e Schuwerk, vincitori nel 2004 del concorso in due fasi, esito di un percorso culturale nutrito dalla sensibilità di due istituzioni fortemente determinate a ribadire la necessità, in una città come Brescia, di uno spazio dedicato. Il modo in cui questa forte volontà può diventare compatibile con le logiche urbanistiche della Brescia contemporanea è la sfida che la Fondazione per il museo ha lanciato alla città e che una procedura amministrativa apparentemente costruita ad hoc ha per contro trasformato in un iter a dir poco contorto, fatto di società di sviluppo (immobiliare Basileus spa, proprietaria dell’intera area del Comparto Milano, circa 275.000 mq) e scorporo degli oneri di urbanizzazione, di bonifiche (nel 2002/2003 l’area rientra nel perimetro del Sito di bonifica di interesse nazionale (SIN) Brescia-Caffaro: progetto approvato dal Ministero dell’Ambiente, opere durate otto anni con una spesa complessiva di circa 38 milioni) e demolizioni, d’infiniti rinvii e di suddivisioni in lotti (stralci), di ricorsi al TAR e al Consiglio di Stato, durato 14 anni e non ancora concluso (il 28 febbraio 2019 dovrebbe essere emessa una sentenza definitiva). Una sfida che prevedeva d’insediare la memoria del lavoro dentro un ex edificio industriale, a rimarcare l’origine di una futura vocazione come momento eminentemente urbano.
Proprio dalle fotografie dall’alto della Tempini – che documentano con sistematicità (e da punto di vista anomalo ma rivelatore) un processo evolutivo continuo (e incongruo rispetto al vicino cimitero) e che restituiscono l’idea di un’inversione tra dinamica della natura e dinamica dell’artificio – è partito lo studio Kleihues e Schuwerk per il progetto. È impossibile, per Schuwerk, affrontare il tema (l’eredità della fabbrica in quanto spazio sociale) senza considerare le specificità e le contraddizioni di uno spazio industriale che diventa museo. L’enorme disponibilità di superficie che le fabbriche dismesse “offrono” non può essere pensata come contenitore di pronto impiego restituito alla città, sia perché spesso mancano le condizioni per un suo riuso immediato (luoghi da bonificare, strutture non più conformi con le normative vigenti), sia perché quei luoghi non sono (contrariamente alla convinzione consolidata) nella disponibilità della città, non sono spazi pubblici.
Ed è inevitabile la delicatissima questione della memoria, della cristallizzazione di uno spazio che per sua natura è sempre stato uno spazio evolutivo e mai una tipologia permanente – soluzione provvisoria, come ci ricorda Eugenio Battisti a cui il museo è dedicato, e non modello immutabile –, del conflitto tra architettura e cultura industriale, dell’incompatibilità delle rispettive logiche (i tempi lunghi dell’architettura contro i tempi inesorabilmente sempre più veloci dell’economia che cambia), dell’“utilitarismo” della fabbrica (un organismo che “semplicemente” ottimizza le risorse in funzione della produzione), del suo essere recinto, spazio economico privato, luogo intimo e vietato. Una riflessione sull’architettura che si sposta su un piano eminentemente teorico e riguarda questioni complesse come la coerenza tra immagine e geometria originaria, lo snaturamento del funzionamento strutturale, la perdita di riconoscibilità, il “restauro ricostruttivo” e la firmitas, ovvero la durata nel tempo come condizione essenziale perché l’architettura possa essere definita tale, come elemento che lega cultura e memoria e definisce ciò che è meritevole di essere ricordato.
Il progetto agisce quindi attraverso una rottura concettuale: ribalta tutta la situazione, cristallizzando le vestigia di un edificio produttivo in una forma stabile, definitiva, non più evolutiva. Da luogo dell’utilitarismo a luogo dell’inutilità: il museo come il luogo più inutile del mondo. Un’idea che per Schuwerk rappresenta l’essenza stessa del fare architettonico, “miesianamente” concepito nei termini di Baukunst. Come per gli antichi la nobiltà dell’architettura viene fondamentalmente dalla sua inutilità: è il concetto utilizzato nel progetto e accolto nell’immagine della nuova facciata. Nel progetto il principio della serialità dell’industria «viene ereditato e adottato, ribaltandone il senso, per raggiungere un fine antitetico: realizzare spazi della “memoria culturale”. Quello che nella fabbrica aveva logica di pura utilità, conferisce al museo valore di permanenza. Da questa contraddizione tra la natura non permanente dell’industrializzazione e quella permanente dell’istituzione museale si sviluppa la logica del progetto». Tema che culmina nella torre, cui non corrisponde alcuna funzione specifica. Un’interpretazione sorprendente, che riesce a far passare in secondo piano gli annosi problemi dell’infinito iter amministrativo e le questioni di budget. Che contribuisce paradossalmente a far sopportare l’idea che siano trascorsi 14 anni dal conferimento dell’incarico senza nessun risultato, proiettando la vicenda in una sorta di dimensione metastorica, di tempo sospeso, e ricollocando il tema del museo dove gli spetta: non più contingenza, evento o circostanza.
La dilatazione dei tempi di realizzazione diventa quindi il modo per verificare la bontà del progetto – «non cambierei una virgola, lo rifarei tale e quale», ammette Schuwerk –: la dimostrazione, nonostante un certo aspetto minimalista innegabilmente legato al proprio tempo, della sua classicità, del suo non essere (stato) di moda. Risultato di un lavoro collettivo, di una collaborazione intensa, di un’esperienza umana e di una profondità di pensiero che racconta dell’importanza delle tracce della civiltà industriale e della funzione sociale del lavoro. E si comprende allora come questo edificio, pacata riflessione sulla lunga durata (cara a Fernand Braudel) e nuovo principio insediativo esso stesso, si pone come risposta possibile all’arroganza neocoloniale dei nuovi padroni delle ferriere, degna conclusione di una storia secolare.