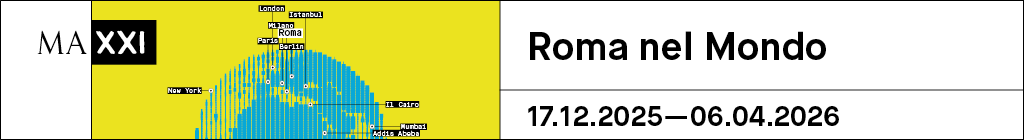L’architetto ticinese prosegue la serie di interviste sul ruolo odierno del progettista e della didattica dell’architettura
Dopo gli interventi di Mario Abis e di Simone Sfriso, il ciclo di interviste ai relatori del convegno “Architettura Oggi. L’evoluzione nel ruolo del progettista e nella didattica dell’architettura” (Ravenna, 22-24 novembre 2018) prosegue con Mario Botta. L’architetto elvetico è titolare dal 1970 di uno studio professionale a Lugano, poi trasferito a Mendrisio dal 2011. Proprio qui è stato tra i fondatori, nel 1996, dell’Accademia di Architettura di Mendrisio, che ha più volte diretto e dove tuttora insegna.
La costruzione di una nuova scuola d’architettura impone chiarezza sui modelli da offrire agli studenti. Quali adottaste?
Quegli anni avevano l’ingenuità e l’energia degli inizi. Gli esordi sono sempre contraddistinti da una carica unica di forza e di bellezza che poi non si può pretedere di rintracciare compiutamente nell’opera realizzata, sottomessa alle condizioni del tempo. Quello che significava per noi, allora, lo slancio verso processi tesi a formare un architetto umanista è qualcosa che resta ancora all’orizzonte rispetto agli sforzi che poi concretamente si sono potuti fare. Anche quel progetto ha pagato in qualche misura lo scotto del tempo, di una professione normata [*da una legislazione europea, n.d.r.], di una condizione generale della cultura che privilegia la definizione dei ruoli e delle competenze e che ha in parte perso lo slancio dell’utopia. Alle origini dell’Accademia di Mendrisio vi era il coraggio per l’affermazione di un architetto contemporaneo e generalista, un architetto umanista, capace di produrre una sintesi e una rappresentazione dell’umano da accogliere e interpretare in architettura. Questa figura poteva e può apparire fuori dal tempo e fuori dal mercato, contraria ad un mondo che richiede specializzazione, ambiti precisi d’intervento e competenze. In realtà è esattamente il contrario: la complessità attuale necessita di una figura che ne tenti la sintesi e renda in tal modo questa stessa complessità abitabile per l’uomo.
La scuola nasceva anche con una forte componente territoriale. Accanto all’indirizzo di un “architetto umanista”, la bibliografia reca anche quello di un “architetto territoriale”. Che cosa significa questo epiteto e come dialoga con il tempo della globalizzazione?
Globale e locale giocano per fortuna in modo conflittuale. La globalizzazione è una realtà di fatto, una realtà che esiste nei mercati e nelle conoscenze. È tuttavia una realtà lontana dallo spirito. Al contrario tanto le persone quanto gli edifici non possono sfuggire al locale. Ovunque essi siano, essi sono legati ad una terra. Questo contatto con la terra, per l’architetto significa appartenere ad un Ethos, ad una cultura territorializzata. La consapevolezza di questa appartenenza, che si è voluta sottolineare alla fondazione dell’Accademia di Mendrisio, significa ribadire la centralità del fatto etico, costante della disciplina dell’architettura ben prima degli apparati distributivi o delle determinazioni funzionali. Quando si auspica un “architetto territoriale”, si prefigura un progettista capace di riconoscere nello spazio quei valori simbolici, storici, civili che caratterizzano i paesaggi, a partire da quelli prossimi, per raggiungere anche quelli lontani. “Architetto territoriale” è un progettista che sa frequentare il sedimentato e i territori della memoria e sa leggerli nel paesaggio. Questa consapevolezza di sé e del proprio contesto consente di affrontare altri luoghi, altri mondi, e i temi del mondo globale appunto.
—
Dunque un architetto territoriale e “territorializzato”. E per le architetture? Che cosa significa avere un luogo?
Per le architetture, il locale che salva è il contatto con la terra. Ciò significa anzitutto il particolare luogo ove esse scaricano il proprio peso. Viviamo invece il tempo del grande equivoco della leggerezza. Non sono contrario alla leggerezza quando essa produce un’estetica. Sono contrario all’equivoco che interpreta la leggerezza come isotropia, come un’architettura ridotta a rappresentazioni di opere su paesaggi monotoni nella loro bellezza, stereotipati, come il linguaggio pubblicitario delle pagine di moda. Vi sono invece architetture che appaiono nella loro bellezza specialmente in giornate di pioggia, in situazioni d’esperienza uniche, ma di fatto irrappresentabili. Il qui dell’architettura è il territorio di questo loro situarsi. La natura vuole che i carichi vengano portati a terra, e questa territorialità non è solo una questione fisica ma, altrettanto, simbolica: l’architettura trova nella terra la propria madre. La terra implica la comprensione simultanea di un paesaggio e di un ambiente: che poi il fatto ecologico e quello architettonico oggi siano stati separati, è un vizio contemporaneo. La comprensione dell’ambiente e del territorio è stata sempre intrinseca all’architettura come disciplina di sintesi, arte a fortissima vocazione interdisciplinare.
—
Il progetto celebra però oggi la collazione delle competenze più che quella delle discipline. Il controllo del benessere tra serrati parametri numerici, necessita del conforto degli specialisti. Quale il ruolo dell’architetto in questo coro?
Il progetto oggi ha bisogno di competenze tecniche specialistiche. Affermare questo non significa tuttavia ammettere la parcellizzazione dell’unità del fatto creativo. Questa parcellizzazione è piuttosto il principio della macchina, adottato per produrre di più e per consumare più in fretta. La divisione del processo di progettazione è una conquista pericolosa che apre all’eccessiva approssimazione. L’architettura necessita invece di una maturazione lenta, di un percorso che implica i processi del tempo, di umiltà e perseveranza nei confronti del proprio lavoro. La fretta e la velocità imposte ai progetti stanno trasformando l’architettura in qualcosa d’altro, in qualcosa che può assomigliare all’architettura ma altro non è che un’affiche, una riduzione bidimensionale dell’architettura: la sua rappresentazione. Questo è anche il riflesso di un tempo che ha perso complessivamente la spinta all’utopia. Al contrario era proprio lo spirito dell’utopia a muovere i grandi protagonisti del Movimento moderno. Al centro delle loro riflessioni vi era l’esistenza dell’uomo intesa contemporaneamente nella sua dimensione individuale e sociale. Ciò che allora appariva un nesso inscindibile, appare oggi un equilibrio impossibile, un punto d’incertezza e inquietudine.
Anche in Italia, quando Bruno Zevi, Ludovico Quaroni, Ernesto Nathan Rogers parlavano di architettura, questa era sempre intesa come casa comune, dell’individuo inteso come essere politico, animale sociale. L’incertezza di cui Lei parla che destino apre all’architettura? Ci sarà ancora spazio per essa?
Sono contrario a scenari apocalittici. L’architettura ha la sua salvezza nel trattare in ogni suo aspetto di archetipi fondamentali: limite / soglia / interno / esterno … Fin quando esisterà un uomo, allora ci sarà architettura. La necessità di dargli un rifugio prescinde fortunatamente dal capriccio della volontà o della ricerca. L’architettura comincia perché anche il semplice rifugio deve comunicare all’uomo un senso di sicurezza e riparo. Se si mette al centro l’uomo, colto anche nelle sue esigenze prime e primordiali, l’architettura è già evocata, è già lì.