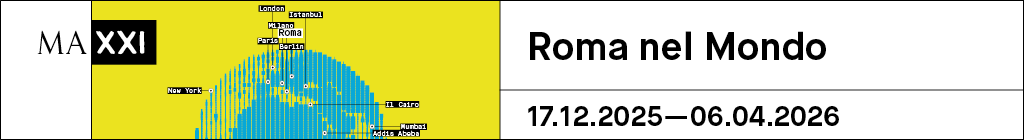Per sostenere un’affermazione simile bisognerebbe avere strumenti appropriati e conoscere i dati. La risposta alla crisi della cultura sociale del progetto non può essere banalizzata. Carlo Olmo, fondatore del Giornale, spiega perché
Leggi la lettera che ha dato il via al dibattito e le risposte
Quando si parla di immaginari sociali bisognerebbe averne gli strumenti e soprattutto conoscere i dati. Forse negli anni cinquanta e sessanta l’immaginario di chi si iscriveva alle Facoltà di Architettura poteva essere Le Corbusier e Wright. Era allora una società che alimentava mitologie sociali e a questo processo non si sottraevano architetti e studenti di architettura. Come negli anni novanta, sempre del Novecento, la fortuna delle archistar fu determinata dalla crisi di legittimità che riguardò forze sociali e politiche e amministrazioni pubbliche. La scorciatoia del “nome”, per bypassare processi burocratici, incapacità decisionali e mancanza di strategie politiche era molto diffusa.
Sarebbe sin troppo facile dire che oggi persino la memoria di cosa hanno realizzato Le Corbusier, Wright o Mies è un problema che si può verificare quotidianamente agli esami di storia dell’architettura o nei laboratori di progettazione. Ma il problema non è solo di memoria. Oggi sono altri i naming without necessity che alimentano gli immaginari degli studenti che popolano i dipartimenti di architettura. Il vero problema è che sono immaginari desunti da altre culture, non da quella architettonica. Smart, sostenibilità, virtualità, sicurezza, green e una visione dell’architettura che tanto deve alle installazioni artistiche, costruiscono non solo gli immaginari ma il primato proprio delle tecniche sulla cultura del progetto. Una cultura, occorre ricordarlo, che le facoltà di ingegneria condividevano con quelle di architettura (non credo occorra ricordare Freyssinet, Torroja, Nervi, Morandi…). Oggi la frammentazione dei saperi tecnici (quanto questa sia fondata è davvero un’altra, bella questione), riempie le ore di chi studia ad architettura, quasi sempre seguendo minicorsi iper specialistici che hanno allontanato dalla formazione dell’ingegnere e dell’architetto la stessa idea del progetto (di macchine, motori, sistemi informatici, impianti industriali, ospedali, scuole, musei, case…).
Alle due facoltà, in maniera diversa manca anche solo la percezione che l’architettura e l’ingegneria sono una produzione sociale di senso, prima che di oggetti; e per essere capaci di dominare una dimensione culturale e produttiva che è enormemente cambiata e cambia quasi di anno in anno, bisogna saper educare alla dimensione critica, al lavorare in team, al dialogo tra saperi relazionali non solo tecnici. Ricordandosi, per l’architettura, che il cuore del suo essere un sapere esperto e millenario, è nel mestiere più difficile per l’architetto: non dare per scontata, ripetitiva e banale la distribuzione dello spazio, di qualsiasi spazio.
Le componenti tecniche, assunte come miti direbbe Blumenberg, hanno creato per altro privilegi e nicchie professionali, non solo demolito l’idea del progetto come missione delle culture politecniche. Ma ricordiamoci che dall’inizio dell’Ottocento quelle culture erano tali perché sapevano benissimo che la tecnica è anche una produzione sociale. È sufficiente leggere la “Revue Générale de l’Architecture”, non solo Carlo Cattaneo, per accorgersene. E che Le Corbusier usasse le metafore della nave o della macchina contro culture ripetitive e che riducevano la storia a etichette, ormai non lo hanno solo scritto, nei lontani anni ottanta, Tim Benton, Giuliano Gresleri, Bruno Reichlin. Basta leggere davvero Vers une Architecure e ci si accorge che lo standard per Le Corbusier si forma rileggendo la storia e le culture antropologiche, non certo per ragioni tecniche. Ma il problema non è Le Corbusier.
Il problema è che oggi sono morte le professioni liberali che hanno segnato da metà Settecento la società borghese. Avvocati, medici, ingegneri, commercialisti, architetti oggi non sono più individualità che devono risponder di persona a una committenza riconoscibile e non anonima. Oggi sono forme di lavoro associativo. Basta entrare in uno studio di avvocati o in un reparto di clinica medica per accorgersene. Ma sono mutate anche le basi etiche di quelle professioni liberali: in primis la responsabilità.
I problemi che hanno davanti, insisto, le culture politecniche e l’architettura, è l’aver accettato e diffuso saperi pseudotecnici, popolando scuole che hanno senso di esistere se sono in grado di rispondere a compiti “progettuali”, con saperi normativi, applicativi, con una cultura del problem solving senza che si sapesse discutere della natura del problema da affrontare, prima che risolvere.
È la crisi della cultura sociale del progetto che non tocca solo le Facoltà di Architettura, quella che si vive oggi. E le soluzioni possibili non sono davvero così banali e tanto meno si possono ritrovare in una delle cause della crisi stessa. In maniera che dire infelice è poco, a partire dall’inizio degli anni novanta, per scelte che competevano anche alle facoltà di Architettura e a chi allora le presiedeva, si è allargata spropositatamente, il numero delle sedi in cui si offriva una “formazione da architetto”. E il grimaldello fu proprio il corso di laurea in ingegneria edile-architettura, voluto in maniera feroce dalle facoltà di Ingegneria, ma anche da facoltà di Architettura che volevano sfruttare l’allora cultura del decentramento e la normativa sui grandi atenei per moltiplicare posti e… caballeros.
Avere in Italia più di cinquanta sedi in cui si formerebbero architetti, ha dato l’esito che l’ultima VQR [Valutazione della Qualità della Ricerca; n.d.r.] fotografa in modo impietoso. In quaranta di quelle sedi non solo non c’è quasi traccia di attività scientifica, ma c’è una diminuzione degli studenti che ormai sta chiudendo quelle cosiddette offerte didattiche. Offerte dove, fatti salvi quattro o cinque casi su quasi venticinque, non esistevano proprio le basi per formare un architetto, in cui si praticava un trasformismo tipicamente italiano (ad insegnare ad esempio storia come progettazione c’erano figure alquanto dubbie), in cui lo studente ritrovava il suo docente a fine lezione solo per volontà del… caso. E alla corsa di questa carovana alla ricerca di un immaginario albero della cuccagna, non si sono certo sottratte le facoltà di Architettura, che da 11 nel 1991 sono diventate 26 nel 2006.
Oggi quelle realtà stanno spegnendosi come le lampadine dell’albero di Natale dopo la Befana: non per l’autocritica che sarebbe necessaria, ma per… morte naturale. Proporre l’ingegneria edile-architettura come modello può far solo sorridere o può, peggio, far pensare davvero a una disinformazione allarmante e a una mancanza di cultura istituzionale forse ancor più difficile da comprendere. Così come risollevare il problema del mercato del lavoro dei laureati in architettura nel modo in cui si dice nella lettera pubblicata.
Oggi solo chi non conosca come si diventa professori di scuola media può avallare quanto sostiene l’autore della lettera. Il problema è ben più grave e investe insieme la necessaria programmazione degli accessi all’università, i rapporti docenti/studenti nei corsi e nei laboratori, l’applicazione vera e autentica del 3 e 2, la missione dell’università (che solo in parte è professionale, per fortuna), il sistema contrattuale del lavoro autonomo (questione che non riguarda certamente solo gli architetti), il sistema pubblico che regola appalti e le catene di Sant’Antonio che si sono create, premiando solo e sempre cordate precostituite di imprese e professionisti, l’assenza in Italia di una cultura dei concorsi (se confrontata, senza guardar lontano, almeno alla situazione francese). E non voglio continuare. Ma se il mercato del lavoro dell’architetto si è così contratto, non è solo per una crisi dell’industria delle costruzioni che non accenna a risolversi, ma è perché si sono create situazioni di oligopolio e presupposti per un’illegalità che l’assurda legiferazione ha indubbiamente e forse scientificamente perseguito.
Semplificare e banalizzare la realtà è una malattia che viviamo troppo spesso, una malattia che aggrava i problemi che si devono affrontare: ce lo racconta ogni giorno la cronaca politica e giudiziaria. E tra questi uno dei più gravi è l’assenza di una discussione pubblica, trasparente, informata, basata su una conoscenza storica approfondita e su dati confutabili ma sicuri, sulla formazione a una delle professioni più complesse, oggi ancor più che ai tempi di Le Corbusier o di Norman Foster. Speriamo che questa lacuna che riguarda tutti (Dipartimenti, Scuole, Ordini, Parlamento, Amministrazioni), possa essere colmata.
La funzione sociale del lavoro dell’architetto è uno dei pochi dati certi. Un ospedale mal distribuito, una scuola che ignora le nuove forme di didattica, uffici che non sanno cosa sia il telelavoro e i mutamenti che la cultura digitale sta apportando anche allo spazio del lavoro, un tempo di ufficio, l’ignoranza di come è mutata la composizione sociale della domanda di residenza, la cultura abitativa, la struttura demografica delle famiglie e di come questa domanda si distribuisca sul territorio, quanto i processi di patrimonializzazione stiano toccando quasi ogni prodotto dell’uomo, può solo portare a banalizzare ancor più città e paesaggi italiani. E non ce n’è davvero bisogno.
Immagine di copertina: copertina della “Revue générale de l’architecture et des travaux publics: journal des architectes, des ingénieurs, des archéologues, des industriels et des propriétaires”, dir. César Daly, ed. Paulin & Hetzel, 1840-1890