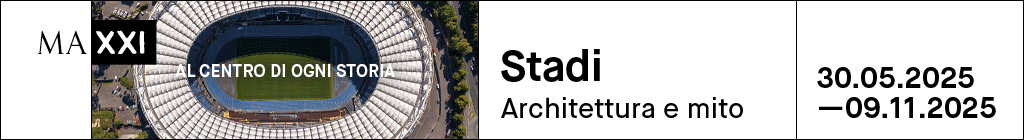Nelle Langhe, camouflage in nome di un ambiguo progetto di riqualificazione energetica per un’opera brutalista lodata anche da Bruno Zevi
Nell’ottobre del 1999 usciva il numero 528 de “L’Architettura. Cronache e storia”, la rivista diretta dal grande critico di architettura Bruno Zevi. Sfogliando le pagine degli editoriali, poco prima delle recensioni dell’opera di Arata Isozaki a Shizuoka e quella di Zaha Hadid a Weil am Rhein, compare una realizzazione di un architetto italiano, curiosamente localizzata in un piccolo paesino della Langa astigiana. E’ il Municipio di Roccaverano, progettato dall’architetto Giulio Balbo ed edificato fra il 1979 ed il 1985.
 L’articolo, edito perciò postumo all’edificazione, volutamente analizza l’opera a distanza nel tempo, per non cadere nell’errore di un facile “marchettarismo” che afflige, allora come oggi, molta della critica architettonica del periodo. Si evidenzia il piccato linguaggio dell’opera, che rilegge il contesto storico circostante e cerca un inserimento ambientale del lato a valle nel seguire le curve di livello, articolandone i muri controterra. La torretta dialoga nello spazio dell’abitato e attraverso le epoche storiche, instaurando legami con la prospiciente chiesa bramantesca, sede della sfera spirituale, e la torre romanica del ricetto medioevale (sede dell’allora sfera temporale). E’ perciò simbolo locale della nuova dimensione politico-amministrativa della giovane Repubblica Italiana, plesso scultoreo in bilico fra monumentalità e espressionismo, omaggi di Balbo che sanno di adesione al Movimento Brutalista. Beton brut, dunque, cemento armato a vista, elemento artificiale che lo stesso Le Corbusier indicava come il materiale più adatto al confronto con la pietra (elemento naturale), e che esalta in una sua particolare opera: la Casa della Cultura a Firminy (Francia, 1965). Il plasticismo scultoreo risente della lezione del tedesco Gottfried Böhm, il grande architetto Premio Pritzker nel 1986, che fonderà le innovazioni concettuali, promosse dal maestro svizzero, con le esperienze di Hugo Häring e con il geometrismo di Sol LeWitt. Balbo ne rimarrà affascinato, recandosi 2 volte in Germania, nel 1974 e nel 1976, per conoscere Böhm e studiarne la poesia delle opere e farne prosa. Anche la prosa, e non sola la poesia e l’accademia, serve a studiare ed a comprendere le espressioni di un’epoca.
L’articolo, edito perciò postumo all’edificazione, volutamente analizza l’opera a distanza nel tempo, per non cadere nell’errore di un facile “marchettarismo” che afflige, allora come oggi, molta della critica architettonica del periodo. Si evidenzia il piccato linguaggio dell’opera, che rilegge il contesto storico circostante e cerca un inserimento ambientale del lato a valle nel seguire le curve di livello, articolandone i muri controterra. La torretta dialoga nello spazio dell’abitato e attraverso le epoche storiche, instaurando legami con la prospiciente chiesa bramantesca, sede della sfera spirituale, e la torre romanica del ricetto medioevale (sede dell’allora sfera temporale). E’ perciò simbolo locale della nuova dimensione politico-amministrativa della giovane Repubblica Italiana, plesso scultoreo in bilico fra monumentalità e espressionismo, omaggi di Balbo che sanno di adesione al Movimento Brutalista. Beton brut, dunque, cemento armato a vista, elemento artificiale che lo stesso Le Corbusier indicava come il materiale più adatto al confronto con la pietra (elemento naturale), e che esalta in una sua particolare opera: la Casa della Cultura a Firminy (Francia, 1965). Il plasticismo scultoreo risente della lezione del tedesco Gottfried Böhm, il grande architetto Premio Pritzker nel 1986, che fonderà le innovazioni concettuali, promosse dal maestro svizzero, con le esperienze di Hugo Häring e con il geometrismo di Sol LeWitt. Balbo ne rimarrà affascinato, recandosi 2 volte in Germania, nel 1974 e nel 1976, per conoscere Böhm e studiarne la poesia delle opere e farne prosa. Anche la prosa, e non sola la poesia e l’accademia, serve a studiare ed a comprendere le espressioni di un’epoca.
 Questa però è storia. L’architettura che descriviamo oggi non c’è più. O meglio, sopravvive ma all’interno di un camouflage, traballante esperanto formale elevato ad arte.
Questa però è storia. L’architettura che descriviamo oggi non c’è più. O meglio, sopravvive ma all’interno di un camouflage, traballante esperanto formale elevato ad arte.
La rilettura critica dell’edificio passa attraverso un ambiguo progetto di riqualificazione energetica, che abbina le legittime istanze del contenimento delle dispersioni di calore ad un’energica revisione del linguaggio usato, considerando la struttura un non finito e perciò da completare. In questo atteggiamento paternalistico, si perde così la lettura della torretta e del suo parallelepipedo sommitale di nove lati, ora geometrizzata e alterata nelle proporzioni, così come la globale intonacatura delle superfici e il decorativismo finto antico dei cantonali in pietra. L’opera, fuori contesto per alcuni e stridente nel paesaggio locale dominato dalla pietra, è stata ricondotta all’ordine, appiattita, in fede a un revisionismo storico che sa di damnatio memoriae nei confronti di un’epoca scomoda, quella della disillusione sociale successiva al secondo conflitto mondiale, che sfociò nel Brutalismo. Il fraintendimento nasce proprio per la diversa visione dei valori sociali di base condivisi, di una comunità locale che non si riconosce all’interno dei segni espressivi che questa corrente produsse, ossia l’opposizione ideologica ai “ruffiani” stilemi moderni del nuovo empirismo svedese e del finto vernacolare, mutuati proprio dalla genuinità della civiltà rurale. Nella Langa, però, quei valori secolari raccontano un’identità culturale, e fomentano un aspro scontro dialettico, mai del tutto taciuto, che ha prodotto questa reazione allergica a distanza di 30 anni. Il tutto nonostante la storicizzazione dell’opera, e ciò significa che ancor oggi i valori della Controcultura con i quali si schiera il Brutalismo vengono riconosciuti estranei alla memoria della storia locale, e ritenuti erroneamente fastidiosi ed imposti.
 Di chi sono le colpe dello strappo prodotto? Occorre un approfondito esame di coscienza delle parti in gioco, in un sottile pendolo di accuse reciproche, promesse mancate e premesse evase, legate alla particolare natura di quell’opera, in bilico fra razionalismo e espressionismo.
Di chi sono le colpe dello strappo prodotto? Occorre un approfondito esame di coscienza delle parti in gioco, in un sottile pendolo di accuse reciproche, promesse mancate e premesse evase, legate alla particolare natura di quell’opera, in bilico fra razionalismo e espressionismo.
 C’è da dire che l’architettura, per sua natura evoluzionista, cambia linguaggi e percezioni, e guarda al Brutalismo come ad un’epoca storicizzata, superata da un nuovo credo globale volto a valorizzare l’empatia ambientale ed i tecnicismi (il cosiddetto neo International Style). Proprio per questo, pensare ad una valorizzazione del patrimonio architettonico contemporaneo è doveroso, per evitare campagne iconoclaste come nel caso di Roccaverano. La percezione del contemporaneo dev’essere aumentata, perché i rischi di scivolare in uno sterile empirismo e di ritirarsi all’interno del regionalismo critico sono reali, e sfociano sempre in operazioni dubbie. Certo, è pur vero che nell’aporia che vede da una parte l’interesse per l’opera e dall’altra l’uomo comune “di strada” che mal digerisce l’edificio, rimuovere e discriminare ciò che non si comprende non è la via corretta da praticare. Nessuno si sognerebbe mai di completare, infatti, le celebri jute materiche di Alberto Burri, così come di nascondere ai visitatori di un museo un “vecchio” dipinto di Jean Dubuffet, il pittore simbolo dell’Art Brut ed esposto al MoMA di New York. E questo non per incappare in sanzioni penali, legate alla violazione del diritto d’autore sulle opere, ma per il condiviso valore dell’arte nella società, che spesso provoca ma aiuta a riflettere, e sicuramente porta ad un dibattito sociale. Se l’architettura è l’arte dell’abitare, occorre perciò una maggiore sensibilizzazione sul costruito, e se proprio dev’essere, meglio operare un abbattimento che subire questo camouflage, certamente politically correct ma dal sapore insipido proprio dell’edilizia.
C’è da dire che l’architettura, per sua natura evoluzionista, cambia linguaggi e percezioni, e guarda al Brutalismo come ad un’epoca storicizzata, superata da un nuovo credo globale volto a valorizzare l’empatia ambientale ed i tecnicismi (il cosiddetto neo International Style). Proprio per questo, pensare ad una valorizzazione del patrimonio architettonico contemporaneo è doveroso, per evitare campagne iconoclaste come nel caso di Roccaverano. La percezione del contemporaneo dev’essere aumentata, perché i rischi di scivolare in uno sterile empirismo e di ritirarsi all’interno del regionalismo critico sono reali, e sfociano sempre in operazioni dubbie. Certo, è pur vero che nell’aporia che vede da una parte l’interesse per l’opera e dall’altra l’uomo comune “di strada” che mal digerisce l’edificio, rimuovere e discriminare ciò che non si comprende non è la via corretta da praticare. Nessuno si sognerebbe mai di completare, infatti, le celebri jute materiche di Alberto Burri, così come di nascondere ai visitatori di un museo un “vecchio” dipinto di Jean Dubuffet, il pittore simbolo dell’Art Brut ed esposto al MoMA di New York. E questo non per incappare in sanzioni penali, legate alla violazione del diritto d’autore sulle opere, ma per il condiviso valore dell’arte nella società, che spesso provoca ma aiuta a riflettere, e sicuramente porta ad un dibattito sociale. Se l’architettura è l’arte dell’abitare, occorre perciò una maggiore sensibilizzazione sul costruito, e se proprio dev’essere, meglio operare un abbattimento che subire questo camouflage, certamente politically correct ma dal sapore insipido proprio dell’edilizia.