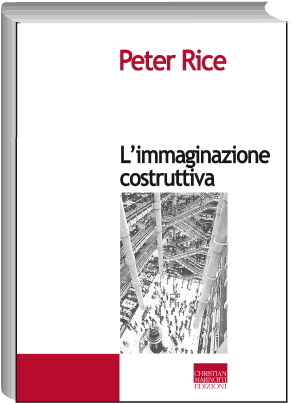Ma noi italiani da che parte stiamo? Per decenni è stata nettissima la frontiera tra un nord acciaio e vetro e un sud murario e tradizionalista (Italia, Spagna, Portogallo). Negli ultimi anni tuttavia il fronte meridionale si sfalda, perché nella penisola iberica compaiono opere che potrebbero tranquillamente essere sottoscritte da giovani architetti olandesi o svizzeri. Adesso, forse, anche il paese più conservatore e renitente al cambiamento cede al dominio tecnologico e abbraccia la contemporaneità. Una sintesi emblematica del processo in atto la dobbiamo a Maria Vittoria Capitanucci (Milano. Le nuove architetture, Skira 2012): Milano è un grande cantiere aperto e gli studi italiani, a stretto confronto con le firme internazionali, si dimostrano molto ben attrezzati; e il terreno dellemancipazione è la tecnologia. Cino Zucchi, Italo Rota, Piuarch, Stefano Boeri, Barreca & La Varra, Vudafieri Saverino, Mario Cucinella gareggiano ad armi pari con Herzog & De Meuron, Rem Koolhaas, David Chipperfield, Zaha Hadid, Daniel Libeskind, Arquitectonica e, come valore aggiunto, interpretano e rinnovano la nostra specifica cultura del progetto urbano. Facciate doppie e triple, schermi high-tech e pareti naturali, pannelli e sistemi prefabbricati di ogni genere manifestano una dimensione industriale che sembra destinata a prevalere e a oscurare la verità tettonica della costruzione. Una contrapposizione che trova un esempio lampante nei due grattacieli in costruzione nel Business Park dellEur, a Roma, gemelli diversissimi disegnati luno da Franco Purini (versione tettonica) e laltro dallo studio Transit (versione tecnodigitale). Due polarità opposte, un problema critico su cui ragiona Valerio Paolo Mosco che sviluppa lidea di Kenneth Frampton per cui alla radice dellarchitettura cè, e ci deve essere, la tettonica (Tettonica e architettura: poetica della forma architettonica nel XIX e XX secolo, Skira 1999). Il titolo del libro di Mosco, Nuda architettura (Skira, 2012), ha solleticato in molti lidea che finalmente si tornasse a discutere la dimensione erotica dellarchitettura, già ben presente in Adolf Loos e Le Corbusier e oggi confinata alle scenografie dei nuovi centri benessere. Invece Mosco colleziona architetture ridotte allosso, primitive, elementari, diagrammatiche, dove la struttura definisce forma e carattere delledificio. Daltronde, come scrive Paolo DAngelo nel suo Ars est celare artem. Da Aristotele a Duchamp (Quodlibet, 2005), «se anche lassenza di ornamento fa ornamento, se è possibile pensare un ornamento non apparente, non cè possibilità di raggiungere un grado zero, un non-ornato: la semplicità può essere un vezzo, la naturalezza un artificio».
E la sostenibilità? Possiamo prescindere dalla parete ventilata? Il ponte termico non è più un problema? Lardua sentenza è demandata ai posteri ma intanto risulta chiaro che la partita sullarchitettura del futuro prossimo si gioca tutta sul terreno della tecnologia. Questione affrontata, per esempio, da Ingrid Paoletti e Paola Tardini, giovani architette milanesi che scrivono direttamente in inglese e che, con le riflessioni e gli esempi del loro Mass Innovation. Emerging Technologies in Construction (Maggioli, 2011), forniscono un aggiornato repertorio sullevoluzione e sulle prospettive future della ricerca applicata.
Post Scriptum: miti di ieri e di domani. Peter Rice moriva nel 1992, a soli 57 anni, per un tumore al cervello. Ingegnere capo di Ove Arup, socio di Renzo Piano, credo che Rice sia stato la figura più influente dellarchitettura degli anni settanta e ottanta. È il suo incredibile genio costruttivo che ha dato forma allOpera House di Sydney, al Centre Pompidou, alla sede dei Lloyds a Londra, al museo de Menil, al nuovo Louvre e agli aeroporti di Kansai e Stansted, ed è a lui che dobbiamo linvenzione del vetro strutturale (Peter Rice, Hugh Dutton, Le verre structurel, Editions du Moniteur, 1990) che ha generato molte performance deccezione, come le serre del Museo della scienza alla Villette e il primo edificio importante di Odile Decq e Benoit Cornette. Il ricordo di Rice vive nelle sue opere che sono però spesso rubricate sotto la figura dominante dellarchistar che le ha firmate (Jørn Utzon, Renzo Piano, Richard Rogers, Norman Foster), e per riconoscere il suo lavoro ci soccorre un libro prezioso, An Engineer Imagines (Ellipsis, 1996), in cui lo stesso Rice, alle prese con la malattia a cui non potrà sopravvivere, mescola riflessioni e memorie in una autobiografia, davvero molto scientifica, di grandissimo interesse. Oggi il libro è in italiano (Limmaginazione costruttiva, Christian Marinotti, 2012, traduzione a cura di Attilio Pizzigoni) e si propone come una delle testimonianze dirette più interessanti, sul rapporto tra architettura e tecnologia, degli ultimi decenni.
La tecnologia incanta