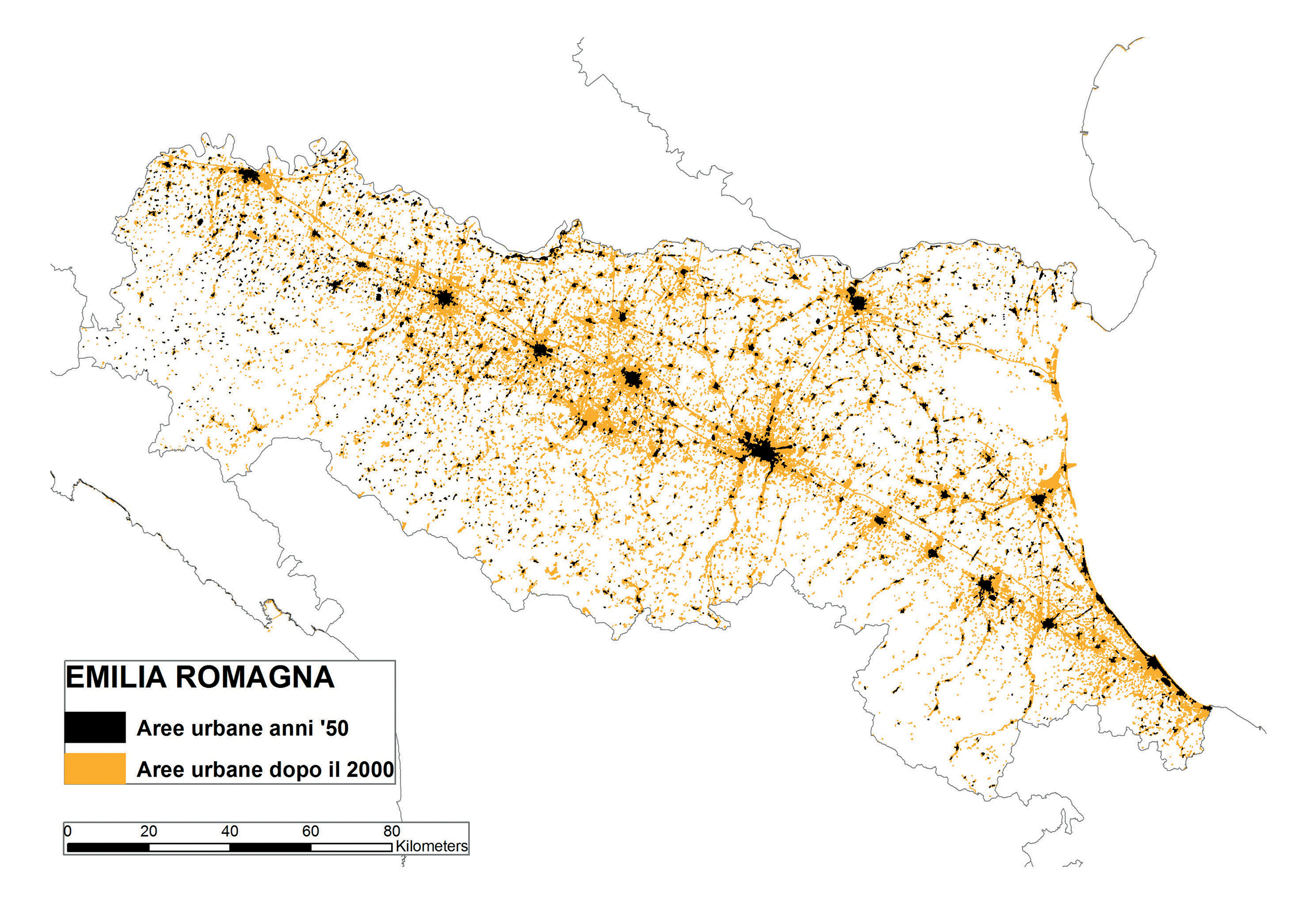Ècertamente positivo che, come Arturo Lanzani segnala nel numero scorso di questo Giornale, negli ultimi mesi molti studiosi abbiano «sottolineato lurgenza di fermare o almeno rallentare la trasformazione di suolo agricolo e naturale in suolo urbanizzato». Cè indubbiamente da compiacersene soprattutto da parte di chi, almeno dalla seconda metà degli anni novanta, e compiutamente nel 2005 con la prima edizione della «scuola di Eddyburg» (voglio ricordare tra gli altri Maria Cristina Gibelli, Mauro Baioni, Fabrizio Bottini, Vezio De Lucia, Georg Frisch, Antonio di Gennaro), evidenziava questo come un tema di rilevanza fondamentale, ma si sentiva allora circondato da un silenzio assordante (Gibelli e Salzano, No Sprawl, Alinea, 2006). Sentiva cioè di studiare e proporre in un contesto culturale (e politico-amministrativo), nel quale la «diffusione urbana», o la «città diffusa», o la «città infinita» sembravano fenomeni da analizzare non per contrastarli, ma per scoprire in essi una nuova occasione di sperimentazione di pratiche «innovative» di disegno urbano. Non per contrastare il fenomeno dunque, ma per accompagnarlo, riprogettarne le forme, integrarne i contenuti, arricchirne il significato, accrescerne la bellezza (con rotondi alberelli e magari con nuove più massicce costruzioni). Bisognerebbe domandarsi a che cosa è dovuta la «recente» consapevolezza maturata nel milieu culturale specialistico sulla necessità dintervenire con urgenza per fermare il consumo di suolo agricolo e naturale. Non certo a una sia pur tardiva presa di coscienza da parte della politica e dellamministrazione. E neppure a un vigoroso allarme sollevato dalla cultura urbanistica ufficiale: quella dellaccademia e delle istituzioni culturali, che ha continuato a preoccuparsi più di mitigare e correggere il fenomeno (e insomma di accompagnarlo) che di denunciarlo e di suggerire gli strumenti tecnici per contrastarlo, dopo averne compreso e svelato le radici.
Quali sono le radici del fenomeno, a guardarlo dal campo visuale dellurbanista? Almeno tre: il ruolo assolutamente dominante della rendita immobiliare (dellaccrescimento del valore della rendita fondiaria a causa delle aspettative di urbanizzazione dei suoli e di nuove forme/aree su cui generarla); labbandono delle politiche di edilizia abitativa programmate negli anni sessanta e settanta; il discredito nel quale è stata gettata la cosiddetta «urbanistica autoritativa».
Se si volessero sviluppare le proposte generosamente avanzate da Lanzani occorrerebbe partire da una riflessione su perché e come quelle tre questioni si siano manifestate (e siano anzi diventate devastanti) nel ventennio passato. Certo la riflessione dovrebbe tener conto del quadro più complessivo: che è quello dellegemonia dellideologia neoliberista (a cominciare dalla martellante predica del primato del privato sul pubblico, del mercato sullo stato, delleconomia sulla politica), della sua diffusione nelle pratiche di governo del territorio e, last but not least, della mutazione del sistema economico in quello che è stato definito Finanzcapitalismo (Luciano Gallino, Einaudi, 2011).
Su eddyburg.it e nelle diverse edizioni della sua scuola estiva di pianificazione, cerchiamo costantemente di fornire materiali, non troppo specialistici, di conoscenza e riflessione critica su questo più ampio quadro. Siamo infatti convinti che chiudere lattenzione degli urbanisti nello stretto recinto disciplinare-professionale li possa sospingere a diventare facilitatori di processi che sfuggono alla loro comprensione, anziché interpreti critici delle tendenze in atto e propositori di obiettivi e percorsi alternativi.
In questa sede ci limitiamo a porre un interrogativo.
Non avrà la cultura urbanistica ufficiale legittimato, consapevolmente o meno, il modello del neoliberismo?
A mio parere sì, in particolare con lappoggio, o addirittura linvenzione, di pratiche e parole dordine che hanno legittimato le ideologie da cui ha tratto alimento.
Accenno ad alcune espressioni che di queste ideologie sono il risultato operativo: l«urbanistica contrattata» (o concertata) come strumento per sottrarre il rapporto tra il pubblico (lente territoriale elettivo) e il privato (immobiliarista e/o proprietario) alla trasparenza e alla subordinazione del secondo al primo; la perequazione e la compensazione come riconoscimento, premio e incentivo alla formazione di plusvalori fondiari; i «programmi speciali» e gli «accordi di programma» in deroga alla pianificazione ordinaria; infine, i «diritti edificatori», mera invenzione degli urbanisti (Prg di Roma) e causa del riconoscimento pratico dellimpossibilità di ridurre previsioni eccessive di edificabilità dei piani urbanistici. E vorrei aggiungere anche lerrore culturale e pratico commesso con lintroduzione dellinteresse degli investitori come componente legittimamente riconoscibile nella decisione della quantità dellespansione urbana, fino a farne una componente del fabbisogno edilizio.
Lanzani ha costruito la sua proposta raccogliendo criticamente quelle che ha desunto dal dibattito in corso. (Sarebbe interessante capire perché ha trascurato di rammentare quella elaborata da Luigi Scano, contenuta nella «proposta di legge di Eddyburg» e recepita in alcuni dei disegni di legge della XIV legislatura). Non espongo qui le mie osservazioni su ciascuna delle nove proposte di Lanzani; lo farò su Eddyburg. Esse comunque non mi sembrano tali da assicurare una ragionevole (cioè drastica quanto è necessario) riduzione del consumo di suolo: sia per alcuni limiti peculiari ai singoli punti, o al modo in cui sono formulati, sia perché non affrontano tutti i versanti del problema, soffermandosi solo su quello urbanistico-edilizio. La mia ferma opinione è che non sia sufficiente combattere lespansione edilizia, ma occorra al tempo stesso difendere il territorio rurale dallurbanizzazione non strettamente necessaria. Ciò significa collegare le mille vertenze aperte per combattere il consumo di suolo urbano con quelle, aperte in tutto il mondo, per la difesa delle utilizzazioni agro-silvo-pastorali dinteresse delle popolazioni insediate, per contrastare sia lirragionevole espansione della «repellente crosta di cemento e asfalto» sia il land grabbing e la sostituzione di colture basate sul valore di scambio sul mercato internazionale anziché sul valore duso dellalimentazione sana e risparmiatrice di energia.
Affrontare congiuntamente i due versanti dellaggressione alluso del suolo consentirebbe di rafforzare quello che a me sembra uno degli aspetti decisivi della novità registrata da Lanzani: il fatto che la questione del contrasto al consumo di suolo sia diventata un tema allordine del giorno. A mio parere (e do in tal modo la mia risposta alla domanda che ponevo allinizio) la novità è emersa per effetto di due tensioni: da un lato, quella positiva espressa dalle migliaia di vertenze che, quasi in ogni regione, sono sorte per rivendicare un uso del territorio alternativo rispetto a quello che ha provocato laberrante consumo di suolo che abbiamo conosciuto; dallaltro lato, quella (a mio parere negativa: ma a volte sono un po manicheo) esercitata dagli operatori (immobiliaristi e finanzieri, professionisti, amministratori dogni ordine e grado) in vario modo legati al mondo del mattone, che avvertono che la bolla si è sgonfiata, che con la prosecuzione del consumo di suolo non si fanno più affari, e che quindi conviene invece spendersi (e guadagnare) recuperando, riqualificando, rigenerando, riprogettando. E mitigando, molcendo, migliorando.

Ve l’avevo già detto