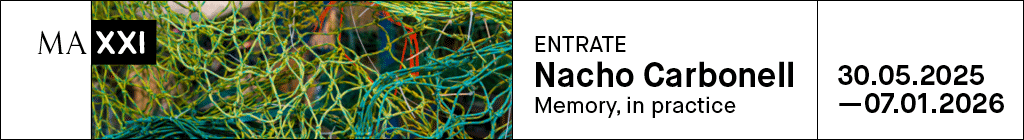Roma. Nel governo «tecnico» che guida il Paese, il neosottosegretario del Ministero per i Beni culturali, larchitetto Roberto Cecchi è senzaltro un «supertecnico». A 63 anni, ha scalato tutti i gradini della gerarchia: da funzionario a soprintendente (Calabria e Venezia) a direttore generale e infine segretario generale, al vertice del Mibac.
Secondo lei, i tentativi fatti in due legislature di portare avanti una legge sulla qualità dellarchitettura avranno possibilità di essere ripresi?
Ne abbiamo discusso nella VII Commissione Cultura, anche perché è uno dei nodi importanti che devono essere sciolti, visto che si trascina ormai da troppo tempo.
Il mondo degli architetti è in profondo conflitto con le Soprintendenze. Lei, da architetto che vi ha operato, che cosa ritiene si possa fare per tentare di riavvicinare questi due mondi che nascono dalla stessa matrice?
Il presidio alla tutela del patrimonio culturale deve essere esercitato e continuo a credere in questo ruolo delle Soprintendenze. Esse attualmente stanno giocando una partita in trincea, si difendono. Non hanno quel carattere propositivo che le connotava negli anni sessanta, ma sembrano una sorta di fanteria darresto e non è solo quello che serve. Si tratta probabilmente di riproporre un dialogo dotandoci di strumenti come una revisione importante della Carta del restauro del 1972 che dia delle certezze e risolva il problema del rapporto tra nuovo e antico, perché è lì il nodo. Se si consente al nuovo di esistere senza considerarlo un nemico, le Soprintendenze non si troverebbero in una posizione di retroguardia. Ma per fare questo devono essere legittimate.
Sono convinto che la legittimazione arriverà da voi e da un nuovo statuto in qualche misura legislativo e non solo normativo.
Oggi si sollevano spesso polveroni su questioni molto rilevanti che hanno come unico risultato quello di fermare liniziativa privata, la capacità progettuale dei singoli e di mettere gli uffici nella condizione di svolgere un ruolo meramente burocratico. Il nodo è la partnership privato-pubblico, la sua filosofia, non solo la sua pratica.
Il problema della costruzione del moderno dentro il tessuto storico è molto sentito in diverse città italiane e spesso porta a fermare i progetti, come avvenuto nel recente caso di Torino sotto la Mole Antonelliana. Ma è anche giusto pensare che si possa costruire il moderno nellantico. Forse cè una condizione culturale da rivedere.
Credo che ci siano strumenti che in questo senso vadano riletti e penso ad esempio alla Carta del restauro del 1972, costituita da un corpo principale di articoli, al quale si aggiungono quattro allegati. Lultimo riguarda i centri storici, come se lentità di questa porzione di città, che rappresenta la sommatoria di tanti episodi che potrebbero far parte del primo allegato, cioè del patrimonio culturale architettonico, fosse cosa diversa. Quindi io credo che ci sia bisogno di riconsiderare la Carta del restauro e la Carta di Venezia del 1964 che sono stati strumenti poderosi per garantire la tutela, in un momento in cui cera bisogno di fermare leccesso di demolizione dellantico, ma non per cercare di capire come mettere insieme antico e nuovo.
Partendo dal caso romano del concorso internazionale per la riqualificazione del mausoleo di Augusto e di piazza Augusto imperatore vinto nel 2006 dal gruppo guidato da Francesco Cellini, possiamo ritenere che in questi ultimi anni ci sia stato il tentativo di trasferire il concetto di paesaggio da agricolo, o extraurbano, a urbano, tentando di definire un concetto di paesaggio urbano da tutelare secondo visuali, prospettive e regole, che già esistono in altri paesi europei? Crede si possa agire in Italia con strumenti che non solo siano vincolanti ma che facilitino la gestione di un patrimonio costituito da una moltitudine di paesaggi urbani possibili?
Anche questo è un grande spunto di riflessione. Inizierei col dire che a fine anni settanta non esisteva nulla che tutelasse quello che si definisce ambiente. Allora le nostre Soprintendenze si chiamavano Soprintendenze sia per i beni ambientali che architettonici. Il concetto di paesaggio è maturato qualche anno dopo e si è capito che lambiente è una cosa e il paesaggio unaltra. Personalmente sono molto affezionato alla definizione di paesaggio come insieme di natura e storia, dove la storia è intesa come il fare, il costruire, cioè lantropizzazione. Questo è il campo entro il quale si dovrebbe muovere la riflessione, ovvero che queste due entità riconoscibili in un unico soggetto, il paesaggio, debbano essere alla fine trattate nella stessa maniera attraverso una tutela che argomenta, seppur in campi specifici diversi, il suo manifestarsi attraverso forme simili di gestione. E per tenere insieme la naturalità, il paesaggio e lintervento sullesistente si deve passare da un percorso di conoscenza.
Anche in ambito urbano?
Anche in ambito urbano e penso a Venezia: il più bel paesaggio artefatto del mondo costruito interamente sullacqua.
Un vostro dialogo maggiore con chi costruisce i piani regolatori, al di là delle regole, deve diventare uno degli elementi fondamentali.
In questo senso il Codice dei beni culturali e del paesaggio è intervenuto dando una definizione di paesaggio partendo dalla splendida riflessione della Commissione Franceschini, che ha considerato per la prima volta in modo unitario i due ambiti (paesaggio e beni culturali) che erano percepiti come entità distinte per effetto delle leggi 1089 e 1497 del 1939.
Ma lei crede che il ministero sia in grado di proporsi come interlocutore forte?
Credo di sì. Credo anche che si debba riflettere sulla struttura che ha dei vuoti, delle carenze e delle inadeguatezze, ma dobbiamo ridefinire le strutture per adeguarle in base agli obiettivi. Lo Stato dovrebbe concentrarsi sui temi di prevenzione, in particolare dal rischio, sui piani paesaggistici, ovvero su una lettura e una trasformazione del territorio condivisa, e in ultimo sulla fruizione, cioè sulluso intelligente di questo patrimonio. Riporto un dato che deve far riflettere: i musei in Italia sono poco meno di 5.000. Quelli statali, tra archeologici, artistici e storici, sono 424. La metà dei 35 milioni di visitatori lanno entra in 8 di questi musei; si arriva a coprire l85% del totale di visitatori con circa 60 musei. Questo significa che non siamo in grado di motivare lattenzione del pubblico nei confronti di un patrimonio diffuso.
Questo è anche frutto di una cultura storiografica che ha fatto del monumento, e anche dellemergenza, lunico suo oggetto dinteresse.
È assolutamente vero e noi abbiamo abbandonato da un pezzo questo tipo di visione. La tutela non è il monumento ma linsieme dei beni come artefatto, il «documento materiale avente valore di civiltà» come suggerisce la Commissione Franceschini.
Lei crede che il lavoro di censimento delle opere architettoniche degli ultimi sessantanni iniziato da Pio Baldi con il Mibac possa trovare un riscontro in azioni politiche? Le chiedo questo anche in relazione al caso di Torino dove il Palazzo del Lavoro di Pier Luigi Nervi rischia di essere profondamente trasformato dagli usi.
La legge deve interpretare un sentimento comune. Ricordo quando sono entrato in Soprintendenza che cosa significava parlare di tutela dellarchitettura contemporanea. Lidea di pensare alla torre Velasca come a un monumento da tutelare, allinizio degli anni ottanta, sembrava bizzarro, eppure nellarco di pochissimi anni la sensibilità è cambiata. Abbiamo iniziato a parlare della tutela dellopera di Giuseppe Terragni nel 1986-1987 e sembrava una cosa che non si dovesse fare, mentre oggi il «tema Terragni» è tutto sotto tutela e questo è frutto di una riflessione che è passata dalle Università, dalle Soprintendenze e dal sentir comune delle persone e ha preso rapidamente piede.
È interessante quello che dice: condividere. Ma condividere significa anche stimolare, da parte vostra, una serie di studi e momenti di confronto. Sul piano della formazione universitaria che riguarda i beni architettonici si sta pensando a una politica meno dispersiva che promuova eccellenze attraverso politiche, convenzioni, ecc?
Credo sia assolutamente auspicabile perché questo proliferare di corsi di laurea ha prodotto molti danni. Ripensarli a partire da alcune eccellenze riconosciute e condivise sarà fondamentale.
Ma quale può essere la strada, da intraprendere in un momento in cui il ministero della Pubblica istruzione sta affrontando il problema della valutazione che si attuerà in un processo di distinzione tra Università di ricerca e non, cosa molto chiara nei principi ma che manca di strategie di politica culturale. Sarebbe interessante capire se il ministero sia in grado di proporre qualcosa di più di un giusto processo di riduzione e sia in grado di ragionare considerando che noi abbiamo città come Roma o Firenze in cui si può proporre un certo tipo di politiche riguardo una certa tipologia di restauro, o Venezia dove invece si può proporre il restauro architettonico.
Su questo non cè dubbio. Ci dovrebbe essere una riflessione comune tra i due ministeri in questa direzione, anche su alcuni assetti disciplinari. Per quanto riguarda il restauro architettonico, generalmente, linsegnamento è limitato alla superficie delledificio generando uno squilibrio di conoscenza tra ciò che è la «pelle» del monumento e ciò che sta allinterno. Non è più sufficiente laureare persone in restauro che conoscano perfettamente i meccanismi di alterazione di una superficie e non abbiano una conoscenza sufficiente di ciò che sono i problemi strutturali o non siano in grado di ragionare in termini distributivi. Quale sia lo strumento da attivare presso le Università non lo so, ma potremmo guardare a esperienze positive come quella spagnola.
In un momento in cui la pubblicistica scritta sta conoscendo una drammatica crisi di produzione e di vendita, state pensando in che misura investire per far conoscere un patrimonio enorme e diffuso come quello italiano, non solo al turista ma allabitante, usando nuove tecnologie?
Si, non cè dubbio, la divulgazione se fatta bene ha il potere di entrare nella testa delle persone, però considero sempre la scuola come lelemento fondamentale della conoscenza.