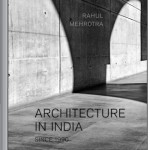Il messaggio più evidente del nuovo libro di Rahul Mehrotra, uscito pochi mesi dopo il suo insediamento a Harvard come direttore del Dipartimento di Urban Planning and Design, è che si debba diffidare di una lettura dellarchitettura indiana appiattita intorno alla riscoperta della sua identità nazionale, in opposizione a una stagione precedente di colonialismo e imposizione di modelli. Mehrotra ricorda, citando Amartya Sen, che «dobbiamo resistere a un assunto troppo spesso invocato, cioè che scopriamo la nostra identità piuttosto che sceglierla»: un suggerimento importante per capire larchitettura in India degli ultimi ventanni (il libro prende come punto di partenza la riforma per la liberalizzazione economica, avviata allinizio degli anni novanta). Le opere illustrate nel volume restituiscono, rispetto al tema dellidentità, un catalogo di prese di posizione tuttaltro che convergenti. Per rappresentare questo «paesaggio plurale» (sintitola così il lungo saggio iniziale), Mehrotra colloca idealmente i progetti in una matrice che incrocia la prospettiva «verticale» della storia della modernità indiana con quella «orizzontale» necessaria a descrivere la compresenza attuale di fenomeni diversi, spesso stridenti.
Alla prospettiva storica fanno capo alcune genealogie che non è possibile eludere se si vuole capire il panorama contemporaneo: dal ruolo di Le Corbusier a Chandigarh e non solo (portato poi avanti dal suo braccio destro Balkrishna V. Doshi), al meno noto filone wrightiano impersonato da Nari Gandhi, che porta Wright ad Ahmedabad (mai realizzati i Calico Headquarters) e rielabora la sua lezione dopo avere lavorato a Taliesin; dal filo diretto di Charles Correa con il Mit e il mondo accademico americano, coltivato fin dagli anni cinquanta, al ruolo di Ray e Charles Eames, chiamati dal governo indiano per avviare un programma educativo nazionale dedicato al design. Ancor più significativa appare la storia di Laurie Baker, che raggiunge negli anni quaranta unIndia ancora britannica, lavora dapprima come medico, entra in contatto con Mahatma Gandhi e infine avvia la sua attività di architetto: fonda un metodo dinterazione con lartigianato e le maestranze locali che avrebbe fatto scuola, attuandolo in opere come lo straordinario campus di Thiruvananthapuram (1967-1992) o nella costruzione di oltre 20mila case attraverso lassociazione no profit Costford.
Percorsi come quello di Baker contribuiscono, negli anni, ad ampliare le geografie dellarchitettura indiana: solo un terzo dei 41 progetti (1990-2011) selezionati da Mehrotra si trovano nelle quattro città principali di New Delhi (5), Ahmedabad (4), Mumbai (3), Calcutta (1). Acquisiscono importanza luoghi diversi: da Bangalore (dove nel clima di grande sviluppo sono ben sei i progetti segnalati), ad Auroville, la comunità ideale fondata dal nulla nel 1968 secondo il masterplan di Roger Anger. Ma la vicenda di Baker introduce anche la più significativa delle quattro categorie critiche compresenti nel panorama attuale, con cui Mehrotra affronta la prospettiva «orizzontale» della sua matrice: affiancandosi alle «Pratiche globali», alle «Manifestazioni regionali» e al «Contro-modernismo», sono infatti le «Pratiche alternative» a qualificare maggiormente larchitettura indiana, per la loro capacità di riconoscere la presenza di voci subalterne o dinterpretare le esigenze di ogni frangia della società. A Mehrotra va il merito di dare spazio a tali pratiche, che si esplicano soprattutto a livello urbano facendo incontrare larchitettura e il planning con la sociologia, lantropologia, leconomia (si pensi, solo a Mumbai, ad associazioni come Udri e Sparc, Pukar e Urbz). Il libro, tuttavia, non va realmente a fondo nella loro esplorazione perché fatica a svincolarsi, nella descrizione delle architetture, da un criterio che privilegia la produzione dimmagini: è ben più complesso trovare registri descrittivi per fenomeni architettonici meno appariscenti ma pervasivi, informali ma molto sofisticati.
Nel periodo coloniale e nei primi anni dallindipendenza (1947) convivevano in India mondi diversissimi, per ceto e ambizioni, però separati in luoghi diversi. Nelle immagini degli slum affiancati a moderni grattacieli così come nella compresenza stridente dinnovazione e conservatorismo, appare evidente come oggi tutto invece coesista: tanto che «lespressione di società umane capaci di convivere con le differenze […] è ciò che rende straordinario lesperimento indiano», rendendolo radicalmente diverso rispetto a quello cinese o mediorientale.
Cè un paese dove coesistono slum e grattacieli. Ecco come